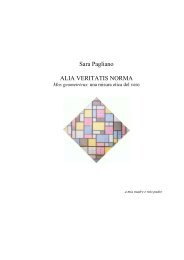kant_il pensiero_della_bellezza.pdf - Lettere e Filosofia
kant_il pensiero_della_bellezza.pdf - Lettere e Filosofia
kant_il pensiero_della_bellezza.pdf - Lettere e Filosofia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
70<br />
L’estetica in Kant si è separata in una teoria del sensib<strong>il</strong>e (e <strong>della</strong> sua conformità<br />
all’esperienza possib<strong>il</strong>e) e in una teoria del bello (<strong>il</strong> cui oggetto è la realtà del reale: la<br />
sua contingenza, singolarità, effettualità). 299 Mentre le categorie sono pronte a accogliere<br />
e oggettivare <strong>il</strong> particolare, secondo le proprie condizioni, come casus datae<br />
legis (qui, dunque, le condizioni a priori eccedono l’empirico), nel caso <strong>della</strong> <strong>bellezza</strong>,<br />
invece, empirico e trascendentale si identificano e le condizioni dell’esperienza<br />
reale coincidono col condizionato, la legge col caso singolo. 300 La CdG apre lo spazio<br />
‘paradossale di un empirismo trascendentale capace di superare le condizioni di possib<strong>il</strong>ità<br />
dell’oggetto verso la sua genesi reale. La singolarità è la propria condizione<br />
stessa. Realtà e condizione sono uno. Dunque, la CdG è <strong>il</strong> momento in cui Kant più si<br />
avvicina al superamento del punto di vista di un mero condizionamento, aprendo uno<br />
spazio di riflessione che dalle condizioni di possib<strong>il</strong>ità dell’oggetto porti al punto di<br />
vista di una vera genesi. 301<br />
C’è, dunque, in Kant un’estetica delle condizioni di possib<strong>il</strong>ità dell’esperienza, che<br />
è un estetica dell’esempio e <strong>della</strong> particolarità (e si esaurisce nella determinazione); e<br />
c’è un’estetica del reale come condizione <strong>della</strong> propria stessa effettualità, che è<br />
un’estetica dell’esemplarità e <strong>della</strong> singolarità (che esige <strong>il</strong> passaggio nella riflessione).<br />
L’una si riferisce al reale attraverso <strong>il</strong> possib<strong>il</strong>e; l’altra pensa <strong>il</strong> possib<strong>il</strong>e a partire<br />
dal virtuale. Il possib<strong>il</strong>e riguarda <strong>il</strong> reale che ne è la limitazione. Il virtuale riguarda<br />
l’attuale e <strong>il</strong> loro rapporto è di ‘creazione’. Scrive Deleuze: “L’Idea, così definita,<br />
non dispone di alcuna attualità, ma è virtualità pura”. 302 Se l’Idea è solo ‘regolativa’<br />
nei confronti del mondo fenomenico oggettivo (cioè, del possib<strong>il</strong>e delimitato dal reale),<br />
essa è però intrinseca alla realtà come insieme di virtuale e di attuale. Kant denuncia<br />
l’<strong>il</strong>lusione implicita nella sostanzializzazione delle idee, ma è anche <strong>il</strong> primo a<br />
vedere l’idea come orizzonte e come problema che inscrivono l’infinito nel mondo.<br />
L’idea <strong>kant</strong>iana accenna a quel carattere problematico dell’essere che, sia pure in<br />
modi diversi, sia Merleau-Ponty che Deleuze pongono al centro <strong>della</strong> loro riflessione.<br />
303 [c’è solo qui, ma r<strong>il</strong>eggere] Per Merleau-Ponty l'interrogativo non è un "modo<br />
derivato" dall'indicativo. Esso è "forse <strong>il</strong> modo proprio del nostro rapporto con l'Essere".<br />
304 L'essere contiene la domanda nelle sue pieghe e nelle sue differenziazioni: "<strong>il</strong><br />
299 Deleuze torna più volte su questa dualité lacérante dell’estetica (per es. in Differenza e ripeti-<br />
zione e Logica del senso).<br />
300 Cfr. Deleuze 1997, p. 117.<br />
301 Cfr. su questo, e sulle critiche a Kant di post-<strong>kant</strong>iani come Maïmon, Differenza e ripetizione,<br />
cit., p. 221 sgg. Deleuze interpreta come un momento decisivo di questa problematica anche la f<strong>il</strong>osofia<br />
di Nietzsche: la volontà di potenza non va intesa meramente come forza che sottostà alla forma,<br />
ma anche come “elemento differenziale” capace di dar luogo, come “principio di differenza e<br />
di differenziazione interna”, a una genesi e a una produzione dell’oggetto, di superare cioè <strong>il</strong> <strong>kant</strong>ismo<br />
delle mere condizioni di possib<strong>il</strong>ità (cfr. Nietzsche e la f<strong>il</strong>osofia, Einaudi, Torino 1992, pp. 77<br />
- 78).<br />
302 Deleuze 1997, p 444.<br />
303 Cfr. Gambazzi 1999, cap. 19.<br />
304 Merleau-Ponty 1993, p. 146.