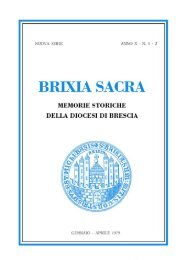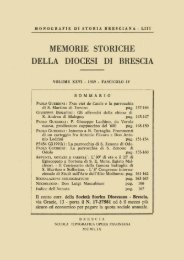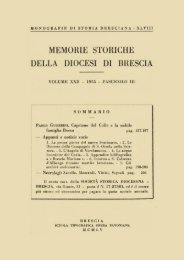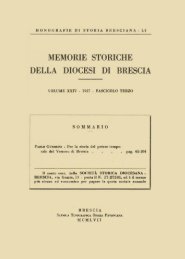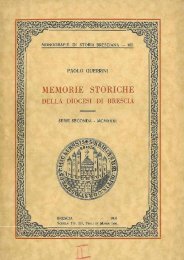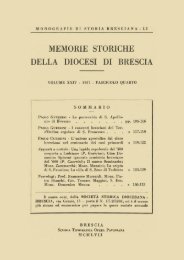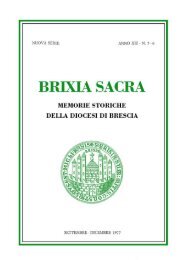You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
del Carmine, l'opera bresciana più riccesca dello Zanetti, seguirebbe le altre due<br />
pale più legate al clima locale (quindi dopo il 1741 e prima del 1747, anno in cui<br />
la ricorda, senza datarla, il Maccarinelli) secondo un'ipotesi temporale che implicitamente<br />
presume un progressivo sganciamento dalla cultura bresciana per una<br />
sempre più stretta adesione al pittore veneziano.<br />
Invece, e non solo per alcune affinità tematiche, è proprio la S. Cecilia l'opera<br />
più prossima ai dipinti veronesi con i quali condivide la «tessitura di colori<br />
solari» (15) e le tipologie strettamente veronesiano-riccesche anche se ormai sulla<br />
base di una maggiore levigatezza formale e accademica riconducibile sì, come<br />
vuole Passamani, agli influssi locali (16) - e in questo senso va in ogni caso datata<br />
dopo i dipinti veronesi che nulla tengono della cultura bresciana - ma che<br />
dipende anche dalla accurata preparazione della tela, mentre le tavole di Verona<br />
sono state lavorate senza imprimitura direttamente sul legno, appena sporcato con<br />
un po' di bolo.<br />
E' dunque evidente che il pittore sulle Lagune e nel Veneto, dimenticati i<br />
primi insegnamenti paglieschi, si muove totalmente nell'ambito culturale veneziano,<br />
mentre a Brescia si rieducherà gradualmente alla cultura locale fino ad<br />
assumere, soprattutto nella pala di S. Zeno, una posizione per molti versi affine<br />
a quella dell'esasperato e antiaccademico Fali di S. Francesco (17).<br />
Purtroppo non è possibile, ora come ora, tentare di spiegare questa presenza<br />
tutto sommato anomala e, a quanto pare, senza seguito del bresciano a Verona,<br />
né è tanto meno possibile indicare una qualche traccia che conduca ai committenti.<br />
Tuttavia non è forse senza significato che il monumentale altar maggiore<br />
degli Scalzi - esempio, io credo unico, nel Veronese - sia concordemente indicato,<br />
dal Lanceni (18) in poi, come opera di Antonio Corbarelli decorata per la<br />
parte plastica (due statue laterali con S. Teresa e S. Giovanni della Croce, Puttini,<br />
Angeli e Virtù) da Angelo (sic) Calegari.<br />
Anche se Angelo Calegari non risulta esistere (forse un semplice errore di<br />
stampa - non registrato. ma non è certo l'unico caso. nemmeno negli Errata<br />
corrige in fondo al volume del Lanceni -- da correggere evidentemente con Santo<br />
il Vecchio (19) dal momento che l'altare è da credere su per giù contemporaneo<br />
alla pala del Balestra del 1697). tuttavia il Lanceni (1659-1735) •. implicato direttamente<br />
negli ambienti artistici veronesi non solo come conoscitore e autore di un<br />
fondamentale catastico delle chiese cittadine e di provincia ma anche come pit-<br />
(15)<br />
(16)<br />
(17)<br />
(18)<br />
(19)<br />
B. PASSAMANI, op. dt., p. 101.<br />
B. PASSAMANI, op. cit., p. 101.<br />
Per il quale si veda: L. ANELLI - E.M. auzzo, op. cit., pp. 63-67. E.M. auzzo,<br />
La pittura ... , op. cit., p. 185.<br />
a.B. LANCENI. op. cit., p. 157.<br />
Santo il Veéchio è l'unico della famiglia già attivo negli ultimi anni del Seicento: in<br />
ogni caso il CARBONI (op. cit., p. 23) cita, senza specificare, suoi lavori per Verona<br />
(forse questi?).<br />
19