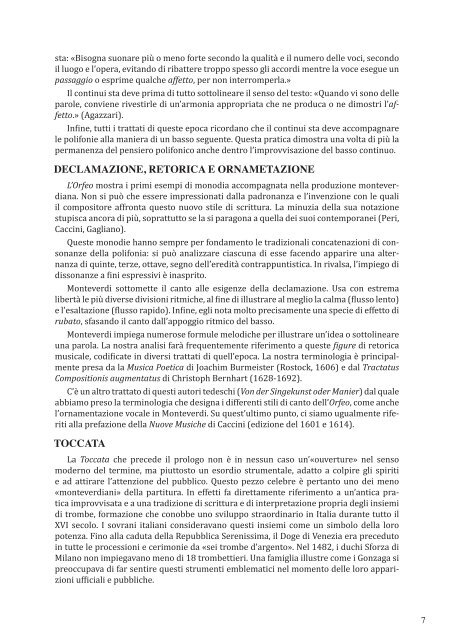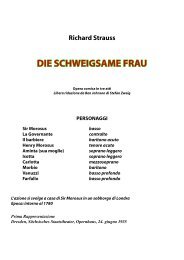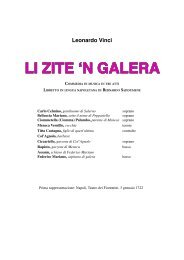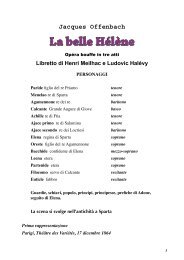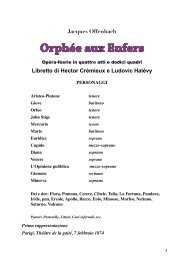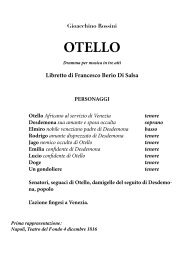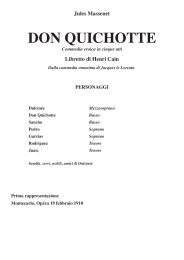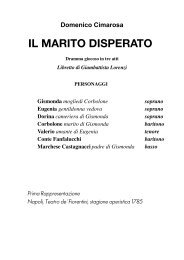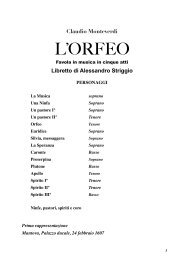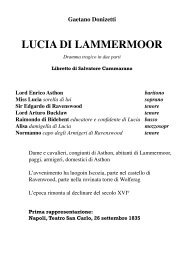COMMENTARIO MUSICALE DELL'ORFEO di Denis Morrier
COMMENTARIO MUSICALE DELL'ORFEO di Denis Morrier
COMMENTARIO MUSICALE DELL'ORFEO di Denis Morrier
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sta: «Bisogna suonare più o meno forte secondo la qualità e il numero delle voci, secondo<br />
il luogo e l’opera, evitando <strong>di</strong> ribattere troppo spesso gli accor<strong>di</strong> mentre la voce esegue un<br />
passaggio o esprime qualche affetto, per non interromperla.»<br />
Il continui sta deve prima <strong>di</strong> tutto sottolineare il senso del testo: «Quando vi sono delle<br />
parole, conviene rivestirle <strong>di</strong> un’armonia appropriata che ne produca o ne <strong>di</strong>mostri l’affetto.»<br />
(Agazzari).<br />
Infine, tutti i trattati <strong>di</strong> queste epoca ricordano che il continui sta deve accompagnare<br />
le polifonie alla maniera <strong>di</strong> un basso seguente. Questa pratica <strong>di</strong>mostra una volta <strong>di</strong> più la<br />
permanenza del pensiero polifonico anche dentro l’improvvisazione del basso continuo.<br />
DECLAMAZIONE, RETORICA E ORNAMETAZIONE<br />
L’Orfeo mostra i primi esempi <strong>di</strong> mono<strong>di</strong>a accompagnata nella produzione montever<strong>di</strong>ana.<br />
Non si può che essere impressionati dalla padronanza e l’invenzione con le quali<br />
il compositore affronta questo nuovo stile <strong>di</strong> scrittura. La minuzia della sua notazione<br />
stupisca ancora <strong>di</strong> più, soprattutto se la si paragona a quella dei suoi contemporanei (Peri,<br />
Caccini, Gagliano).<br />
Queste mono<strong>di</strong>e hanno sempre per fondamento le tra<strong>di</strong>zionali concatenazioni <strong>di</strong> consonanze<br />
della polifonia: si può analizzare ciascuna <strong>di</strong> esse facendo apparire una alternanza<br />
<strong>di</strong> quinte, terze, ottave, segno dell’ere<strong>di</strong>tà contrappuntistica. In rivalsa, l’impiego <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ssonanze a fini espressivi è inasprito.<br />
Montever<strong>di</strong> sottomette il canto alle esigenze della declamazione. Usa con estrema<br />
libertà le più <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>visioni ritmiche, al fine <strong>di</strong> illustrare al meglio la calma (flusso lento)<br />
e l’esaltazione (flusso rapido). Infine, egli nota molto precisamente una specie <strong>di</strong> effetto <strong>di</strong><br />
rubato, sfasando il canto dall’appoggio ritmico del basso.<br />
Montever<strong>di</strong> impiega numerose formule melo<strong>di</strong>che per illustrare un’idea o sottolineare<br />
una parola. La nostra analisi farà frequentemente riferimento a queste figure <strong>di</strong> retorica<br />
musicale, co<strong>di</strong>ficate in <strong>di</strong>versi trattati <strong>di</strong> quell’epoca. La nostra terminologia è principalmente<br />
presa da la Musica Poetica <strong>di</strong> Joachim Burmeister (Rostock, 1606) e dal Tractatus<br />
Compositionis augmentatus <strong>di</strong> Christoph Bernhart (1628-1692).<br />
C’è un altro trattato <strong>di</strong> questi autori tedeschi (Von der Singekunst oder Manier) dal quale<br />
abbiamo preso la terminologia che designa i <strong>di</strong>fferenti stili <strong>di</strong> canto dell’Orfeo, come anche<br />
l’ornamentazione vocale in Montever<strong>di</strong>. Su quest’ultimo punto, ci siamo ugualmente riferiti<br />
alla prefazione della Nuove Musiche <strong>di</strong> Caccini (e<strong>di</strong>zione del 1601 e 1614).<br />
TOCCATA<br />
La Toccata che precede il prologo non è in nessun caso un’«ouverture» nel senso<br />
moderno del termine, ma piuttosto un esor<strong>di</strong>o strumentale, adatto a colpire gli spiriti<br />
e ad attirare l’attenzione del pubblico. Questo pezzo celebre è pertanto uno dei meno<br />
«montever<strong>di</strong>ani» della partitura. In effetti fa <strong>di</strong>rettamente riferimento a un’antica pratica<br />
improvvisata e a una tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> scrittura e <strong>di</strong> interpretazione propria degli insiemi<br />
<strong>di</strong> trombe, formazione che conobbe uno sviluppo straor<strong>di</strong>nario in Italia durante tutto il<br />
XVI secolo. I sovrani italiani consideravano questi insiemi come un simbolo della loro<br />
potenza. Fino alla caduta della Repubblica Serenissima, il Doge <strong>di</strong> Venezia era preceduto<br />
in tutte le processioni e cerimonie da «sei trombe d’argento». Nel 1482, i duchi Sforza <strong>di</strong><br />
Milano non impiegavano meno <strong>di</strong> 18 trombettieri. Una famiglia illustre come i Gonzaga si<br />
preoccupava <strong>di</strong> far sentire questi strumenti emblematici nel momento delle loro apparizioni<br />
ufficiali e pubbliche.<br />
7