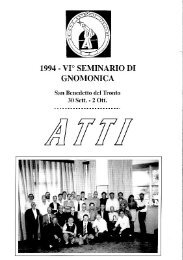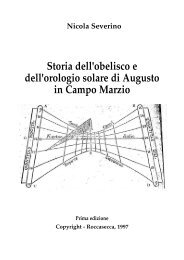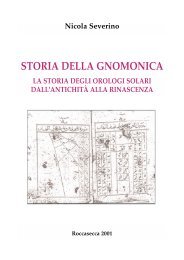IL LIBRO DEGLI ASTROLABI - Nicola Severino
IL LIBRO DEGLI ASTROLABI - Nicola Severino
IL LIBRO DEGLI ASTROLABI - Nicola Severino
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
per trovare la posizione del Sole, della Luna, e<br />
degli altri astri, e per seguire il moto degli stessi;<br />
era questa una specie di sfera armillare, perchè<br />
composta da più circoli, aveva i suoi traguardi, che<br />
allora facevan le veci di telescopio, e si chiamava<br />
astrolabio (astrolabon), parola che deriva da<br />
astron (astrum) e lambanw (consequor).<br />
Nell'Enciclopedia metodica (di Diderot,<br />
D'Alembert - nda), all'articolo "Astrolabe"; nel<br />
tomo I, pag.567 della "Storia dell'Astronomia" di<br />
Bailly, e nel tomo I, pag. 306 della "Storia della<br />
Matematica" di Montucla, si riporta che la macchina,<br />
in seguito chiamata Astrolabio, è proprio quella<br />
descritta da Tolomeo nel suo Almagesto...".<br />
Naturalmente, Settele si oppone a queste<br />
asserzioni rilevando che la "macchina" di Tolomeo<br />
non era altro che l'armilla meridiana (descritta anche<br />
da Proclo in Hypotyposis astronomicarum positionum),<br />
un anello di metallo diviso in 360°, con<br />
un'altro circolo concentrico mobile con due pinnule,<br />
infisso su di un pilastro e posto perpendicolarmente<br />
al piano del meridiano che serviva a<br />
determinare l'obliquità dell'eclittica e, in genere, a<br />
misurare l'altezza degli astri.<br />
"Non credo - scrive il Settele - che questa macchina<br />
potesse dare origine a quella che poi, per antonomasia,<br />
fu chiamata Astrolabio, perchè l'Astrolabio,<br />
nei tempi posteriori, era propriamente la<br />
proiezione della sfera sul piano, come può rilevarsi<br />
dai diversi passi della lettera di Sinesio a Poenio<br />
sul Dono dell'astrolabio".<br />
A questo proposito si deve notare che la lettera di<br />
Sinesio a Peonio (circa 410 d.C.), ritenuta da certi<br />
autori moderni responsabile di aver tratto in<br />
inganno gli studiosi del passato che hanno<br />
attribuito, sulla base di questa, l'invenzione dell'astrolabio<br />
a Tolomeo o addirittura ad Ipparco,<br />
non aveva ingannato invece il Settele che pure<br />
scriveva all'inizio dell'Ottocento.<br />
Secondo Settele, altri autori sostenevano che<br />
Vitruvio nominò nella sua Architettura (Lib. 9,<br />
cap.7), una parola che avrebbe dovuto indicare un<br />
astrolabio: "...Quorum inventa secuti, syderum et<br />
occasus, et ortus, tempestatumque significatus,<br />
Eudoxus, Eudemon, Callixtus, Melo, Philippus,<br />
Hipparchus, Aratus, caeterique ex Astrologia, parapegmatum<br />
disciplinis invenerunt, et eas posterius<br />
explicatas reliquerunt...". In cui la parola "parapegmatum",<br />
ha dato filo da torcere agli interpreti nelle<br />
varie epoche, ed il Settele espone la questione così:<br />
"... Il Baldi, appresso il Filandro ed il Barbaro dice:<br />
certè de astrolabiis, dioptris, armillis, radiis, et<br />
coeteris ejuscemodi intelligi debere".<br />
Il Perrault nella nota al detto passo di Vitruvio<br />
vuole che la frase "parapegmatum disciplinis" debba<br />
intendersi per "l'uso degli strumenti che servono nelle<br />
osservazioni astronomiche". Mentre Claudio<br />
Salmasio, crede che "parapegma" stia ad indicare<br />
una lastra di rame sulla quale vi sono incise una<br />
serie di linee relative al percorso delle stelle sulla<br />
sfera celeste ed altre indicazioni astronomiche. In<br />
questo caso la parola "parapegma" sarebbe usata<br />
per discernere propriamente gli strumenti scientifici<br />
(parapegmi) per lo studio del cielo. Il Settele<br />
approva questa tesi in quanto il termine, la cui<br />
origine è evidentemente greca, significa letteralmente<br />
"una cosa inchiodata, e fermata", che porta<br />
a pensare all'"unione di più pezzi", come possono<br />
essere appunto le lastre di rame simili agli strumenti<br />
per l'osservazione astronomica, o proprio le<br />
lastre che compongono un astrolabio del tipo classico.<br />
Infatti, Berardo Galiani, traduce<br />
"Parapegmatum disciplinis" in "colla scienza degli<br />
Astrolabii", senza che abbia dimostrato con ciò la<br />
verità della propria conclusione.<br />
Altri autori, sebbene non del tutto apertamente,<br />
ma tacitamente, evitano di identificare il<br />
"Parapegma" con l'Astrolabio. Così, Dionisio<br />
Petavio (Auctar. L.2, Cap.8) chiama "parapegmata"<br />
quelle tabelle sulle quali venivano registrate le<br />
osservazioni celesti e meteorologiche. Francesco<br />
Bianchini (de Kalend. et cyclo Caesaris) dà al calendario<br />
cesariano anche il nome di "parapegma".<br />
Montucla, dice che Democrito scrisse delle effemeridi<br />
chiamate "parapegmi", come fecero successivamente<br />
Eudosso, Ipparco e Tolomeo. Premesse<br />
le ipotesi a favore e contro l'identificazione della<br />
parola "parapegma" in "astrolabio", Settele espone<br />
il suo pensiero:<br />
"Il Filandro e il Vossio ne derivano l'etimologia dal<br />
verbo greco paraphgniw "idest adpingo, sive<br />
affigo": era dunque il parapegma una macchina<br />
risultante da più pezzi riuniti e sovrapposti l'uno<br />
all'altro. Gli antichi, quindi, chiamavano con<br />
"parapegmata", o "pegma", le macchine propriamente<br />
dette, e non le semplici lamine su cui erano<br />
incise le osservazioni. Difatti, Teone chiama<br />
pinacaz queste lastre e non "parapegmata". Il<br />
"Siderum et occasus et ortus", per Vitruvio poteva<br />
ottenersi appunto con delle macchine che facili-<br />
<strong>Nicola</strong> <strong>Severino</strong> Il Libro degli Astrolabi<br />
6