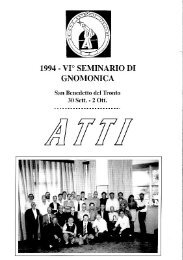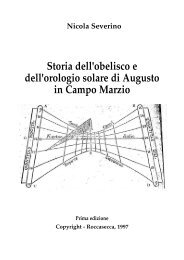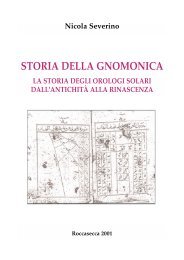IL LIBRO DEGLI ASTROLABI - Nicola Severino
IL LIBRO DEGLI ASTROLABI - Nicola Severino
IL LIBRO DEGLI ASTROLABI - Nicola Severino
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
conseguenza i gradi dello zodiaco che corrispondono<br />
a queste tappe. Piazzato quindi il grado dello<br />
zodiaco ove si trova il sole all'inizio della malattia<br />
sulla linea del mezzodì (initium morbi), si hanno<br />
direttamente i gradi dello zodiaco che si trovano<br />
su ciascuno degli "angoli" del timpano; la stessa<br />
operazione può farsi con la luna e le "case lunari"<br />
Conclusione<br />
La rinascita dell'astronomia nell'Europa del secoli<br />
XII e XIII contribuisce alla diffusione di uno strumento<br />
preciso e versatile come l'astrolabio. Dalla<br />
redazione di testi insicuri, in cui compaiono<br />
grossolani errori teorici e di costruzione, si arriva<br />
piano piano a sviluppare, durante il tardo periodo<br />
universitario, delle tecniche perfette di realizzazione<br />
grazie anche allo sviluppo delle nuove tecnologie<br />
artigiane.<br />
A questo proposito è importante sottolineare la<br />
grande difficoltà che si incontra nella classificazione<br />
e catalogazione degli astrolabi dall'anno<br />
Mille in poi, tenendo conto dei diversi particolari<br />
costruttivi che caratterizzavano le varie scuole<br />
europee. In più, è da considerare che pochissimi<br />
sono i pezzi firmati. Per esempio, non ci è giunto<br />
nessun astrolabio gotico (cioè realizzato in stile<br />
gotico) firmato - come fa rilevare Tullio Tomba in<br />
un suo articolo di qualche decennio fa 17 27<br />
-, pochissimi,<br />
uno o due, recano un monogramma quasi<br />
indecifrabile e in più ci sono le possibili modifiche<br />
avvenute nelle posizioni degli indici delle stelle, e<br />
questo rende quasi impossibile la loro datazione<br />
usuale col calcolo delle coordinate astronomiche.<br />
Dalla descrizione di Tomba dei due astrolabi latini<br />
risalenti al XIV secolo, possiamo notare i miglioramenti<br />
costruttivi apportati dagli artigiani e di cui<br />
faranno tesoro gli astrolabisti della Rinascenza:<br />
"...l'elemento degli archi trilobati è comune a quasi tutti<br />
gli strumenti delle prime scuole d'Occidente, ma qui è<br />
di una raffinatezza e di un equilibrio che troviamo ben<br />
di rado in altri esemplari insieme ad una tecnica di real-<br />
izzazione perfetta, degna del miglior professionismo...".<br />
Questi particolari, insieme con quello della sistemazione<br />
del lembo sulla madre per mezzo di<br />
spine cilindriche ribattute, si ritrovano sugli astrolabi<br />
dell'epoca, ed anche più antichi, come quello<br />
islamico del X secolo conservato nella collezione<br />
Lewis Evans di Oxford, che reca un lembo distinto<br />
dalla madre, oppure l'astrolabio gotico della<br />
collezione Michel, e l'ispano moresco della raccolta<br />
Billmeier, il gotico n° 175 della stessa ed altri 18 .<br />
Inoltre, tali particolari non si riscontrano con facilità<br />
nei testi medievali e pare che l'unico trattato che<br />
ne parli sia quello di Roberto Anglico nel capitolo<br />
"De inscriptione matris Rotule et Limbi" dei suoi rari<br />
Canones de Astrolabio, stampato a Perugia nel 1480,<br />
in cui afferma che il "Limbum seu margilabrum"<br />
deve essere adeguato al numero delle "Tabulae" e<br />
ci dà la precisa sensazione che questo pezzo costituisse<br />
un elemento a sé da potersi anche sostituire<br />
se si fosse presentata l'occasione di aumentare il<br />
numero dei timpani.<br />
Anche Peregrino di Maricourt, nella Nova compositio<br />
Astrolabii particularis (Codice Vaticano Latino<br />
1332, carta 14 r.) offre particolari costruttivi interessanti<br />
trattando di due procedimenti per la<br />
costruzione della madre e del lembo, l'uso del<br />
tornio oppure l'applicazione del lembo di una "tabula"<br />
con l'antica saldatura all'argento: "Vel aliter<br />
facies tabulam fabricari super quam limbum sibi aptum<br />
cum armilla decenter composita unges (sta per coniuges)<br />
cum argento in quo..." 19 .<br />
Sembrerà strano, ma nonostante la loro popolarità<br />
ben pochi sono gli astrolabi che si conservano in<br />
Italia, più precisamente sembrano esserne in<br />
numero non superiore ad una decina. Sempre il<br />
Tomba 20 , dà la seguente collocazione: 5 astrolabi<br />
sono conservati al Museo Copernicano di Monte<br />
Mario (Roma), 3 al Museo di Storia della Scienza di<br />
Firenze, 1 all'Osservatorio Astronomico di<br />
Bologna, 1 al Museo di Venezia.<br />
Questo probabilmente dimostra, nonostante tutto,<br />
come fossero in pochi i costruttori professionisti di<br />
astrolabi e strumenti astronomici in quell'epoca tra<br />
cui vanno ricordati i poco noti Ibrahim ibn Said as-<br />
Sahli di Valencia e Muhammed Ibn Futtuh di<br />
17 Tullio Tomba, Due astrolabi latini del XIV secolo conservati a Milano, in "Physis", VIII, 1966 - Olschki Ed., Firenze<br />
18 T. Tomba, ibid. p. 298<br />
19 T. Tomba, ibid., pp. 299-300<br />
20 T. Tomba Un astrolabio del XIV secolo di probabile origine italiana, in "Physis", anno 12, 1970, Leo S. Olschki ed. , Firenze<br />
<strong>Nicola</strong> <strong>Severino</strong> Il Libro degli Astrolabi<br />
48