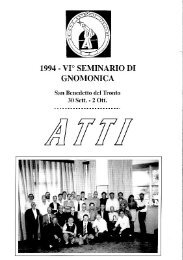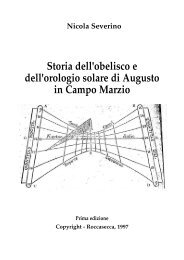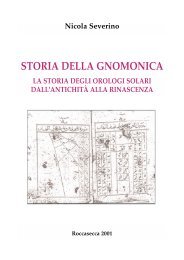IL LIBRO DEGLI ASTROLABI - Nicola Severino
IL LIBRO DEGLI ASTROLABI - Nicola Severino
IL LIBRO DEGLI ASTROLABI - Nicola Severino
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
21Il periodo Universitario<br />
Nell'anno Mille, in definitiva, manca un'adeguato<br />
monumento letterario sul quale improntare un<br />
successivo studio sull'argomento. E la causa di ciò<br />
va ricercata nell'impossibilità in cui si trovavano i<br />
primi autori cristiani di assimilare completamente<br />
la scienza araba, e quindi l'arte dell'astrolabio a<br />
partire dalle pochissime, mediocri, traduzioni<br />
arabo-latine che vennero eseguite in quel periodo.<br />
Per ridare vita all'impulso iniziale era necessario<br />
riconsiderare il problema dalle sue radici, appunto<br />
le radici della scienza araba. Da qui nasce la seconda<br />
fase delle traduzioni delle opere degli arabi<br />
nella lingua latina, che può farsi iniziare verso il<br />
secondo quarto del XII secolo, e che sarà l'elemento<br />
determinante e decisivo che permetterà<br />
l'adozione definitiva e vantaggiosa della teoria<br />
dell'astrolabio e lo sviluppo dell'astronomia<br />
nell'Occidente.<br />
Probabilmente la traduzione di Ermanno il<br />
Dalmata (da non confondere con Ermanno<br />
Contratto) del Planisfero di Tolomeo, è decisiva nell'acquisizione<br />
generale della teoria della<br />
proiezione stereografica e della sua relativa corretta<br />
applicazione nella costruzione dell'astrolabio.<br />
Ricordiamo il grande lavoro di Giovanni di<br />
Siviglia, che traduceva Maslama; Rodolfo di<br />
Bruges che traduceva un trattato sulla costruzione<br />
dell'astrolabio di Messahalla, uno dei più importanti;<br />
le traduzioni di Platone da Tivoli dei trattati<br />
sull'uso dell'astrolabio d'Ibn al-Saffar, latinizzato<br />
in Abulcasim. Tutto ciò costituì la nuova piattaforma<br />
di lancio per la scienza dell'astrolabio.<br />
Inoltre, parallelamente ai lavori di questi traduttori,<br />
molti altri autori si sforzarono di scrivere<br />
materiale nuovo, originale, sull'astrolabio: questi<br />
sono Adelardo di Bath, intorno al 1142-1146, sulla<br />
costruzione; Raimondo di Marsiglia, verso il 1141,<br />
sulla composizione e l'uso; Roberto di Chester, nel<br />
1147, sull'uso; un certo Arialdus, sulla composizione<br />
ed uso; Abraham ibn Ezra, verso il 1158-<br />
1161, sull'uso ed altri ancora (si veda la bibliografia<br />
alla fine di questo volume).<br />
La maggior parte di questi testi sono ancora inedi-<br />
ti, e l'impressione che si ricava da essi e dai manoscritti<br />
del XII e XIII secolo è certamente quella di<br />
avere a disposizione libri in cui la teoria e la pratica<br />
dell'astrolabio è definitivamente esplorata.<br />
Inoltre, la terminologia adottata non presenta quel<br />
carattere di abusivismo letterario che con timidezza<br />
veniva riportato negli antichi manoscritti.<br />
Ormai il latino risuonava di termini arabi adottati<br />
e insostituibili: ...et sequitur alhancabuth cujus interpretatio<br />
est aranea... si legge nella traduzione di<br />
Maslama, oppure: ...post hec et sequitur alhancabuth<br />
id est aranea, da Messahalla, e ancora: ...quoddam<br />
superfluum extra circulum capricorni quod almuri arabice,<br />
latine index appelatur, da Arialdus, a proposito<br />
dell'indice che marca sull'"aranea" l'inizio del<br />
Capricorno.<br />
In questi testi, quindi, si riscontra un'esposizione<br />
scientifica migliore, più logica e molto più chiara.<br />
E' interessante, a questo proposito, mettere a confronto<br />
due pezzi sullo stesso argomento dai manoscritti<br />
di Lupitus e Arialdus 14 . Il pezzo relativo al<br />
testo di Lupitus è sulla trasformazione delle ore<br />
ineguali in ore eguali, mentre per Arialdus è<br />
trovare i numeri dei gradi di una ora ineguale. Il<br />
procedimento in entrambi i casi è lo stesso:<br />
LUPITUS. - Quomodo horas tortas facias<br />
rectas. Quando queris tornare horas tortas ad<br />
horas rectas per astrolapsum, accipe quot<br />
queris et in ultima linea horarum quas accepisti<br />
pone nadair solis, et vide ubi stat almeri, et<br />
pone ibi signum; postea circumvolve ipsum<br />
nadair solis ab ultima usque ad primum<br />
almucantarat prime hore et vide ubi stat almeri<br />
et pone ibi signum, et ipsos ordines quos ambulat<br />
almeri partire per ordinem rectarum<br />
horarum, id est per XV, et videbis quot inde<br />
colligis horas recta.<br />
ARIALDUS. - Si vis scire quot gradus habeat<br />
unaqueque hora diei, pone nadir solis super<br />
principum qualiscumque hore et nota gradum<br />
in limbo in cujus directo fuerit almuri; volvesque<br />
rethe nadir donec ad finem ejusdem<br />
hore pervenerit, et quot gradus sive partes<br />
graduum almuri pertransierit tot gradus vel<br />
partes gradum sunt illius hore. Partes vero<br />
horarum noctis cum gradu solis eodem posito<br />
et volvendo circumducto notatisque gradibus<br />
quos almuri pertransierit simili modo reperis.<br />
14 J.-M. Millas-Vallicrosa, Assaig..., p. 285 - Manoscritto latino N. 16652, fol. 36, della Biblioteca Nazionale di Parigi.<br />
<strong>Nicola</strong> <strong>Severino</strong> Il Libro degli Astrolabi<br />
36