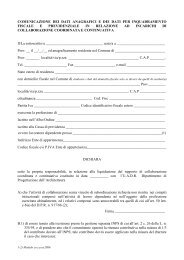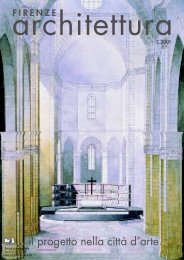i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
In questo scritto sarà mia cura volgermi<br />
alle note programmatiche attinenti<br />
al Laboratorio <strong>di</strong> Progettazione 2, sez.<br />
A, nelle quali si afferma il “primato del<br />
<strong>di</strong>segno” e si postula l’attenzione verso<br />
la sequenza delle in<strong>di</strong>cazioni teoriche<br />
che emergono dai riferimenti della trattatistica,<br />
intesa come traccia del “comporre<br />
architettura”.<br />
Nel delimitare l’ambito del nostro stu<strong>di</strong>o<br />
si afferma, con l’Alberti, che “l’architettura<br />
nel suo complesso si compone<br />
del <strong>di</strong>segno e della costruzione” ponendo<br />
inoltre attenzione alla<br />
asserzione successiva, “... si potranno<br />
progettare mentalmente tali forme nella<br />
loro interezza prescindendo affatto<br />
dai materiali”. La citazione continua definendo<br />
quel “primato del <strong>di</strong>segno”, che<br />
assumiamo, in toto, come nostro tracciato<br />
<strong>di</strong> lavoro, concepito nella mente e<br />
condotto a compimento da persona<br />
dotata <strong>di</strong> ingegno e <strong>di</strong> cultura. Nella citazione<br />
si può riconoscere l’eco <strong>di</strong> più<br />
nuove tautologie relazionate all’improbabile<br />
“eroe positivo” della viva stagione<br />
dell’idealismo al nostro inizio <strong>di</strong> secolo:<br />
a quell’intendente <strong>di</strong> poesia <strong>di</strong> cui<br />
molto si è <strong>di</strong>sputato.<br />
Nell’Alberti si può leggere una presa <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stanza, quasi una nota inespressa <strong>di</strong><br />
biasimo, per un comporre, (un architettare)<br />
e un costruire, frutto degli artefici<br />
toscani: “una ragnatela <strong>di</strong> architettori e<br />
<strong>di</strong> ingegneri” intenti, a parole, narra il<br />
Vasari, a star “sopra il modo <strong>di</strong> voltar la<br />
cupola”, così come eufemisticamente<br />
palesato da quei consoli dell’Arte della<br />
Lana e da quegli operai <strong>di</strong> S. Maria del<br />
Fiore che ritardavano il nuovo <strong>di</strong> ser Filippo<br />
per mantenere intatta la gerarchia<br />
dei saperi corporativi, sperimentati<br />
ma tar<strong>di</strong>vi e comunque inadeguati<br />
42<br />
D O S S I E R<br />
A=f(U,B)<br />
Aurelio Cortesi<br />
alle attese della fabbrica del Duomo.<br />
Alberti poneva in <strong>di</strong>scussione l’assetto<br />
consolidato del ruolo dell’architetto, inteso<br />
come artefice, ma organico ad un<br />
sistema <strong>di</strong> produzione corporativa per<br />
proporre la figura dell’intellettuale compartecipe<br />
e protagonista del nuovo<br />
blocco <strong>di</strong> potere. È in questo senso che<br />
egli descrive l’ambito teorico attribuito<br />
alla figura “intellettuale” che il nuovo architetto<br />
incarna: l’autore che progetta<br />
mentalmente (le) forme... “prescindendo<br />
affatto dai materiali” certo, ma soprattutto<br />
si affranca dalla gestione tetragona<br />
delle corporazioni affermando<br />
un’area <strong>di</strong> intervento propriamente teorico:<br />
il “primato del <strong>di</strong>segno” consegue<br />
come area <strong>di</strong> conquistata autonoma in<strong>di</strong>vidualità.<br />
Le linee portanti del Rinascimento risultano<br />
delineate enunciando principi e<br />
teorie che riducono intenzionalmente il<br />
legame tra idea ed esecuzione in una<br />
operazione che privilegia il processo <strong>di</strong><br />
progetto astraendosi dai proce<strong>di</strong>menti<br />
tecnici consolidati della costruzione<br />
concreta.<br />
Alberti, più avanti nel testo, ci fa avvertiti<br />
dell’altro corno del <strong>di</strong>lemma: “riscoprire<br />
l’arte del costruire” inteso però<br />
come costume morale e non come processo<br />
intrinseco del progetto. Questa<br />
presa <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza, ancora una volta, dà<br />
senso rinnovato al campo della esecutività<br />
che assume una ulteriore autonomia:<br />
“Il <strong>di</strong>segno ne è strumento perché,<br />
al <strong>di</strong> là della scrittura architettonica dell’idea,<br />
sviluppa una sua processualità<br />
che è “forma delle relazioni e pertanto<br />
compone”.<br />
Assumiamo queste enunciazioni, al <strong>di</strong><br />
là delle tautologie possibili, per fissare<br />
il ruolo tra le teorizzazioni e le esecu-<br />
zioni delle opere, rilevando le intenzionalità<br />
dell’estensore che privilegia strumentalmente,<br />
il <strong>di</strong>segno, come fondamentale<br />
forma del pensiero architettonico<br />
tout court esprimendo “idea e<br />
forma delle cose” (Vasari).<br />
Si tratta <strong>di</strong> una strada già esplorata,<br />
anni fa, prima e dopo gli anni cinquanta,<br />
quando Ernesto N. Rogers espresse<br />
una teorizzazione in qualche modo debitrice<br />
alla trattatistica rinascimentale,<br />
privilegiando (facendosi lui stesso trattatista)<br />
il rapporto forma/funzione inteso<br />
come trasposizione dei termini <strong>di</strong> bellezza/utilità<br />
e comprendendo implicitamente,<br />
nella seconda aggettivazione, la<br />
firmitas. Un proce<strong>di</strong>mento analogo, ritengo,<br />
a quello sinteticamente enunciato<br />
nell’esor<strong>di</strong>o albertiano.<br />
Quella proposta mirava recuperare,<br />
alla cultura del Movimento Moderno,<br />
una parte della trattatistica espressa<br />
nella temperie culturale delle avanguar<strong>di</strong>e,<br />
segnando una via <strong>di</strong> riaffermazione<br />
dei valori della storia, in tempi<br />
nei quali la palingenesi era la premessa<br />
per la formulazione <strong>di</strong> nuove definizioni<br />
all’interno del rapporto <strong>di</strong> formalizzazione<br />
canonico.<br />
È la ricerca sulle evoluzioni del linguaggio<br />
architettonico che lo coinvolge<br />
in prima persona. La trattatistica in<strong>di</strong>ca,<br />
nell’arco del suo pensiero, un nodo applicativo,<br />
tra teoria e progettualità che<br />
Rogers riuscirà, nei suoi primi anni <strong>di</strong><br />
insegnamento, dal 1952 al 1955, a <strong>di</strong>ffondere<br />
dal pulpito della <strong>di</strong>sciplina Caratteri<br />
Stilistici e Costruttivi dei Monumenti.<br />
E questo programma rimarrà<br />
inalterato fino alla formulazione dei<br />
temi successivi, sulle preesistenze ambientali,<br />
riferiti alla sua propria elabora-<br />
concorso a inviti per il<br />
recupero <strong>di</strong> un antico<br />
borgo agricolo a<br />
Camerata (To<strong>di</strong>) 1991.<br />
progetto:<br />
prof. Aurelio Cortesi,<br />
arch. Marco Casamonti<br />
con<br />
Laura Andreini,<br />
Isotta Cortesi,<br />
Silvia Fabi,<br />
Giuseppe Fioroni,<br />
Emanuele Franzoni,<br />
Gristina Giani,<br />
Cristina Guerrini,<br />
Stefano Giovannozzi,<br />
Bettina Gori,<br />
Marcello Marchesini,<br />
Giovanni Polazzi.<br />
zione <strong>di</strong> progetto.<br />
La definizione degli aspetti del moderno,<br />
alla luce della problematica rogersiana,<br />
rimanda (siamo nel 1954) alla<br />
successiva elaborazione sui temi della<br />
tra<strong>di</strong>zione nazionale. Un avanzamento<br />
teorico ormai conflittuale, almeno nelle<br />
enunciazioni, rispetto alle idee consolidate<br />
del Movimento Moderno. Una in<strong>di</strong>cazione<br />
tematica che in questa sede<br />
mi limito ricordare in quanto non pertinente<br />
rispetto all’argomento che stiamo<br />
indagando, ma che richiamo per ricordare<br />
il riverbero culturale <strong>di</strong> portata<br />
generazionale del tema, -la contingenza<br />
che prende il sopravvento- rispetto<br />
agli sviluppi successivi dell’architettura.<br />
Ma a questo proposito voglio sottolineare,<br />
comunque, come Rogers perseguisse,<br />
sia nelle prime in<strong>di</strong>cazioni<br />
qui esposte, <strong>di</strong> carattere teorico, sia in<br />
quelle imme<strong>di</strong>atamente successive,<br />
più riferite al <strong>di</strong>battito cogente -quello<br />
della costruzione- una comune adesione<br />
ai temi della storia fissando, da lì, in<br />
modo riconoscibile, il percorso intrapreso<br />
dal mondo dell’architettura e<br />
che, osservato ormai a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong><br />
anni, stabilisce la sua coincidente e <strong>di</strong>rezionata<br />
strada alla progettazione della<br />
Velasca. (E poi del museo del Castello).<br />
Assistiamo ad una finalizzazione dei<br />
temi indagati; la storia, la tra<strong>di</strong>zione, il<br />
luogo, la città, volta ad una nuova pratica<br />
della progettazione, intesa questa,<br />
come “risoluzione” del momento storico<br />
attraversato. Un processo che si pone<br />
all’interno dell’assunto albertiano recuperando,<br />
tra idea ed esecuzione, principi<br />
<strong>di</strong> coerenza e <strong>di</strong> concretezza.<br />
Come abbiamo già sottolinato, la sua<br />
attività <strong>di</strong>dattica inizia mostrando -degli<br />
elementi del fenomeno architettonicole<br />
definizioni e i significati terminologici,<br />
saggiando però, <strong>di</strong> volta in volta, i<br />
limiti dei propri settori, affinché risultasse<br />
evidente -quasi una trama- la delimitazione<br />
del campo <strong>di</strong>sciplinare e il<br />
suo continuo <strong>di</strong>latarsi problematico<br />
d’orizzonte. Un testo lucido ma intrigante,<br />
funzionale alla costruzione sofisticata<br />
del paradosso: un materiale <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o che potrebbe essere assunto,<br />
esso stesso, come base teorica per un<br />
programma <strong>di</strong> ricerca sulle “ragioni del<br />
comporre”, tentando, finalmente, una<br />
risposta non equivoca su “quale storia<br />
per la composizione architettonica”.<br />
“Struttura della composizione architettonica”,<br />
la lezione riassuntiva <strong>di</strong> tale<br />
periodo, pubblicata su “Aut-Aut”, Milano,<br />
luglio 1953, precisa le coor<strong>di</strong>nate<br />
teoriche della sua <strong>di</strong>dattica. In essa cogliamo,<br />
in nota a margine, la sua famosa<br />
formula:<br />
A=f(U,B),<br />
ove l’architettura, A, risulta funzione<br />
delle variabili: U- utilità e B- bellezza.<br />
In questa formula si può cogliere il senso<br />
positivo dei suoi riferimenti tautologici,<br />
rilevandone il cipiglio accademico<br />
e ironico assieme, misurando la sua<br />
capacità <strong>di</strong> allargare all’interno delle<br />
definizioni proposte i compiti dell’architettura<br />
e in ultima analisi dell’arte. <strong>Architettura</strong><br />
e arte intrinseci, per lui, al<br />
Movimento Moderno, beninteso.<br />
Da queste lezioni che sotto il titolo “Utilità<br />
e bellezza (Metodologia della composizione<br />
architettonica)” costituiscono la<br />
seconda parte <strong>di</strong> “Esperienza dell’<strong>Architettura</strong>”<br />
(Einau<strong>di</strong> 1958), si passa successivamente<br />
negli anni 64/65 ad un testo<br />
che mi accompagna da molti anni<br />
nella mia esperienza <strong>di</strong>dattica: mi riferi-<br />
43<br />
D O S S I E R