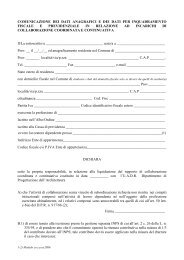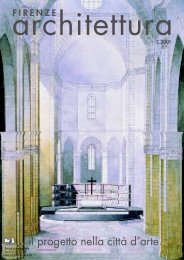i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
D O S S I E R 2.2000<br />
nel prossimo numero <strong>di</strong><br />
FIRENZE ARCHITETTURA:<br />
QUADERNI<br />
PROGETTO CITTÀ<br />
METODI, STRUMENTI, LINGUAGGI<br />
Contributi <strong>di</strong>:<br />
Antonio CAPESTRO, Mario FERRARI,<br />
Flaviano Maria LORUSSO, Cinzia PALUMBO,<br />
Dragana PAVLOVIC, Clau<strong>di</strong>o ZANIRATO.<br />
I L U O G H I D E L L ’ A R C H I T E T T U R A<br />
La prerogativa saliente del quinto numero <strong>di</strong> Dossier è <strong>di</strong> chiudere un ciclo e <strong>di</strong> aprirne un altro nello stesso tempo. I Luoghi<br />
dell’architettura completa, infatti, la prima serie <strong>di</strong> contributi dei docenti del <strong>Dipartimento</strong> ma altresì anticipa, con un impe-<br />
gnativo lavoro redazionale, il carattere più frammentario e antologico dei prossimi numeri.<br />
1. 01 quaderni<br />
Risulta impossibile - post quem - non pensare al <strong>di</strong>battito che aveva animato il progetto della rivista o alle finalità con cui<br />
inauguravamo, in una situazione particolarmente favorevole, la nuova formula <strong>di</strong> FIRENZE ARCHITETTURA (gennaio 97).<br />
Difficile, per chi vive e lavora “altrove”, capire la complessità <strong>di</strong> un’operazione che ha mobilitato “a mosaico” tanti ricercatori e<br />
stu<strong>di</strong>osi. Difficile anche per chi scrive comunicare la sod<strong>di</strong>sfazione per un importante obiettivo raggiunto, reso ancor più<br />
sorprendente dalle pesanti limitazioni: quello <strong>di</strong> far conoscere tutte (o quasi) le realtà <strong>di</strong> un contesto culturale molto eteroge-<br />
neo, non definibile all’interno <strong>di</strong> un in<strong>di</strong>rizzo o tendenza. Poiché è certo che a tutt’oggi la collana rappresenta lo specchio, anzi<br />
il documento più fedele delle “anime”, ovvero delle molteplici identità <strong>di</strong> un luogo ricco <strong>di</strong> magiche potenzialità e <strong>di</strong> profonde<br />
contrad<strong>di</strong>zioni. Per tali motivi ci sembra opportuno non tanto trinciare giu<strong>di</strong>zi a posteriori sulle singolarità dei fatti, bensì fissare<br />
schematicamente alcuni punti <strong>di</strong> un <strong>di</strong>battito ormai maturo che dovranno trovare lo spazio per ulteriori approfon<strong>di</strong>menti.<br />
In questa serie <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> monografici v’è anzitutto un dato positivo istantaneo, relativamente facile da osservare e consiste nel<br />
tentativo <strong>di</strong> circoscrivere il campo d’azione e d’interessi tramite un riconoscimento reciproco; qualcosa <strong>di</strong> molto vicino a quello<br />
che si potrebbe definire un sentimento generale d’appartenenza, oppure l’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> molti in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> una medesima specie, che<br />
si trasmette vicendevolmente e consente <strong>di</strong> promuovere approcci ed esiti sempre più interattivi con la realtà. In secondo luogo,<br />
al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> astratte e velleitarie ambizioni inter<strong>di</strong>sciplinari, v’è l’attenzione verso nuove forme <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>camento, non più chiuse su<br />
fenomeni locali, né costruite sui caratteri logori <strong>di</strong> alcune pratiche, ma quasi alla ricerca <strong>di</strong> un esor<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> terreni d’incontro con<br />
altre comunità scientifiche, in virtù <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> corrispondenze o grazie a proprietà <strong>di</strong>chiaratamente affini o a mo<strong>di</strong> che si<br />
trasferiscono gli uni negli altri. Infine sembra rinascere un po’ ovunque, soprattutto dai contributi dei docenti dell’ultima gene-<br />
razione, uno sforzo comune, un’istanza <strong>di</strong> rinnovamento che tende ad una graduale ricomposizione <strong>di</strong> valori e <strong>di</strong> principi,<br />
collocandosi al <strong>di</strong> fuori della stanca competizione accademica. Ciò testimonia un quasi-trovato clima <strong>di</strong> libertà e d’immagina-<br />
zione che può far sperare per il futuro. Il percorso a ritroso su questi Dossier lascerebbe intravedere le svariate nature <strong>di</strong> tale<br />
tensione e farebbe anche emergere in forma palese l’entità <strong>di</strong> un fenomeno che sarà probabilmente la grande sfida culturale e<br />
scientifica, etica ed estetica, ma soprattutto biologica del ventunesimo secolo: il massiccio spostamento <strong>di</strong> forze sulle ragioni<br />
dell’architettura oggi, la ricerca dei punti <strong>di</strong> sutura tra meto<strong>di</strong>, tecniche ed obiettivi, a partire da una <strong>di</strong>versa e possibile epistè-<br />
me; cioè dai processi conoscitivi, dagli strumenti utilizzabili, dai progetti sostenibili. Insomma il desiderio d’interpretare un’idea<br />
<strong>di</strong> contemporaneità che vada finalmente a scavare in questa realtà il senso concreto e preciso del nostro operare.<br />
(Marino Moretti)<br />
P R E S E N T A Z I O N E<br />
CARLO CHIAPPI<br />
Con il precedente numero della rivista (1-2000, Dossier) il nostro <strong>Dipartimento</strong> conclu-<br />
deva la presentazione delle proprie Sezioni <strong>di</strong> Ricerca costituite ciascuna da gruppi <strong>di</strong><br />
docenti spontaneamente aggregati, affini per comuni interessi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, coltivati e<br />
sviluppati prevalentemente nel lavoro <strong>di</strong>dattico.<br />
Con questo numero invece (2-2000, Dossier) viene illustrata l’attività <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong><br />
docenti che, pur appartenendo ugualmente allo stesso <strong>Dipartimento</strong>, non hanno an-<br />
cora aderito ad alcuna delle Sezioni fino ad oggi costituite, quali <strong>Architettura</strong> e città,<br />
<strong>Architettura</strong> e contesto, <strong>Architettura</strong> e <strong>di</strong>segno, <strong>Architettura</strong> e innovazione.<br />
Tuttavia, nel corso dei lavori redazionali per l’approntamento del presente numero della<br />
rivista, fu in<strong>di</strong>viduato un titolo, I <strong>luoghi</strong> dell’architettura, che parve poter riassumere e<br />
rappresentare in forma certamente sintetica il carattere comune che i vari contributi si<br />
apprestavano a proporre e illustrare. Questo riferimento metodologico e tematico è sta-<br />
to, entro certi limiti, seguito e riconfermato, anche se è forse superfluo ricordare come,<br />
questa volta, ci si trovi in presenza <strong>di</strong> un gruppo che non si è dato a priori un preciso<br />
in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> ricerca ed un programma comune <strong>di</strong> lavoro; fatto che inevitabilmente si riflet-<br />
te, anche se solo in parte, sulla stessa organicità dell’insieme <strong>di</strong> contributi presentato.<br />
Con questa presentazione, tali contributi sono stati or<strong>di</strong>nati in tre gruppi <strong>di</strong>stinti, corri-<br />
spondenti, ciascuno, ad un più particolare taglio metodologico.<br />
Il primo (Vernuccio, Eccheli, Andreini) sviluppa le proprie argomentazioni <strong>di</strong> progetto<br />
per via prevalentemente applicativa, a partire dai vincoli posti da una precisa realtà<br />
costruita e che, più degli altri, sembrerebbe cogliere il riferimento tematico in<strong>di</strong>viduato<br />
preliminarmente.<br />
Il secondo (Cortesi, Chiappi) sviluppa invece i propri argomenti in forma <strong>di</strong> principi<br />
fondativi e, potenzialmente, quale apporto ad una riflessione teorica generale sul modo<br />
<strong>di</strong> pensare architettura. Il riferimento al luogo è qui meno <strong>di</strong>retto e gli esempi applicativi<br />
che accompagnano le tesi sostenute si collocano in un rapporto meno me<strong>di</strong>ato rispet-<br />
to alle argomentazioni sviluppate nel testo.<br />
Il terzo infine (Galli, Mugnai) pur sviluppando anch’esso questioni riconducibili in linea<br />
<strong>di</strong> principio agli aspetti metodologici dell’operare, sembra essere collocato più stabil-<br />
3<br />
D O S S I E R