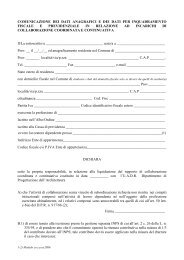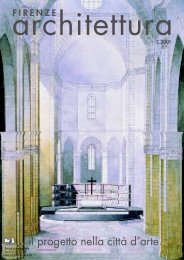i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
“Quelli che nel secolo XIII si chiamavano “magistri ae<strong>di</strong>ficiorum et stratarum”, o semplicemente “ae<strong>di</strong>ficiorum”, nel se. XVI si chiameranno invece “magistri<br />
viarum et ae<strong>di</strong>ficiorum” o semplicemente “viarum”. E la posizione <strong>di</strong> priorità o d’esclusiva, che nella intitolazione tengono questi due termini <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici e <strong>di</strong><br />
strade, in<strong>di</strong>ca il soggetto alternativamente prevalente delle attribuzioni dei maestri nei vari tempi. Nei secoli XIII e XIV i maestri - e non per nulla tutti i<br />
documenti, che ce ne rimagono, sono sentenze arbitrali - sono soltanto dei giu<strong>di</strong>ci: giu<strong>di</strong>ci “super omnibus questionibus Urbis e<strong>di</strong>ficiorum, domorum,<br />
murorum, viarum, platearum, <strong>di</strong>visionum tam intus Urbem quam extra”. Il concetto d’ornato e d’utilità pubblica stenta ancora evidentemente a svolgersi<br />
dalla selva dei casi concreti e delle vertenze particolari <strong>di</strong> convenienza e d’utilità privata (Emilio Re, Maestri <strong>di</strong> strada , Roma, A cura della R. Società<br />
Romana <strong>di</strong> storia patria, 1920, p. 5 sgg.).<br />
“Fin dal trecento, nel 1299, a Firenze, era stato costituito l’ufficio delle contrade, delle piazze e dei ponti. Il principio del rettifilo incominciò ad avere impero<br />
verso la metà del quattrocento, sotto gli auspicii <strong>di</strong> Niccolò V e <strong>di</strong> Sisto IV/…/i magistri viarum , ebbero il compito speciale <strong>di</strong> occuparsi dell’allineamento<br />
delle strade e della loro ornamentazione. Identici concetti imperavano a Siena, dove troviamo gli Uffiziali dell’ornato (1469), a Ferrara e a Milano” (Eugenio<br />
Müntz, L’arte italiana nel quattrocento, Milano 1894, p. 365).<br />
“Quasi tutta la nostra esistenza si svolge tra quattro pareti, che limitano e con<strong>di</strong>zionano la nostra esperienza. E la parete non è soltanto una superficie<br />
solida <strong>di</strong> mattoni intonacati, è anche un colore: l’opera del pittore che tinteggia una parete non è meno costruttiva <strong>di</strong> quella dell’architetto che l’ha progettata<br />
e del muratore che l’ha fabbricata. Il gesto pittorico <strong>di</strong> Rothko è il gesto pacato, uniforme dell’imbianchino che tinteggia un muro: a poco a poco, seguendo<br />
il ritmo regolare del moto che <strong>di</strong>stende il colore, si avvede che la tinta muta la situazione ambientale e che uno spazio sta nascendo là dove non c’era che<br />
una cesura nella continuità dello spazio. La parete cessa <strong>di</strong> essere un limite, un <strong>di</strong>vieto psicologico; come assorbito e filtrato attraverso la trama del colore,<br />
lo spazio al <strong>di</strong> là passa al <strong>di</strong> qua, trabocca dai limiti del muro, invade la stanza col proprio vapore. La parete <strong>di</strong>venta ambiente; lo spazio infinito, cosmico, si<br />
trasforma in spazio empirico, da viverci dentro. Lo spazio che la pittura definisce non è più al <strong>di</strong> là, ma al <strong>di</strong> qua della superficie <strong>di</strong>pinta; e questa, come u<br />
musaici delle chiese bizantine (Rothko è russo), serve a colorire l’aria nel vano architettonico.” (Argan de L’Arte Moderna (sppl. N. 10 del “Corriere della<br />
Sera”, p. 482)<br />
“L’architettura è al tempo stesso un insieme <strong>di</strong> tecniche e una forma d’arte. L’idea <strong>di</strong> architettura non implica solo la costruzione <strong>di</strong> manufatti (muri, case,<br />
città), ma un modo complessivo <strong>di</strong> intendere lo spazio, dallo spazio in<strong>di</strong>viduale ai gran<strong>di</strong> spazi collettivi (la piazza, la strada, un intero territorio in quanto<br />
abitato e mo<strong>di</strong>ficato dall’uomo” ( L’arte come mestiere a cura <strong>di</strong> Umberto Eco, Milano Bompiani 1972, p.107).<br />
“…parlare <strong>di</strong> teatro <strong>di</strong>viene necessariamente parlare <strong>di</strong> espressione <strong>di</strong> fatti comunicativi in uno spazio determinato. Il quale non è solo spazio scenico, ma<br />
contemporaneamente luogo in cui variamente si svolgono rapporti sociali. È nel luogo teatrale, insomma, che si articolano e si <strong>di</strong>alettizzano in maniera<br />
strettamente intrecciata scena, pubblico, mercato e ambiente sociale/…/Ludovico Zorzi, nel recente Il teatro e la città/…/ci fa inseguire la multiforme<br />
fenomenologia dei <strong>luoghi</strong> teatrali così ripensati nella storia: la chiesa, la sala, il cortile, il giar<strong>di</strong>no, la piazza, la città intera, ‘il cui tessuto viario viene<br />
percepito, nell’occasione <strong>di</strong> ingressi e <strong>di</strong> cerimonie solenni, come uno spazio lu<strong>di</strong>co collettivo’.” (Omar Calabrese, Lo spazio, il luogo, il pubblico. Dal<br />
decentramento alla progettazione <strong>di</strong> nuove strutture , “Rinascita” n. 9, 3 marzo 1978, p.24).<br />
“Prima <strong>di</strong> essere forma, una cosa è colore. I colori sono le qualità <strong>di</strong> un quadro. Ogni artista ha i suoi colori o la sua colorazione”<br />
“Cerca <strong>di</strong> <strong>di</strong>menticare gli oggetti che ti stanno davanti: un albero, una casa, un campo ecc. Pensa soltanto: qui c’è un piccolo quadrato azzurro, qui una<br />
striscia <strong>di</strong> giallo, e <strong>di</strong>pingi come ti appaiono” (Manet) (U. Magrini, A. Nastasio, Educazione artistica 1, Firenze Sansoni 1970)<br />
“È importante ricordare che gli oggetti fisici non ci vengono dati come elementi primari. Ciò che vien dato è soltanto un complesso <strong>di</strong> sensa; e un sensum/<br />
…/è qualche cosa <strong>di</strong> “irrelato”. In altre parole, il sensum, come tale, è semplicemente una macchia colorata senza alcun riferimento a oggetti fisici esterni”<br />
(Aldous Huxley, L’arte <strong>di</strong> vedere, Mondadori 1951, p. 49).<br />
“Più volte mi è stato chiesto per quale necessità ho modellato alcune statue ‘a rovescio’, cioè ho modellato lo spazio che racchiudeva il pieno, e non il pieno<br />
<strong>di</strong>rettamente” “Si può considerare il valore del vuoto non come derivato ma come fatto attivo, agente sul pieno” (Mirko, La fondazione Mirko per Firenze ,<br />
Firenze Vallecchi 1979, p.26)<br />
“Quale sarà la via d’uscita? Io credo che essa si trovi in quei punti <strong>di</strong> raccordo in cui la democrazia chiede che tutti i soggetti siano presenti: il politico deve<br />
accostarsi all’architetto, l’architetto e il politico devono accostarsi al citta<strong>di</strong>no per avere una visione comune, per descrivere la vita com’è, e pensare come<br />
può essere, come deve essere. Bisogna sottrarsi al pericolo <strong>di</strong> essere costruttori <strong>di</strong> episo<strong>di</strong> architettonici non ripetibili solo per il gusto <strong>di</strong> vantarsene<br />
facendo la ruota come il pavone, perché in questo modo si aumenta il <strong>di</strong>stacco tra costruire e vivere; e se aumenta il <strong>di</strong>stacco tra costruire e vivere, aumenta<br />
lo spazio per i cattivi costruttori/…/la lunga esperienza storica italiana, che è un’esperienza autoritaria in tutti i sensi [autoritaria socialmente, culturalmente,<br />
economicamente, autoritaria anche dal punto <strong>di</strong> vista religioso] non ha affatto invogliato l’opinione pubblica a partecipare alla costruzione della vita<br />
pubblica.” (Conversazione con Furio Colombo, “l’Architetto” n. 147 giugno 2000, p. 17,18).<br />
Così questo spazio abitato viene necessariamente a caratterizzarsi con un centro, come un luogo a cui è collegato il concetto <strong>di</strong><br />
polo. Uno spazio realmente rappresentato non può non avere un centro:<br />
“Quel che Kant compie è /…/ una messa in chiaro risolutiva <strong>di</strong> quanto costituisce lo specifico carattere (carattere che non è determinante, e quin<strong>di</strong> non<br />
apo<strong>di</strong>ttico) del giu<strong>di</strong>zio estetico; e nel contempo egli <strong>di</strong>mostra l’impossibilità <strong>di</strong> ogni dottrina del bello. Applicato alle arti, questo tipo <strong>di</strong> riflessione filosofica<br />
si risolve nel colpire con l’accusa <strong>di</strong> inconsistenza dal punto <strong>di</strong> vista conoscitivo ogni dottrina filosofica fondata su una definizione dell’arte <strong>di</strong> carattere<br />
essenzialistico: il <strong>di</strong>scorso estetico viene così ad essere limitato al piano d’ una critica che prenda in esame e valuti le opere e - verrebbe da aggiungere -<br />
allo stu<strong>di</strong>o delle strutture fenomeniche <strong>di</strong> queste ultime. Ora, il fatto è che il romanticismo - e tutto quanto ne <strong>di</strong>scende - produce un corto circuito proprio<br />
74<br />
D O S S I E R<br />
“Lo spazio e il tempo, così come ce li rappresentiamo, hanno un centro: non ci possiamo rappresentare un<br />
tempo se non all’in<strong>di</strong>etro o in avanti rispetto al momento presente al quale viene riferito il tutto. Qualcosa <strong>di</strong><br />
analogo vale per la rappresentazione dei <strong>luoghi</strong>”. 2<br />
In sostanza, quale tipo <strong>di</strong> spazio esterno si ritiene <strong>di</strong> dover strutturare in una determinata parte <strong>di</strong> ‘città’, al fine <strong>di</strong> agevolare la<br />
caratterizzazione <strong>di</strong> quel luogo come ‘polo’ significativo in quella determinata zona? Ecco quin<strong>di</strong> che si precisano alcuni connotati<br />
della proposta: spazio esterno, spazio pedonale, che tipo <strong>di</strong> spazio pedonale…. In definitiva, una forma che riesca a darci la<br />
sensazione <strong>di</strong> un contenuto <strong>di</strong> questo tipo.<br />
nella problematica della Critica del Giu<strong>di</strong>zio allorché mette in atto la riduzione del Bello al Vero e procede alla identificazione tra l’esperienza estetica e<br />
l’operazione con cui un contenuto ontologico viene presentato e determinato (Jean-Marie Schaeffer, L’arte dell’età moderna. Estertica e filosofia dell’arte<br />
dal XVIII secolo ad oggi , Bologna, Il Mulino, 1996, p.25).<br />
“una cosa è concepibile se è rappresentata da un concetto; non occorre che sia un concetto, per essere concepibile” Hilary Putnam, Mente, linguaggio e<br />
realtà, Milano, Adelphi 1987, p. 299.<br />
“il n’y a d’originalité‚ possible qu’avec la vérité, que l’originalité‚ n’est autre chose qu’une des formes que prend la vérité pour se manifester; et ces formes<br />
heureusement sont infinies” Eugène Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture t.I, Paris, Morel 1863, p.451.<br />
“Il bello rientra pertanto nel farsi evento nella verità. Non è quin<strong>di</strong> qualcosa <strong>di</strong> relativo al piacere, quale suo semplice oggetto” (Martin Heidegger, Sentieri<br />
interrotti, Firenze, la Nuova Italia 1987, p.64).<br />
…“nel XVII secolo, si affermò il particolare dualismo dei due tipi <strong>di</strong> fiducia dell’uomo in se stesso; uno, era quello della fiducia che l’uomo aveva delle proprie<br />
esperienze sensibili della realtà; l’altro, quello della convinzione <strong>di</strong> poter conoscere la realtà… extra-sensibile e inimmaginabile, in modo matematico e<br />
astratto, fedele alla realtà stessa, anche se non corrisponde all’esperienza” “E sempre non sappiamo se l’uomo è un essere nato nel sole e proteso verso<br />
<strong>di</strong> esso o se il suo regno è l’ombra e il freddo della notte durante la quale si vedono le stelle” (Bogdan Suchodolski, Le idee copernicane e il loro significato<br />
filosofico e culturale , Accademia Nazionale dei Lincei, 1970, p.7, 14).<br />
“È fuori dubbio che il Mondo Moderno, liberando l’in<strong>di</strong>viduo, ha fatto trionfare il soggettivismo e l’in<strong>di</strong>vidualismo. Ma è altrettanto certo che nessuna epoca<br />
precedente ha elaborato un oggettivismo così spinto e che in nessuna età precedente il non-in<strong>di</strong>viduale trovò tanto cre<strong>di</strong>to sotto forma <strong>di</strong> collettivo” (Martin<br />
Heidegger, Sentieri interrotti , Firenze, La Nuova Italia, 1987, p.85).<br />
“Mademoiselle de L’Espinasse: Che pensate dell’incrocio delle specie?/…/<br />
Bordeu: Senza dubbio; l’arte <strong>di</strong> creare degli esseri che non sono, a imitazione <strong>di</strong> quelli che sono, è vera poesia. Questa volta, in luogo <strong>di</strong> Ippocrate, mi<br />
permetterete dunque <strong>di</strong> citare Orazio. Questo poeta, o facitore, <strong>di</strong>ce in qualche parte: Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci; il merito supremo è <strong>di</strong> aver<br />
unito il gradevole all’utile. La perfezione consiste nel conciliare questi due punti. La azione gradevole e utile deve occupare il primo posto nell’or<strong>di</strong>ne<br />
estetico; non possiamo rifiutare il secondo all’utile; il terzo sarà per il gradevole; e relegheremo all’ultimo posto quella che non rende né piacere né profitto.”<br />
(Denis Diderot, Dialoghi filosofici, Canova, Treviso s.d. p.171).<br />
“ne recevoir jamais aucun chose pour vrai que je ne la connusse évidemment être telle” Descartes cit. da Viollet-Le-Duc (Op. Cit., p.453).<br />
“il nostro occhio si esercita continuamente a maneggiare forme innumerevoli: la massima parte dell’immagine non è impressione dei sensi, bensì prodotto<br />
della fantasia. Dai sensi vengono presi soltanto piccoli motivi e occasioni, e ciò viene poi elaborato con l’invenzione. Bisogna mettere la fantasia al posto<br />
dell’inconscio : la fantasia non fornisce deduzioni inconsce, quanto piuttosto possibilità proiettate (quando ad esempio i bassorilievi si trasformano in rilievi<br />
per l’osservatore). Il nostro ‘mondo esterno’ è un prodotto della fantasia, alla costruzione del quale sono state, <strong>di</strong> nuovo, adoperate fantasie precedenti<br />
come attività abituali ed acquisite con l’esercizio. I colori, i toni, sono fantasie, non corrispondono affatto esattamente al processo meccanico reale, bensì<br />
alla nostra con<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>viduale” (Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi, cit. da Carlo Mongar<strong>di</strong>ni, Esprimere/Comprendere , Annuario dell’Insegnante<br />
1973-74, INA).<br />
“ogni fatto psichico esiste non propriamente come fatto (qualcosa <strong>di</strong> già compiuto, precostituito), ma come atto.” (Giovanni Gentile, Sommario <strong>di</strong> pedagogia<br />
come scienza filosofica , Firenze Sansoni 1934, p.26).<br />
…“ogni percezione è una comunicazione o una comunione, la ripresa o il compimento da parte nostra <strong>di</strong> una intenzione estranea, o viceversa è la<br />
realizzazione all’esterno delle nostre potenze percettive e come un accoppiamento del nostro corpo con le cose. Se non è stato possibile accorgercene<br />
prima, è perché la presa <strong>di</strong> coscienza del mondo percepito era ostacolata dai pregiu<strong>di</strong>zi del pensiero oggettivo. Tale pensiero ha costantemente la funzione<br />
<strong>di</strong> ridurre tutti i fenomeni che attestano l’unione del soggetto e del mondo e <strong>di</strong> sostituire a essi l’idea chiara dell’oggetto come in sé e del soggetto come pura<br />
coscienza” (Maurice Merlau-Ponty, Fenomenologia della percezione , Milano, Il Saggiatore 1965, p. 418).<br />
Negli ultimi anni il tema degli spazi aperti è stato <strong>di</strong> attualità (ricor<strong>di</strong>amo, ad esempio, per Firenze, alcuni titoli <strong>di</strong> incontri promossi<br />
dal Circolo Fratelli Rosselli negli anni ’91, ’92: Costruire l’ambiente de-costruire l’architettura; La piazza; La facciata della città.<br />
Fino alle <strong>di</strong>verse modalità <strong>di</strong> riferirsi o <strong>di</strong> utilizzare gli spazi pubblici che hanno preso campo. La Triennale <strong>di</strong> Milano 1997 con il<br />
tema: “Le architetture dello spazio pubblico. Forme del passato forme del presente” fa il punto su questa stagione progettuale e<br />
sugli esiti relativi a varie sperimentazioni in rapporto alla ‘costruzione’ dell’ambiente e alla ‘decostruzione’ dell’architettura. A<br />
Firenze, tra il <strong>di</strong>cembre ’98 e l’aprile ’99 è previsto un ciclo <strong>di</strong> conferenze su alcune piazze citta<strong>di</strong>ne, in<strong>di</strong>viduate così come<br />
‘oggetti’. In sostanza, con il tema della rivalutazione dello spazio pubblico, abbiamo da fare i conti con i connotati <strong>di</strong> un vero e<br />
proprio acca<strong>di</strong>mento che ha contribuito a spostare l’attenzione dall’architettura intesa come e<strong>di</strong>ficio collegato ad una funzione -<br />
la casa, la scuola ecc.- ad un ‘involucro’ citta<strong>di</strong>no).<br />
Si tratta peraltro <strong>di</strong> eventi che vanno in parallelo con l’accentuarsi della crisi dell’architettura moderna. Il cosiddetto Moderno<br />
viene ‘superato’ dal Postmoderno e da altre ‘sigle’ che si costituiscono come risposte in chiave simbolico-espressiva, mentre il<br />
<strong>di</strong>sagio per l’utente delle nuove realizzazioni non pare tenda a <strong>di</strong>minuire così come le polemiche e le <strong>di</strong>scussioni che spesso si<br />
sostituiscono all’attivismo delle realizzazioni del dopoguerra. 3<br />
Per quanto ci riguarda, un Corso universitario si caratterizza essenzialmente come tentativo <strong>di</strong> spiegazione razionale del senso<br />
<strong>di</strong> determinate modalità <strong>di</strong> approccio, in questo caso relative al progetto dell’architettura. “In tutte le opere d’arte è/…/necessario<br />
che l’autore abbia un piano prefisso ed un oggetto” scrive David Hume. 4 In questa sede, in sostanza, scegliamo questo della<br />
definizione <strong>di</strong> un ‘vuoto’ come ‘oggetto’ dell’architettura in certo qual modo assumendolo come riferimento funzionalmente prioritario<br />
intrinsecamente congruo. 5<br />
“La definizione più precisa che si può dare dell’urbs e della polis è in realtà molto simile alla definizione scherzosa del cannone: si prende un foro, vi si avvolge<br />
attorno strettamente del filo <strong>di</strong> acciaio ed ecco il cannone. Così l’urbs e la polis cominciano con l’essere uno spazio vuoto, il forum e l’agorà e tutto il resto sono<br />
soltanto il mezzo per delimitare quello spazio vuoto, per tracciarne il contorno” (J. L. Sert, Centri per la vita della comunità, Ciam. Il cuore della città, Hoepli,<br />
Milano 1954, p.3).<br />
75<br />
D O S S I E R