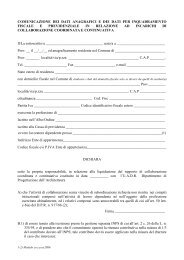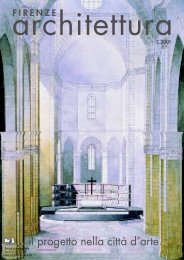i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Per comprendere cosa significhi far collaborare un e<strong>di</strong>ficio alla costruzione della città, basta leggere il saggio su La reggia e la<br />
città <strong>di</strong> Paolo Portoghesi 22 come quando riflette sul fatto che<br />
78<br />
D O S S I E R<br />
“il barocco, almeno a Roma, è essenzialmente arte urbana preoccupata <strong>di</strong> plasmare gli spazi esterni delle<br />
strade come spazi interni della città.”<br />
o dove descrive il Palazzo Ducale <strong>di</strong> Venezia e il modo <strong>di</strong> strutturare quella parete. 23 Oppure raccogliere (e interpretare) le<br />
considerazioni dello stesso Manfredo Tafuri, quando, trattando del teatro, si chiede:<br />
“fino a che punto le recenti lotte per il decentramento culturale e una nuova gestione pubblica della cultura<br />
stessa saranno capaci <strong>di</strong> evitare la palude del populismo e incidere in modo muovo sulla struttura profonda<br />
dell’istituzione teatrale? E fino a che punto quelle riven<strong>di</strong>cazioni, in Italia sempre più vive, sono premessa <strong>di</strong> una<br />
concezione <strong>di</strong>versa dello spazio urbano?” 24<br />
Se è vero “che per la ricerca modernista è <strong>di</strong> fondamentale importanza lo spazio abitabile,” 25 non risulta tuttavia corrispondente alla<br />
realtà che l’abitabilità dello spazio abbia costituito obiettivo centrale, dal punto <strong>di</strong> vista pratico, per l’architettura moderna. 26 Dichiarazioni<br />
a parte, come abbiamo già rilevato nel Progetto della scuola in Italia, 27 nella cosiddetta architettura moderna:<br />
“i riferimenti funzionali tendono ad essere rapidamente co<strong>di</strong>ficati, ed in posizione subalterna rispetto all’esigenza<br />
<strong>di</strong> produrre nuove sollecitazioni spaziali e ambientali”. 28<br />
La ricerca funzionale effettiva, in fondo, implica relazioni sociali. Per l’architettura moderna l’obiettivo non può essere che<br />
quello espressivo, legato alla sintesi della ‘macchina’, o all’elaborazione <strong>di</strong> messaggi relativi alla propria ‘identità’, più che<br />
alle analisi delle con<strong>di</strong>zioni abitative; alla ricerca <strong>di</strong> nuove modalità <strong>di</strong> espressione, che non alla risposta sistematica ad<br />
esigenze oggettive che pur fa parte del bagaglio culturale del Movimento Moderno. 29 Quin<strong>di</strong> la funzionalità è sostanzialmente<br />
all’insegna della metafora. La “linea analitico-razionale” 30 non trova con<strong>di</strong>zioni particolarmente favorevoli per il proprio<br />
sviluppo. Nella stessa scelta dell’industria come committente, si risolve la riduzione dell’obiettivo ad oggetti da mettere sul<br />
mercato, come espressione simbolica <strong>di</strong> modernità, e nel metodo dell’analogia la maniera <strong>di</strong> definirli. 31 E questa è un po’<br />
l’ere<strong>di</strong>tà che, questa volta nella pratica dell’ideologia dominante, il Moderno ha lasciato alla cultura degli architetti: ai valori<br />
della vivibilità viene attribuita un’importanza secondaria. Non è l’architettura che costituisce un ‘relativo’ nei confronti dell’abitabilità,<br />
ma il contrario!<br />
“Ma per caso si abita bene in una casa <strong>di</strong> Mies van der Rohe? Oppure L’urlo <strong>di</strong> Munch è per caso un quadro rilassante? Ora, l’equivoco nasce sull’architettura,<br />
perché in essa vi si abita e quin<strong>di</strong> c’è il pregiu<strong>di</strong>zio che bisogna abitare in maniera comoda e felice, ma tutta l’arte contemporanea è caricata <strong>di</strong> forti<br />
tensioni e <strong>di</strong> inquietu<strong>di</strong>ne. Ma sulla funzione bisogna pure mettersi d’accordo, perché quello che è funzionale per certi non lo è per altri” (Manfredo Tafuri.<br />
Non può esistere un valore collettivamente riconosciuto intorno a cui far ruotare il sistema della cultura, intervista <strong>di</strong> Giacinto <strong>di</strong> Pierantonio, “Flash Art” n.<br />
154, 1990, p. 92. Si noti come nella stessa intervista Tafuri fa presente i pregi <strong>di</strong> un’architettura che in<strong>di</strong>vidua “un nuovo tessuto urbano” contro “le risposte<br />
attuali” che “al contrario cercano <strong>di</strong> enucleare dei punti quasi rinunciando ad influenzare la scala urbana, accettando lo stato <strong>di</strong> frantumazione, anzi<br />
rifrantumando ancora <strong>di</strong> più”).<br />
“Maldonado cita una frase <strong>di</strong> Friedrich Dessauer: ‘Il fine dell’e<strong>di</strong>lizia non è la casa, ma l’abitare, così come il fine della produzione <strong>di</strong> locomotive non è la<br />
locomotiva, ma il trasporto’. Considerazioni <strong>di</strong> quelle che appaiono ovvie, ma <strong>di</strong> cui in pratica si finisce per tenere poco conto…” (Carlo Meolograni,<br />
L’oggetto casa, “Rinascita” 9 settembre 1977).<br />
In sostanza si identifica lo sviluppo della città con il singolo intervento ‘qualificato’ necessariamente incentrato sui ‘pieni’, affidandosi<br />
alle capacità <strong>di</strong> sintesi dell’architetto-artista. A fondamento <strong>di</strong> questa situazione che perdura fino ai nostri giorni sta la ricerca<br />
da parte dell’architettura moderna <strong>di</strong> un “linguaggio universale, comprensibile ovunque”, una sorta <strong>di</strong> manifestazione dell’Io che<br />
trova un veicolo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione nelle riviste, libri, mostre, dove il critico, che tende ad isolare lo specifico oggetto-artistico che sta<br />
analizzando, viene ad assumere un’importanza determinante nella valorizzazione della forza dell’immagine che tende ovviamente<br />
ad identificarsi con un oggetto. 32 E non potrebbe essere altrimenti date le premesse idealistiche: “tutto ciò che è spirituale<br />
è superiore ad ogni prodotto naturale”; 33 l’uomo trasforma “le cose esterne su cui imprime il sigillo del suo interno e in cui ritrova<br />
ora le proprie determinazioni”. 34 L’architetto stesso si fa critico al fine della promozione della propria opera. Altrettanto ovviamente,<br />
tutt’altra cosa è l’universalità <strong>di</strong> un contesto determinato, dove a giu<strong>di</strong>care è l’abitante dello spazio, che tuttavia, al momento,<br />
non ha in pratica alcun ruolo in questi confronti a livello soprattutto internazionale sulle <strong>di</strong>spute sull’arte in quanto tale, dove il<br />
‘locale’ non ha voce in capitolo. 35 Ponendosi come arte, non ‘relativa’ ma assoluta, l’architettura si stacca necessariamente da un<br />
determinato invaso spaziale ma anche dal rapporto con le modalità con le quali viene solitamente ‘utilizzata’. 36 Che pare poi il<br />
problema della particolarità sollevato da Lucács. E, prima ancora, dal Dewey:<br />
“In primo luogo, vi è l’opposizione della conoscenza empirica a quella razionale più elevata. La prima è congiunta<br />
con gli affari giornalieri, serve agli scopi dell’in<strong>di</strong>viduo comune che non ha scopi intellettuali specializzati, e<br />
porta i suoi bisogni con un certo nesso con l’ambiente imme<strong>di</strong>ato. Questa conoscenza è <strong>di</strong>sprezzata, o almeno<br />
poco considerata, come puramente utilitaria e priva <strong>di</strong> significato culturale. La conoscenza razionale dovrebbe<br />
essere qualcosa che tocchi la realtà in modo definitivo, intellettuale; qualcosa che dovrebbe essere perseguito<br />
per se stesso, non abbassato con l’applicazione alla condotta. Socialmente la <strong>di</strong>stinzione corrisponde a quella<br />
fra l’intelligenza usata dalle classi operaie e l’intelligenza usata da una classe istruita lontana dagli interessi che<br />
concernono i mezzi della vita. Filosoficamente, la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong>venta <strong>di</strong>stinzione fra particolare e universale.<br />
L’esperienza è un aggregato <strong>di</strong> particolari più o meno isolati, e la conoscenza <strong>di</strong> ognuno <strong>di</strong> essi va fatta separatamente.<br />
La ragione concerne cose universali, principi generali, leggi, che stanno al <strong>di</strong> sopra dell’ammasso dei<br />
particolari concreti”. 37<br />
Concentrandosi sul ‘particolare’ o sul ‘locale’ 38 possiamo arrivare, in linea teorica, anche all’organizzazione del “paesaggio come<br />
un autentico para<strong>di</strong>so terrestre” sostenuta da Karel Teige. 39<br />
Note:<br />
1 Milano, E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità, 1956, p. 178.<br />
2 Carl Stumpf, Psicologia e metafisica, Firenze,<br />
Ponte alle Grazie, 1992, p. 132.<br />
3 Ve<strong>di</strong> ad esempio il carattere <strong>di</strong> ‘allestimenti impermanenti’<br />
rilevato da Furio Colombo per le architetture<br />
moderne ( <strong>Architettura</strong> e comunicazione: costruzioni<br />
irrepetibili , “L’Architetto” n. 130, ottobre<br />
1998). <strong>Architettura</strong> come ‘comunicazione inutile’?<br />
“C’è un gran rumore per non <strong>di</strong>re niente. Come fa la<br />
televisione. Anche Popper la detestava” (sono considerazioni<br />
<strong>di</strong> Gombrich dal “Sole 24 ore” del<br />
dell’1.11.98). Tutto il <strong>di</strong>scorso si può ridurre alle attitu<strong>di</strong>ni<br />
comunicative? Quello dell’architettura “Uno<br />
tra i mille mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> comunicare” (dal Viaggio nel mondo<br />
degli animali n.29). Comunicare che in uno spazio<br />
si possono compiere determinate azioni. Mentre,<br />
per <strong>di</strong>re, per Frank O. Gehry si nota come per<br />
lui non vi sia “collegamento tra forme e funzioni dell’architettura”<br />
(Sebastiano Brandolini, “La Repubblica<br />
delle Donne” 12.10.98), la ‘ragione’ tende oggettivamente<br />
ad attaccare posizioni <strong>di</strong> questo tipo. Furio<br />
Colombo deputato DS coor<strong>di</strong>na “Le città: spazi<br />
per partecipare” al 2° Forum internazionale Verso<br />
città amiche delle bambine e dei bambini a Torino<br />
15-17 ottobre 98.<br />
Resta il fatto che nelle sperimentazioni dell’arte<br />
contemporanea si è provato veramente <strong>di</strong> tutto e, a<br />
seconda delle prospettive prescelte, paiono ancora<br />
vali<strong>di</strong> aspetti del Moderno e ad<strong>di</strong>rittura “A questo<br />
punto tornano i conti persino con la caotica rivisitazione<br />
del passato che opera il post-modernismo”<br />
(Maurizio Calvesi su “Rinascita” del 13 marzo<br />
1981), specie nel desiderio <strong>di</strong> riorganizzare completamente<br />
il <strong>di</strong>scorso “Però la rimessa in causa <strong>di</strong><br />
tutti i linguaggi può avvenire in due maniere: o in<br />
modo critico, responsabile, problematico; o in<br />
modo caotico, acritico, carnevalesco, come è il<br />
caso <strong>di</strong> certa produzione pittorica ma anche architettonica.<br />
Questo secondo modo, evidentemente,<br />
non promette nulla <strong>di</strong> buono.”<br />
4 L’estetica dell’empirismo inglese, a cura <strong>di</strong> Mario<br />
M. Rossi, Firenze Sansoni 1944, t.II, p.531.<br />
5 Anche altri corsi pare si interessino dello steso<br />
tema. Cfr. Celestino Porrino che si riferisce ai “vuoti<br />
ed il loro uso sociale”, “Archi e Colonne” A:I, n.5-6<br />
settembre-<strong>di</strong>cembre 1985, p. 11. O Franco Mancuso,<br />
quando, dopo aver preso atto che oggi la norma<br />
“non consentirebbe mai la manifestazione <strong>di</strong> un organismo<br />
urbano con la vitalità urbana <strong>di</strong> un campo<br />
<strong>di</strong> Venezia, <strong>di</strong> una piazza <strong>di</strong> Siena, <strong>di</strong> una strada <strong>di</strong><br />
Firenze” riven<strong>di</strong>ca l’importanza del <strong>di</strong>segno urbano<br />
“quando per affrontare i problemi <strong>di</strong> una città, o <strong>di</strong><br />
una sua parte, occorre partire dalla definizione degli<br />
spazi, piuttosto che da quella dei manufatti” (L’architettura<br />
tra piano e progetto, “Architetti Veneto” n. 1<br />
luglio 1990, p.16). Ma non risulta possibile la compresenza<br />
<strong>di</strong> due intenzioni <strong>di</strong>verse e magari opposte:<br />
una or<strong>di</strong>natrice dei vuoti per l’urbanistica e l’altra<br />
, l’architettura, che magari li <strong>di</strong>strugge.<br />
6 Nonostante la critica al Bauhaus (che segue) è<br />
proprio a Gropius che dobbiamo la rivalutazione del<br />
citta<strong>di</strong>no inteso come pedone: “il pedone è stato respinto<br />
contro il muro nel processo <strong>di</strong> costruzione<br />
della grande rete del traffico automobilistico che ha<br />
fatto espandere tanto esplosivamente la nostra comunità.<br />
Io sono convinto che è altrettanto se non più<br />
necessario creare ora, in aggiunta a quelle per il<br />
traffico automobilistico, reti in<strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong> traffico<br />
pedonale, separate e protette contro le automobili.<br />
Questo tracciato stradale pedonale, sovrapposto a<br />
quello automobilistico, comincerebbe e finirebbe<br />
non su un’autostrada, ma in una bella piazza, vietata<br />
alle automobili, vero cuore e centro dell’unità urbanistica,<br />
che dovrebbe servire come centro locale<br />
per il pubblico scambio <strong>di</strong> opinioni e la partecipazione<br />
agli affari comunitari.” (<strong>Architettura</strong> integrata, Milano<br />
Il Saggiatore 1963, p.206).<br />
7 Marco De Michelis, Agnes Kohlmeyer, Bauhaus,<br />
“Dossier” all. ad “Art e Dossier” n. 119, Firenze 1997.<br />
Non a caso, sulla pagina opposta del brano <strong>di</strong> Sert è<br />
riprodotta una foto <strong>di</strong> piazza San Marco a Venezia.<br />
8 “La forme devenait morale lorsqu’éteait mise à nu<br />
la fonction” (Erich Michaud, La vie moderne,<br />
Bauhaus et ‘modenisme’ , “Les Cahiers du Musé<br />
National d’Art Moderne”, n. 19,20, Juin 1987,<br />
p.132). Nel marzo 1987 “Domus” n. 681 ripubblica<br />
Struttura e architettura <strong>di</strong> Giuseppe Pagano, dove<br />
la posizione moralista/essenzialista emerge con<br />
particolare chiarezza: “per effetto <strong>di</strong> coloro che<br />
hanno sentito il problema morale dell’architettura<br />
moderna in tutta la sua vastità, si affronta la questione<br />
nella sua essenza, fino a cercare <strong>di</strong> ogni<br />
cosa la fisionomia finale, la forma-tipo, la sintesi volumetrica<br />
assoluta, anonima, prima.” (p.19,20). Anche<br />
Pagano vede l’origine <strong>di</strong> questa “Arte moderna<br />
primitiva” nei maestri nord-europei. In particolare in<br />
Henry van de Velde. Che in effetti afferma “che il<br />
nostro cervello è rimasto più sano dei nostri occhi”<br />
(Per un nuovo stile, Il Saggiatore 1966, p. 124), instaurando<br />
così una sorta <strong>di</strong> egemonia dell’‘intelligenza’<br />
(e dell’‘ingegneria’). Invece dell’oggettività si<br />
mira all’oggetto, invece <strong>di</strong> applicare principi <strong>di</strong> questo<br />
genere all’analisi oggettiva dei fatti, si trasferisce<br />
questa “logica” nella definizione dell’e<strong>di</strong>ficio. Se<br />
la situazione non potrà <strong>di</strong>venire “morale” sarà l’e<strong>di</strong>ficio<br />
al quale si cercherà <strong>di</strong> attribuire contenuti del<br />
genere. L’errore teorico è manifesto: in certo qual<br />
modo anche Lucács pone in evidenza i limiti della<br />
matrice ‘interna’ della forma del Bauhaus quando<br />
osserva (Estetica , vol.II, Torino Einau<strong>di</strong> 1970,<br />
p.1199): “Molte teorie moderne (per esempio del<br />
Bauhaus) commettono un errore teorico e pratico<br />
funesto per lo sviluppo dell’architettura proprio perché<br />
nella realizzazione oggettivo-tecnologica <strong>di</strong><br />
una costruzione, quando essa è riuscita come tale,<br />
vedono un fatto ovviamente estetico.” Eppoi, <strong>di</strong> fatto,<br />
introduce il paragone con la cupola del Brunelleschi<br />
e l’esigenza <strong>di</strong> presentare “tratti qualitativamente<br />
nuovi”.<br />
Il concetto <strong>di</strong> standard in quanto tale presenta peraltro<br />
possibilità <strong>di</strong> interpretazioni senz’altro positive,<br />
poiché risponde ad esigenze oggettive. Le Corbusier<br />
“In <strong>di</strong>fesa dello standard scriveva in Vers une<br />
architecture: ‘Tutti gli uomini hanno un medesimo<br />
organismo, medesime funzioni. Tutti gli uomini hanno<br />
medesimi bisogni’.” cita Renato De Fusco (Il<br />
progetto <strong>di</strong> architettura, cit. p. 58). È quando lo standard<br />
<strong>di</strong>venta e<strong>di</strong>ficio e forma precostituita e non garanzia<br />
<strong>di</strong> un certo livello qualitativo nella definizione<br />
delle forme che le verifiche complessive lasciano a<br />
desiderare. “Che la costruzione organica/…/della<br />
città si imponga all’elemento standard per rinnovarlo<br />
e non che l’elemento standard con<strong>di</strong>zioni la costruzione”,<br />
scrive Enzo Paci su la “Rivista <strong>di</strong> estetica”<br />
n. 1, gennaio-aprile 1956, p. 61.<br />
9 Nelle situazioni e nei margini in cui gli in<strong>di</strong>vidui<br />
vengono lasciati liberi <strong>di</strong> organizzarsi vengono fuori<br />
spesso risultati <strong>di</strong> particolare interesse. Ve<strong>di</strong> ad<br />
esempio: Handmade Houses, A Guide to the Woodbutcher’s<br />
Art, Idea Books International, London<br />
1975. La pubblicazione inizia con queste parole <strong>di</strong><br />
Sim Van der Ryn: “For some years we have heard<br />
the extravagant technological promise of housing<br />
at low cost. It has never come to pass. The answer<br />
to low cost housing, it seems to me, is to make a<br />
break with a ‘standard of living’ that makes us slaves<br />
to centralised decision-making and control, to<br />
an economy whose values are the magnitude of<br />
production and consumption. The dollar is not a reasonable<br />
measure of the quality of life or the quality<br />
of place.” In pratica, pare svilupparsi un “naturalismo”<br />
<strong>di</strong> segno opposto a quello caratterizzante la<br />
Bauhaus dove “il naturalismo formale si <strong>di</strong>ssolve<br />
nel cosiddetto Astrattismo. Questo, come è noto, si<br />
fonda sul principio dell’in<strong>di</strong>pendenza della forma<br />
artistica da ogni determinante empirica” con la relativa<br />
“impossibilità <strong>di</strong> una fabula de lineis et coloribus”<br />
scrive Argan (Walter Gropius e la Bauhaus,<br />
Torino Einau<strong>di</strong> 1051, p. 25. 26). Proprio perché il<br />
prodotto si pone come opera d’arte: “l’opera d’arte,<br />
come qualsiasi cosa della realtà, è constatabile ma<br />
ingiu<strong>di</strong>cabile.” (ivi, p. 26).<br />
10 Robert Delaunay, rip. In Robert Delaunay, Du cubisme<br />
a l’art abstrait , a cura <strong>di</strong> Pierre Francastel,<br />
Paris S.E.V.P.E.N., 1957p. 150. Un ‘descrittivo’ che<br />
in architettura ostacola o impe<strong>di</strong>sce la partecipazione<br />
alla scena urbana.<br />
11 Citato da Stefano Ray, L’architettura moderna nei<br />
Paesi Scan<strong>di</strong>navi, Bologna Cappelli 1965, p. 20.<br />
12 “L’attività progettante per eccellenza è la filosofia”<br />
“Si possono avere due concezioni dell’architettura,<br />
a seconda che essa venga o no messa in rapporto<br />
con la ideologia. Nel primo caso l’architettura è puramente<br />
un’arte per l’arte, cioè un esercizio creativo<br />
<strong>di</strong> forme, il cui substrato ideologico è un fatto<br />
preliminare personale, dell’artista; si fonde, cioè<br />
con la ‘poetica’ ispiratrice. Oppure si ritiene – e questo<br />
è il richiamo all’or<strong>di</strong>ne fondamentale del pensiero<br />
razionalista – che l’architetto, con le sue nuove<br />
forme, voglia contribuire a quello che genericamente<br />
si definisce come ‘progresso sociale’; e quin<strong>di</strong><br />
l’ideologia non è più un fatto preliminare, personale<br />
della creazione artistica, bensì qualcosa che illumina<br />
tutto il processo creativo.” (Giovanni Klaus Koenig,<br />
Meto<strong>di</strong> e limiti del progettare, “Quaderni dell’Istituto<br />
<strong>di</strong> Elementi <strong>di</strong> <strong>Architettura</strong> e Rilievo dei monumenti”,<br />
n. 6/7 Firenze LEF 1964, p. 83,84).<br />
Koenig pone il problema del rapporto tra progettazione<br />
e filosofia, la filosofia come una sorta <strong>di</strong><br />
‘scienza della progettazione’ “l’attitu<strong>di</strong>ne costruttiva<br />
e la capacità <strong>di</strong> dedurre da principî arbitrariamente<br />
posti il piano dell’universo” scrive Zino Zini prefazione<br />
ad Alessandro Mazoni, Del sistema che fonda<br />
la morale sull’utilità, Torino Paravia 1931, p. 84.<br />
Quin<strong>di</strong>, per usare le parole <strong>di</strong> Koenig, un tipo <strong>di</strong> architettura<br />
che trova nell’ideologia il fondamento<br />
della sua strategia, dandosi cioè degli obiettivi in<br />
contrapposizione al principio dell’arte per l’arte, <strong>di</strong><br />
una sorta <strong>di</strong> oggetto che si esaurisce in se stesso,<br />
non in<strong>di</strong>viduando altre motivazioni al proprio esterno<br />
(aspetto, come si vedrà, da recuperare anche in<br />
una prospettiva ‘ideologica’).<br />
13 Citato da Stefano Ray, L’architettura moderna nei<br />
Paesi Scan<strong>di</strong>navi, cit., p.82.<br />
79<br />
D O S S I E R