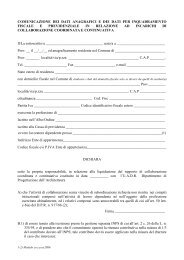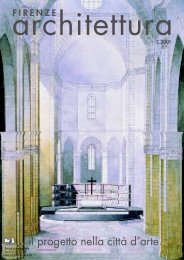i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sco agli “Elementi del fenomeno architettonico”,<br />
(scritto per Laterza ma ristampato<br />
successivamente da Guida<br />
E<strong>di</strong>tore). Libro fortunoso, scritto in fretta,<br />
<strong>di</strong>rei in pochi giorni, nell’occasione <strong>di</strong> un<br />
concorso a cattedra, ma luci<strong>di</strong>ssimo libro<br />
al cui travaglio formativo ho assistito<br />
e nel quale sono stato chiamato a svolgere<br />
una ricerca iconografica (poi risolta,<br />
con più autorevolezza e tempestività<br />
nella redazione <strong>di</strong> Casabella).<br />
Gli “Elementi del fenomeno architettonico”,<br />
rivisitano i <strong>luoghi</strong> della ricerca rogersiana<br />
superando i valori assoluti<br />
delle definizioni chiuse in se stesse,<br />
per aprire contorni più concreti, ma non<br />
per questo meno limitati, coinvolgendo<br />
un <strong>di</strong>scorso certamente più maturato e<br />
affabile che si sofferma, meno sui principi<br />
e su regole finalistiche predeterminate<br />
per giungere ad una azione pedagogica<br />
colloquiale, maieutica, storicamente<br />
riassunta e confrontata con i<br />
<strong>di</strong>versi livelli dell’insegnamento delle<br />
singole <strong>di</strong>scipline.<br />
Ma torniamo all’equazione A=f(U,B,) e<br />
riportiamo da “La struttura della composizione<br />
architettonica” la nota a margine<br />
che la chiarisce: “Soltanto a scopo<br />
<strong>di</strong>dattico e non certo con l’idea ingenua<br />
<strong>di</strong> risolvere la problematica in una formula,<br />
ho cercato <strong>di</strong> esprimere la concezione<br />
architettonica con simboli matematici,<br />
che, col far intendere l’insufficienza<br />
<strong>di</strong> una definizione ad<strong>di</strong>tiva<br />
(firmitas, utilitas, venustas) <strong>di</strong> marca vitruviana,<br />
mettesse in evidenza la caratteristica<br />
fondamentale del fenomeno:<br />
che è un complesso <strong>di</strong> relazioni necessariamente<br />
integrate.<br />
<strong>Architettura</strong> (arte applicata) è una funzione<br />
<strong>di</strong>pendente dai termini variabili<br />
Utilità e Bellezza A=f(U,B)<br />
46<br />
D O S S I E R<br />
(Ma come ogni formula, anche la mia<br />
ha i suoi limiti, fuori dai quali perde ogni<br />
significato: se nel considerare, ad<br />
esempio una macchina vogliamo ammettere<br />
che B->0, non se ne deduce<br />
che U->• e, viceversa, se si considera<br />
un’opera <strong>di</strong> pura plastica, dove U->0,<br />
ché altrimenti l’architettura, trovandosi<br />
tra i due estremi, ciò significherebbe<br />
che essa è tanto più inutile quanto più è<br />
bella e viceversa)”.<br />
La cautela nell’enunciazione della formula,<br />
ascritta ad un esclusivo uso <strong>di</strong>dattico,<br />
ci incuriosisce per il ricorso accattivante<br />
a simboli matematici: il linguaggio<br />
più garantito in una scuola<br />
politecnica, certo, ma congeniale, anche,<br />
ai rassembramenti internazionali<br />
legati alle avanguar<strong>di</strong>e del Movimento<br />
Moderno, ove Rogers era considerato<br />
un interlocutore privilegiato per quel<br />
suo argomentare sul superamento dei<br />
rapporti deterministici forma/funzione:<br />
rapporti che costituivano, in quegli<br />
anni, il nodo centrale della <strong>di</strong>scussione<br />
sul “linguaggio” del Movimento Moderno<br />
stesso, in vista <strong>di</strong> un suo invocato<br />
superamento.<br />
Una formulazione comprensibile e <strong>di</strong>vulgabile<br />
nella scuola del CIAM; un grimaldello<br />
per affacciare la sua ulteriore<br />
trattazione (certamente <strong>di</strong> minoranza)<br />
la quale postulava, a partire dal 1954,<br />
una serie <strong>di</strong> relazioni sul fenomeno architettonico<br />
che trascendevano una<br />
funzione <strong>di</strong> tipo deterministico, quasi<br />
aritmetico, fra i termini variabili ed in<strong>di</strong>pendenti<br />
<strong>di</strong> Utilità e Bellezza.<br />
Ne “Il Cuore della città: per una vita più<br />
umana delle comunità”, testo curato oltre<br />
che da Rogers anche da J. L. Sert e<br />
da J. Tyrwhitt, (Hoepli 1954) viene affacciato,<br />
per la prima volta, dai CIAM, e con<br />
ritardo, nel 1951, a Hoddesdon, il problema<br />
dei centri storici. Le argomentazioni<br />
del suo saggio: “Il cuore: problema<br />
umano delle città” risultano <strong>di</strong> “transizione”.<br />
Quasi un camuffamento.<br />
Nella prima parte dello scritto assistiamo<br />
alla terminologia consueta delle<br />
avanguar<strong>di</strong>e. Non manca il riferimento<br />
alla geometria, e ancor <strong>di</strong> più alla fisiologia<br />
e alla biologia (riferimenti antiaccademici<br />
per eccellenza) per porre successivamente<br />
in evidenza il valore della<br />
vita della “comunità”. Si avanza la similitu<strong>di</strong>ne<br />
fra il nocciolo (che contiene le<br />
sementi), con il cuore, che esprime e<br />
riassume il palpito del sentimento; ci si<br />
riferisce ad un lessico consumato all’interno<br />
del Movimento Moderno, derivato<br />
dalla pubblicistica ancora corbuseriana.<br />
Nel testo citato, Rogers, (sia pure con le<br />
cautele <strong>di</strong> rito), prende posizione contro<br />
le “fantasticherie astratte delle città ideali”,<br />
tracciando una linea <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa sulla<br />
conservazione dei centri storici, rimarcandone<br />
lo scempio dovuto all’obbrobrio<br />
della guerra ma anche alle vaniloquenti<br />
vestigia dell’Ecole de Beaux Arts:<br />
il nemico storico.<br />
Si tratta <strong>di</strong> formulazioni espresse in forma<br />
on<strong>di</strong>vaga, a metà strada fra il lessico<br />
vitruviano rinnovato, e il linguaggio dell’avanguar<strong>di</strong>a.<br />
Concetti che risulteranno,<br />
però, dal 1954, con la nuova Casabella-Continuità,<br />
puntuali e taglienti<br />
supporti ad una battaglia per la nuova<br />
architettura della città, perché espressi<br />
senza più le remore, anche linguistiche,<br />
del gruppo <strong>di</strong> appartenenza.<br />
A partire da “La responsabilità verso la<br />
tra<strong>di</strong>zione” a “Le preesistenze ambientali<br />
e i temi pratici contemporanei”, entrambi<br />
del 1954 fino alla relazione tenuta<br />
al l’INU il 23 marzo 1957 e all’inter-<br />
concorso per il nuovo<br />
Parlamento tedesco<br />
nell’area dello<br />
Spreebogen a Berlino,<br />
1992<br />
progetto:<br />
prof. Aurelio Cortesi<br />
(capogruppo)<br />
arch. Laura Andreini,<br />
Marco Casamonti,<br />
Isotta Cortesi,<br />
Giovanni Polazzi<br />
con Silvia Fabi,<br />
Laura Tartagli,<br />
Venturina<br />
47<br />
D O S S I E R