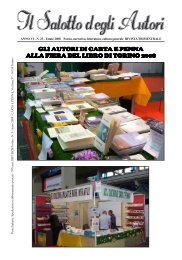muoiono se mangiano... ma non smetterebbero mai di mangiare!
muoiono se mangiano... ma non smetterebbero mai di mangiare!
muoiono se mangiano... ma non smetterebbero mai di mangiare!
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pri<strong>ma</strong>vera 2008<br />
DANTE DANTE ALIGHIERI<br />
ALIGHIERI<br />
OPERE OPERE MINORI<br />
MINORI<br />
<strong>di</strong> Carlo Alberto CALCAGNO (Arenzano - Ge)<br />
Questio florulenta ac perutilis de duobus elementis aquae et terrae<br />
Epistole<br />
For<strong>se</strong> Dante si recò a Mantova 1 nel 1319 e qui nacque,<br />
come ci racconta il poeta stesso 2 , una grossa <strong>di</strong>sputa, la<br />
quale egli volle poi trattare e definire in una conferenza<br />
nella chiesa <strong>di</strong> S. Elena a Verona il 20/01/1320 3 .<br />
Tale questione concerneva il fatto <strong>se</strong> l’acqua in qualche<br />
punto fos<strong>se</strong> più alta della terra, visto che per i dotti l’elemento<br />
più nobile deve stare <strong>se</strong>mpre in alto (fuoco su aria,<br />
aria su acqua, acqua su terra) 4 .<br />
Dante affronta l’argomento anche per rispondere alle<br />
critiche ricevute per la sua cosmografia dell’Inferno 5 ed è<br />
per la negativa: la terra è in ogni punto più alta dell’acqua,<br />
che pure è elemento più nobile, per l’attrazione e<strong>se</strong>rcitata<br />
dalle stelle; porta a sostegno delle sue considerazioni<br />
Aristotele, Tolomeo e Alfergano 6 oltreché ad esperienze<br />
<strong>di</strong> carattere fisico che hanno per il poeta la <strong>ma</strong>ggior<br />
importanza.<br />
La scienza <strong>di</strong> Dante tuttavia <strong>non</strong> supera quella del suo<br />
tempo <strong>non</strong>ostante porti qualche buona ragione (ad es. l’illusione<br />
dei naviganti in alto <strong>ma</strong>re <strong>di</strong> vedere la terra più<br />
bassa): l’opera tuttavia ha un valore storico perché fa il<br />
punto sullo stato delle conoscenze del <strong>se</strong>colo.<br />
Interessa anche la <strong>di</strong>chiarazione del poeta <strong>di</strong> es<strong>se</strong>re vissuto<br />
fin dalla puerizia nell’amore della verità e la condanna<br />
delle indagini volte a co<strong>se</strong> che trascendono il nostro<br />
intelletto.<br />
Il valore letterario è invece <strong>di</strong>scutibile: il latino utilizzato<br />
è piano e <strong>di</strong>messo, <strong>se</strong>ppure l’architettura del trattato<br />
sia armonica 7 .<br />
L’attribuzione a Dante è per alcuno 8 incerta perché la<br />
concezione dell’Inferno è contrastante ed inoltre i commentatori<br />
antichi hanno ignorato quest’opera che è stata<br />
ritrovata solo nel XVI <strong>se</strong>colo.<br />
Però c’è anche da rilevare che D. parlò della questione<br />
al clero <strong>di</strong> Verona (ne è testimone il figlio Pietro) e che<br />
l’Inferno e la Questio <strong>di</strong>vergerebbero solo perché il primo<br />
è frutto <strong>di</strong> invenzione fantastica.<br />
Dell’Alighieri si sono con<strong>se</strong>rvate poche epistole <strong>ma</strong><br />
quelle <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>sponiamo sono <strong>di</strong> grande importanza: <strong>di</strong>rette<br />
ad uomini pubblici importanti, <strong>di</strong>battono temi politici<br />
e sociali <strong>di</strong> grande attualità e ci con<strong>se</strong>gnano degli spaccati<br />
assai preziosi del <strong>se</strong>colo XIV.<br />
Nel <strong>ma</strong>rzo del 1304 D. scrive una lettera al Car<strong>di</strong>nale<br />
Niccolò <strong>di</strong> Prato a nome dei Bianchi fuoriusciti, perché il<br />
vescovo <strong>di</strong> Ostia e legato pontificio, riporti la pace in Firenze.<br />
In altra epistola si conduole con Guido e con Oberto<br />
da Romena della morte del loro zio Alessandro (estate<br />
- 13 -<br />
del 1304); è dubbio che appartenga a Dante perché questo<br />
Alessandro troverà posto nell’Inferno.<br />
Un’epistola anteriore al 1306 è <strong>di</strong>retta a Cino da Pistoia<br />
e ha ad oggetto la risposta ad una questione - posta da<br />
Cino con un sonetto - <strong>se</strong> l’ani<strong>ma</strong> possa passare dall’amore<br />
per una persona all’amore per un’altra con la stessa<br />
facoltà.<br />
D. risponde affer<strong>ma</strong>tivamente con il sonetto “Io sono<br />
stato con amore insieme” e spiega meglio nella lettera<br />
che la potenza dell’ani<strong>ma</strong> <strong>non</strong> si esaurisce in un atto e<br />
quando questo è compiuto essa passa ad un altro.<br />
Altre tre epistole, dallo stile polemico e personale (contrariamente<br />
a quanto richiesto dall’epistolografia latina)<br />
sono scritte in occasione della <strong>di</strong>scesa <strong>di</strong> Arrigo VII: una<br />
ai Principi <strong>di</strong> Italia: ai re d’Italia, ai signori dei feu<strong>di</strong>, ai<br />
<strong>se</strong>natori ro<strong>ma</strong>ni, perché accolgano l’Imperatore voluto da<br />
Dio (1310), un’altra «agli scelleratissimi fiorentini <strong>di</strong><br />
dentro» perché <strong>non</strong> resistano alla calata <strong>di</strong> Arrigo VII<br />
(1311); la terza all’Imperatore stesso, in uno stile solenne<br />
tanto quanto il destinatario cui tale epistola è rivolta (1311).<br />
Ancora nel 1311 Dante in<strong>di</strong>rizza un’epistola al <strong>ma</strong>rche<strong>se</strong><br />
Moroello Malaspina <strong>di</strong> Giovagallo: in essa confida all’amico<br />
che appena allontanato dalla Curia (quella del<br />
Marche<strong>se</strong> o <strong>di</strong> Arrigo VII) giun<strong>se</strong> sulle acque dell’Arno<br />
dove vide una donna che lo infiammò <strong>di</strong> una passione terribile<br />
(anche in questo caso for<strong>se</strong> si tratta <strong>di</strong> un’allegoria).<br />
Della pri<strong>ma</strong>vera del 1311 sono anche tre biglietti <strong>di</strong> ringraziamento<br />
scritti da Dante in nome della contessa<br />
Gherardesca <strong>di</strong> Battifolle (figlia del conte Ugolino) e destinati<br />
all’imperatrice Margherita (moglie <strong>di</strong> Arrigo VII).<br />
Altra epistola è <strong>di</strong>retta ai car<strong>di</strong>nali convenuti in conclave<br />
dopo la morte <strong>di</strong> Clemente V nel 1314, perché si accor<strong>di</strong>no<br />
ad eleggere un papa più degno (Clemente V aveva<br />
ingannato Arrigo VII) e soprattutto eleggano un pontefice<br />
italiano in modo che la <strong>se</strong>de <strong>di</strong> Pietro sia riportata a<br />
Ro<strong>ma</strong>.<br />
Del 1315 è invece un’epistola destinata ad un amico<br />
fiorentino (<strong>di</strong> valore inferiore rispetto a quelle scritte in<br />
occasione della calata <strong>di</strong> Arrigo VII) che il poeta <strong>non</strong> vuole<br />
nominare: D. scrive in occasione dell’amnistia concessa<br />
da Firenze, affer<strong>ma</strong>ndo <strong>di</strong> <strong>non</strong> volerne fruire poiché egli<br />
è <strong>se</strong>mpre stato innocente e quin<strong>di</strong> <strong>non</strong> ha intenzione <strong>di</strong><br />
piegarsi ad inutili umiliazioni, <strong>ma</strong> preferisce <strong>se</strong>guire la<br />
ragione che appunto gli impe<strong>di</strong>sce il ritorno.<br />
L’ulti<strong>ma</strong> epistola è <strong>di</strong>retta al signore <strong>di</strong> Verona<br />
Cangrande della Scala (Par., XVII, 76 e ss.) <strong>ma</strong> sull’autenticità<br />
i dantisti sono quanto <strong>ma</strong>i <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>; per contrac-