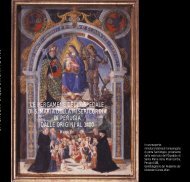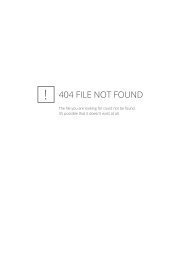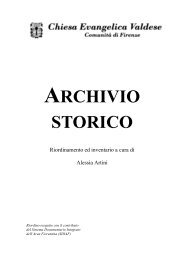ITALIA JUDAICA - Direzione generale per gli archivi
ITALIA JUDAICA - Direzione generale per gli archivi
ITALIA JUDAICA - Direzione generale per gli archivi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
90 Michele Luzzati<br />
Ma, detto questo, se vo<strong>gli</strong>amo radicalizzare il discorso, trascurando le molte<br />
sfumature che sarebbero necessarie, i Medici seguirono nei confronti de<strong>gli</strong> Ebrei<br />
una politica di favore che è sostanzialmente lineare. Intorno alla metà del secolo<br />
essi giocarono due carte <strong>per</strong> attirarli: i privilegi ai levantini ed i privilegi ai<br />
banchieri, nella s<strong>per</strong>anza che il loro effetto si rivelasse cumulativo. Ma né i<br />
Medici, né <strong>gli</strong> stessi Ebrei si resero conto con sufficiente tempestività che le<br />
due linee di privilegio non erano compatibili.<br />
Il privilegio del banco finì <strong>per</strong> imporsi, <strong>per</strong> ragioni sociali e culturali<br />
interne all'ebraismo (basti pensare alla quasi mitica figura del banchiere-medicorabbino-capo<br />
della comunità che metteva in ombra qualsiasi mercante, pur di<br />
rango internazionale), sul privilegio del commercio; e la difficoltà dei rapporti<br />
fra elemento ebraico centro-settentrionale, o italiano tout-court, ed elemento<br />
ebraico iberico condusse ad uno stallo. Gli Ebrei italiani, proprio attraverso i<br />
banchi di prestito, controllavano l'insediamento toscano e miravano a proporre<br />
piuttosto il modello dell'ebraismo padano che non quello dell'ebraismo mediterraneo.<br />
Ma i Medici guardavano al Mediterraneo, non all'Italia del Nord, ed<br />
i loro Ebrei avrebbero dovuto assomi<strong>gli</strong>are più ai levantini che ai banchieri<br />
mantovani o emiliani. Sce<strong>gli</strong>endo i banchi, e subordinando ai loro interessi <strong>gli</strong><br />
ebrei iberici, <strong>gli</strong> Ebrei toscani si misero fuori gioco e tradirono le aspettative<br />
granducali di un contributo ebraico alla rianimazione dell'economia toscana; si<br />
giunse così alla ghettizzazione, strumento che aveva lo scopo di metter più<br />
facilmente sotto controllo un insediamento «inquietante » che, conformemente<br />
all'ideologia e a<strong>gli</strong> interessi dei governanti, poteva meritare un diverso trattamento<br />
soltanto se avesse dimostrato di essere provata utilità allo Stato.<br />
Nonostante tutto questo, come abbiamo visto, la chiusura dello Stato nei<br />
confronti de<strong>gli</strong> Ebrei, e la chiusura de<strong>gli</strong> Ebrei nei confronti delle esigenze<br />
dello Stato, non furono assolute dopo il 1570-71 e, gradatamente, nel giro di<br />
soli vent'anni, ci si avviò a ritentare le strade del privilegio, questa volta di un<br />
solo privilegio, quello <strong>per</strong> il commercio e <strong>per</strong> i levantini, essi stessi probabilmente<br />
inclini a voler ridotta al minimo la presenza al loro fianco di Ebrei italiani.<br />
E il successo, come tutti sappiamo, fu strepitoso, <strong>per</strong> <strong>gli</strong> Ebrei e <strong>per</strong> il granducato<br />
di Toscana.<br />
Il paradosso - che non è in fondo tale, se riflettiamo sul fatto che ogni<br />
società, e quella ebraica non meno delle altre, coltiva al suo interno germi di<br />
sviluppo come germi di autodistruzione - è che soltanto la ghettizzazione<br />
dell'ebraismo indigeno consentì ai Medici di gettare le basi di un poderoso<br />
insediamento levantino.<br />
Sotto questa luce i ghetti di Firenze e di Siena, almeno nella loro origine<br />
storica, non sono una quasi incomprensibile negazione dei liberi insediamenti<br />
di Pisa e di Livorno, bensì parti integranti di un medesimo sistema, che esigeva<br />
il sacrificio di alcuni Ebrei, forse più colti e certo più radicati in Toscana, a<br />
favore di altri Ebrei, forse meno colti e senza radici locali, ma incomparabilmente<br />
più attivi e più legati al loro tempo.<br />
ALDO AGOSTO<br />
L'ARCHIVIO DI SThTO PI GENOVA<br />
E LE FONTI RELATIVE ALLA STORIA<br />
DEGLI EBREI GENOVESI DAL XV AL XVIII SECOLO<br />
Si può affermare che la documentazione relativa a<strong>gli</strong> Ebrei in Genova e<br />
nelle Riviere comincia ad apparire di un certo rilievo, e non più sporadica,<br />
a partire dalla fine del secolo XV, ossia dopo il 1492, quando si verificò la<br />
diaspora sefardita <strong>per</strong> l'espulsione « del popolo della legge » dal regno di Spagna,<br />
ma anche da quello di Francia e dai territori della Germania, in seguito alle<br />
leggi antigiudaiche allora emanate 1•<br />
Prima di quell'epoca i documenti registrano presenze di Ebrei di passaggio<br />
più che di stanza, come confermerebbe la ben nota lettera del 18 gennaio 1460,<br />
inviata dalla Signoria genovese al papa Pio II, che stava cercando decime <strong>per</strong><br />
la sua crociata contro i Turchi, nella quale si legge chiaramente in volgare:<br />
« Li Zudei non abitano qui » 2•<br />
Circostanza di rilievo è che in Genova <strong>gli</strong> Ebrei risultano dediti a piccoli<br />
commerci più che ad attività feneratizie, in quanto tali o<strong>per</strong>azioni erano già praticate<br />
in loco dai genovesi stessi. Infatti le qualifiche di « casanieri » e di « imprestieri<br />
», rilevabili da carte d'<strong>archivi</strong>o di recentissima individuazione, non lasciano<br />
dubbi di sorta: ormai sembra potersi estendere anche a questa accezione<br />
il famoso epiteto di Genuensis ergo mercator 3•<br />
* * *<br />
Studi specifici su documenti dell'Archivio di Stato di Genova sono stati<br />
condotti in diverse epoche e con vario grado di organicità ed approfondimento<br />
in rapporto ai termini temporali e spaziali delle indagini. Ricordiamo i bene-<br />
1 Per una informazione <strong>generale</strong> si veda: C. RoTH, The History of the Jews in Italy,<br />
Philadelphia 1946; A. MILANO, Storia de<strong>gli</strong> Ebrei in Italia, Torino 1963; C. BRIZZOLARI,<br />
Gli ebrei nella storia di Genova, Genova 1971, introduzione e capitoli I-IV.<br />
2 ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA [d'ora innanzi ASG], Archivio Segreto, Diversorum<br />
Communis Janue, filza 569, 18 gennaio 1460.<br />
6 ASG, Archivio Segreto, Politicorum, Regesti, b. 1647/1/31, 8-28 maggio 1432: sup·<br />
plica dei rappresentanti delle « Casane » al Doge di Genova <strong>per</strong> ottenere la conferma delle<br />
loro convenzioni e dei privilegi col decreto della chiesta provvigione; ibid., b. 1648/2/83,<br />
25 maggio 1481: supplica dei rappresentanti delle « Casane » i quali chiedono l'osservanza<br />
delle loro concessioni e privilegi col Comune di Genova e successivo decreto.