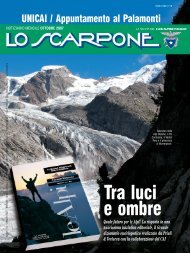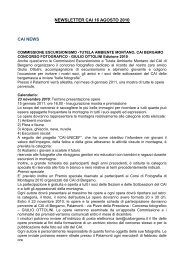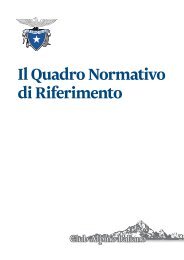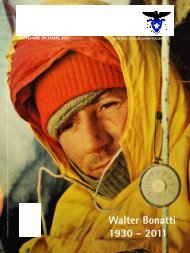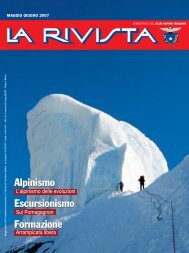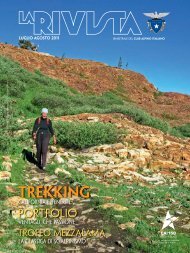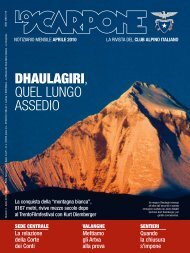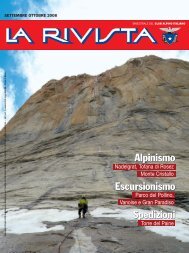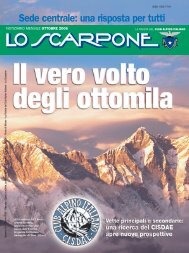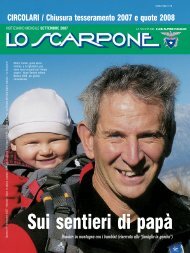luglio agosto - Club Alpino Italiano
luglio agosto - Club Alpino Italiano
luglio agosto - Club Alpino Italiano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LA RIVISTA 4 | 2010 21<br />
» "La sposa dell'aria",<br />
edito da Feltrinelli,<br />
l'ultimo libro di Marco<br />
Albino Ferrari.<br />
dalla cultura del momento.<br />
Le montagne<br />
sono immagini vuote<br />
(o meglio simboli),<br />
sulle quali proiettiamo<br />
le nostre aspettative.<br />
Sono appunto “simboli”<br />
cioè luoghi dove il<br />
materiale e l’immateriale<br />
convivono.»<br />
Facciamo un salto indietro<br />
nel tempo. Nel<br />
1999, per Corbaccio,<br />
esce il suo libro “Il<br />
vuoto alle spalle. Storia<br />
di Ettore Castiglioni”.<br />
Un grande alpinista,<br />
partigiano, morto sul ghiacciaio del Forno ai confini con<br />
la Svizzera. E la montagna non è solo lo sfondo naturale delle<br />
vicende narrate, ma ha un ruolo tragicamente determinante.<br />
«La storia di Ettore Castiglioni è la parabola di un misantropo<br />
riscattato. Castiglioni era un dandy, milanese, altolocato, colto<br />
e solitario, che aveva tagliato i ponti con il mondo. Andava in<br />
montagna per fuggire dalla mediocrità che lo circondava (siamo<br />
negli anni Trenta), criticando aspramente la retorica vitalistica<br />
che esaltava gli alpinisti indottrinati dal regime. Poi la svolta.<br />
Quando vide che grazie alle sue doti di alpinista avrebbe potuto<br />
dare la vita a chi fuggiva dall’Italia sconvolta della guerra, iniziò<br />
ad amare gli altri. Le stesse montagne che fino a quel momento<br />
rappresentavano la fuga dagli uomini, erano diventate la soglia<br />
oltre la quale si poteva dare la vita agli uomini. Non si è risparmiato.<br />
Ed è morto.»<br />
Nel 2002, sempre per Corbaccio, pubblica “Terraferma”. Anche<br />
in questo caso, è la natura a determinare le coordinate di una<br />
vicenda storica ambientata nella Terra del Fuoco.<br />
«A metà Ottocento la Terra del Fuoco era ancora un luogo da<br />
“evangelizzare”. Ci avevano messo gli occhi anche i missionari<br />
anglicani. Partiti da Plymouth e attraversato l’oceano, approcciavano<br />
le popolazioni Yagan brandendo la Bibbia e alzando<br />
canti sacri nella speranza di essere accolti. Venivano sterminati.<br />
A ondate. Ma a quei missionari il rischio non faceva paura, anzi<br />
pensavano che la “bella morte”, lontano da casa, «cantando inni<br />
al Signore» avrebbe dato senso ultimo alla loro esistenza. Erano<br />
estremisti romantici. Riuscì nell’intento un missionario sui generis,<br />
Thomas Bridges, che prima di tentare il passo decise di imparare<br />
lingua e costumi locali. Ebbe perciò un approccio morbido.<br />
Alla fine venne accettato, ma il contatto fu fatale per gli stessi<br />
Yagan. Thomas Bridges portava con se i germi dell’influenza che<br />
avrebbero decimato la popolazione vulnerabile alla nuova malattia.<br />
“Terraferma” è la storia di un dialogo impossibile.»<br />
Naturalmente l’alpinismo ha un ruolo centrale nella sua<br />
avventura letteraria. Nel caso di “Frêney 1961 – Tragedia sul<br />
Monte Bianco” (Corbaccio), la montagna mette sul piatto tutta<br />
la potenza degli elementi naturali, di fronte ai quali l’uomo<br />
è poca cosa.<br />
«“Frêney 1961” uscì per la prima volta nel 1996 presso l’editore<br />
Vivalda. E continua ad essere ristampato (l’anno scorso da Corbaccio).<br />
Si può dire che sia ormai diventato un classico della letteratura<br />
di montagna. La forza del libro sta nella storia, una storia<br />
esemplare che ci restituisce il senso dell’alpinismo classico nei suoi<br />
ultimi bagliori. Una storia di cinquant’anni fa, ma che ci sembra<br />
ancora più lontana, persa in un’Italia ingenua, l’Italia del Boom<br />
economico, che rimase incollata alla radio per conoscere gli esiti di<br />
ciò che accadeva sul Monte Bianco.»<br />
In “Dolomiti, rocce e fantasmi” (Excelsior 1881 editore), indaga<br />
sulla perdita di un mondo che non potrà mai più tornare e propone<br />
il tema del “tempo circolare”.<br />
«Nelle società tradizionali delle Alpi ciò che scandiva il tempo era il<br />
calendario liturgico: un vero Codice dell’Ordine. E i giorni vivevano<br />
come ricorrenze, in un immutabile ciclo dell’esistenza. Al centro<br />
c’era l’idea del tempo circolare: ogni giorno gemello al giorno corrispondente<br />
dell’anno precedente, scandito dal nome di un santo.<br />
In questa idea del tempo, non come flusso di un costante progresso<br />
ma di una circolarità che tende a ripetersi sempre uguale, è posta<br />
in primo piano la ricerca di stabilità che sfocia, per esempio, nella<br />
conservazione di un equilibrio duraturo con la montagna. Quello<br />
non è un tempo che corre come il nostro, ma è un tempo che ricorre.<br />
Penso però che capire questo concetto aiuti a vedere la montagna<br />
come è stata per secoli: chi ha raccontato bene tutto questo è<br />
l’etnografo autodidatta Giuseppe Šebesta, fondatore del Museo di<br />
San Michele all’Adige.»<br />
Perché la narrativa che ha per protagonista la montagna fatica<br />
a trovare lettori che non siano per forza appassionati di<br />
alpinismo?<br />
«Parliamo di un genere spesso autoreferenziale. C’è una produzione<br />
molto vasta di libri scritti da alpinisti che sentono l’urgenza di raccontarsi,<br />
scrivere diventa per loro quasi una necessità: così, però, sì<br />
rischia di scrivere più per sé stessi che per il lettore.»<br />
Come ogni alpinista, anche lei ha una personalissima hit parade<br />
delle montagne preferite. Nel suo libro “In viaggio sulle Alpi.<br />
Luoghi e storie d’alta quota” (Einaudi) traccia il ritratto delle<br />
dieci vette più importanti dell’arco alpino.<br />
«Come ho detto mi interessa la simbologia legata alla montagna.<br />
Ogni montagna è portatrice di qualcos’altro, qualcosa che sta fuori<br />
da essa, che noi le attribuiamo.»<br />
Nei suoi libri la visione che i personaggi hanno della montagna<br />
è duplice: di attrazione o di repulsione. È una metafora per<br />
la vita?<br />
«Questa duplicità tra attrazione e repulsione è alla base del sentimento<br />
moderno che ci lega alla montagna e in generale a tutti<br />
i luoghi selvaggi, oceani, vulcani, deserti. È l’estetica del sublime.<br />
L’alta montagna è inospitale, ostile, evoca il pericolo, eppure<br />
la guardiamo sedotti. Ci fa paura ma la cerchiamo. In questo senso<br />
la montagna diventa il mezzo che ci fa scoprire l’ebbrezza di perdersi<br />
nel tutto.» «