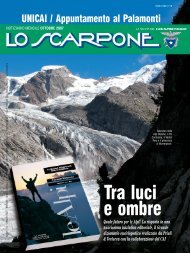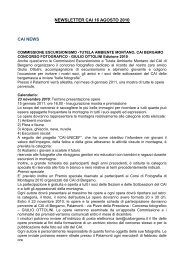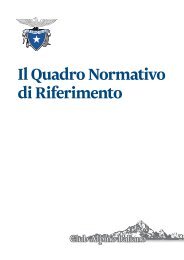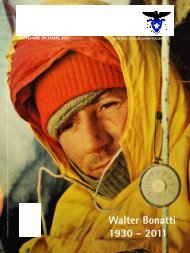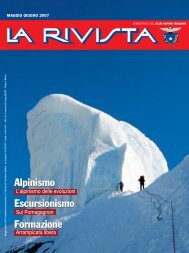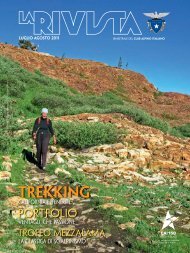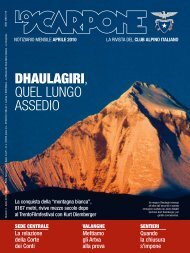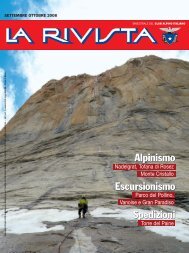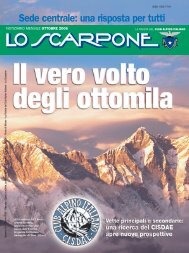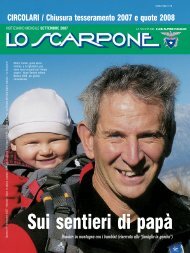luglio agosto - Club Alpino Italiano
luglio agosto - Club Alpino Italiano
luglio agosto - Club Alpino Italiano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
» PuNTI DI VISTA<br />
In primo luogo: qualsiasi cima va relativizzata nel tempo, non<br />
solo per i differenti suoi assetti metamorfici (in dipendenza,<br />
ad es., di formazioni di ghiaccio, di crolli di roccia, ecc.), ma<br />
anche per le differenti culture e tecniche di differenti epoche<br />
dell’“alpinismo”.<br />
Il Cerro Torre del 2005 e del 2008, di Ermanno Salvaterra, di<br />
Rolando Garibotti, di Alessandro Beltrami, di Colin Haley, non<br />
è quello del 1959 di Cesare Maestri e Toni Egger, né quello del<br />
1970 di Cesare Maestri.<br />
In secondo luogo: le “possibilità” alpinistiche con riguardo<br />
ad una vetta variano nel tempo. Varia, pertanto, la “misura”<br />
di esse: quale si può mettere a punto solo per “tentativi” (è<br />
qui la radice dell’importanza del saper “tentare” ciò che pare<br />
“impossibile”).<br />
Il cerro Torre giudicato “impossibile” al tempo di Lionel Terray<br />
è oggi “possibile”, ancorché “estremo”.<br />
Così stando le cose, se ne cavano due importanti conclusioni:<br />
prima, le misure dell’“impossibile” sono storiche, e diventano<br />
un criterio per giudicare la concreta “fattibilità” di una cima in<br />
una data epoca (così ciò che è “storicamente” impossibile per<br />
il Cerro Torre del 1959 non è la montagna in sé, ma il modo<br />
con cui Maestri pretende di essere salito); seconda, lo storico è<br />
irresistibilmente attratto dalla ricerca critica della “documentazione”<br />
di tali “possibilità” di fronte alle sfide di fatti che si<br />
prospettano come possibilità immaginate, ma non documentate<br />
(come nel caso di Mallory all’Everest nel 1924 o di Cesen nel<br />
1990 al Lhotse).<br />
In terzo luogo: le vette più rilevanti come sfide nel gioco della<br />
ricerca del “possibile” nell’“impossibile” si trovano, da un punto<br />
di vista “alpinistico”, ad “avere un passato”, fatto anche di<br />
tentativi falliti, tanto più “grandi” nel loro significato, quanto<br />
più capaci di aprire nuovi orizzonti di ricerca di superamenti<br />
del limite (ogni volta “storicamente” diversi). In questo senso<br />
è importante il riconoscimento che Messner fa dell’importanza<br />
del “tentativo” di Maestri-Egger al Cerro Torre nel 1959.<br />
Ogni alpinista, che sia capace di confrontarsi con il mistero<br />
dell’“ignoto” o dell’“estremo”, sa valersi anche della ricostruzione<br />
“storica” di quel passato delle vette che è costituito dalle<br />
vie, tentate o riuscite, dei “precursori” e di cui si compone il<br />
significato “alpinistico” di una vetta. Di qui segue l’importanza<br />
della storia per fare alpinismo.<br />
Punto terzo: un aspetto cruciale della ricerca “storica”, quando<br />
di un fatto in questione non si hanno “documentazioni” che<br />
prescindano dal racconto di un singolo sopravvissuto, è quello<br />
che consiste nel riscontrare quel “racconto” con la realtà della<br />
montagna, per controllarne la coerenza con l’assetto dei luoghi,<br />
con quello delle attrezzature, ecc.<br />
In tale esame accade talvolta che la stessa versione dei presunti<br />
fatti, quale data da chi se ne propone come protagonista, diventi,<br />
essa stessa, la sua più decisiva smentita (così è accaduto<br />
anche nel “caso” più sopra ricordato del K2).<br />
È, questo, un aspetto “storico” non meno rilevante di altre questioni<br />
critiche, attinenti aspetti tecno-alpinistici che presentano<br />
più o meno evidenti “illogicità”.<br />
Con tali questioni “storiche” si intrecciano nel libro di Messner<br />
anche precise questioni “filosofiche”, propriamente di “filosofia”<br />
dell’alpinismo.<br />
Primo, cos’è una via di salita? Intenderla come un’“opera<br />
4 | 2010 62<br />
d’arte” è una delle modalità fondamentali per portare “rispetto”<br />
alla montagna, rifiutando qualsiasi pretesa di “conquista”<br />
e sostituendo, per contro, ad essa l’intento di realizzare un’“interpretazione”<br />
della parete rocciosa come una via da percorrere<br />
nel gioco di tentare di rendere possibile l’impossibile, in un<br />
confronto principalmente con sé stessi, con le proprie risorse<br />
vitali, spesso ignote o dimenticate, con la ricerca di un proprio<br />
“stile”, con la propria capacità di “reinventarsi” attraverso l’avventura<br />
nella natura.<br />
Non ci sono vincoli alla libertà di immaginare un’arrampicata,<br />
come accade in arte; ma c’è una radicale differenza: l’arte è<br />
auto-sufficiente con l’immagine, l’idea di un’arrampicata va,<br />
invece, confrontata con un concreto tentativo di realizzazione<br />
“a tu per tu” con la montagna.<br />
Secondo, quale è l’approccio adeguato a “interpretare” la sfida<br />
alla salita?<br />
La risposta è inequivocabile: è decisivo portare “rispetto” alla<br />
montagna; è decisivo escludere ogni pretesa di “conquista”,<br />
ogni “volontà di vittoria”, anche perché con esse svanisce il<br />
mistero.<br />
Di qui segue l’importanza del tentativo anche senza il raggiungimento<br />
(purché sia coltivato con una “speranza” capace di<br />
serietà di studio della sua concreta realizzabilità).<br />
Terzo, quale “etica” si richiede in coerenza con tale concezione<br />
dell’“alpinismo”?<br />
Non si può pretendere di imporre ad altri un’etica che sia staccata<br />
dalla diversa storia di ciascuno: tuttavia occorre, quanto<br />
meno, che chi per propria libertà sceglie una propria maniera di<br />
“scalare”, non cerchi poi di farla passare per un’azione ispirata<br />
all’“amore” alla montagna, se non ha le “carte in regola” del<br />
“rispetto” della montagna.<br />
Occorre non fare “idealismo” delle proprie ambizioni di successo.<br />
Occorre assumersi responsabilità nel proprio modo di agire.<br />
Di qui segue anche che, per coerenza con l’idea del “rispetto”,<br />
occorre far propria la scelta di “salire” “by fair means”.<br />
Tali aspetti “filosofici” ed anche “etici” si ritrovano palpitanti<br />
“al vivo” in tutte le pagine del libro di Messner: scritto con un<br />
ritmo che ricorda quello del suo passo, rapido, deciso, sicuro.<br />
Sono, questi, alcuni dei punti salienti di questo mirabile libro di<br />
Messner che credo di grande importanza per la cultura dell’“alpinismo”<br />
di cui il CAI deve farsi promotore e custode.<br />
Non tralascio, infine, di segnalare che alla figura d’alpinista di<br />
Toni Egger, una sorta di incarnazione della passione, vissuta<br />
nella sua concretezza attraverso la realizzazione di avventure<br />
“al limite”, senza “idealizzazioni” né “eroicizzazioni”, Messner<br />
dedica alcune agili, puntuali ed efficaci pagine di storia, ponendo<br />
in risalto alcune delle sue più importanti salite (come<br />
quella allo Jirishanca, in Perù, nel 1957, una montagna la cui<br />
immagine stessa è al limite della fantasticità).<br />
Mirabile anche la rievocazione della personalità di Toni Egger<br />
quale ricostruita anche attraverso la testimonianza di Lore<br />
Stötter, che condivise con lui anche alcune arrampicate: una<br />
fila di ricordi che risalgono fino a quando il giovane Toni faceva<br />
il boscaiolo in Tirolo, in Baviera, in Svizzera.<br />
Così Messner rende l’ossequio della storia a Toni Egger, che<br />
era stato ingiustamente per lo più dimenticato. Anche questo<br />
è un pregio prezioso del libro, che, appunto, a Toni Egger è<br />
dedicato. «