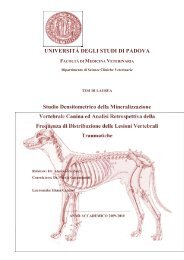Studio sulla presenza della lince - Università degli Studi di Padova
Studio sulla presenza della lince - Università degli Studi di Padova
Studio sulla presenza della lince - Università degli Studi di Padova
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
I motivi che hanno portato a questa situazione critica sono da attribuirsi<br />
prevalentemente all’uomo. Come risultato dello sfruttamento delle foreste e<br />
dell’espansione <strong>di</strong> aree coltivate si ebbe un’alterazione <strong>degli</strong> ecosistemi, con<br />
<strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> siti <strong>di</strong> rifugio, interruzione <strong>di</strong> areali e riduzione <strong>di</strong> risorse alimentari.<br />
Infine vennero effettuati abbattimenti <strong>di</strong>retti nei confronti <strong>di</strong> questi animali, ritenuti<br />
dannosi per il bestiame e competitori nella caccia.<br />
Dopo<strong>di</strong>chè è cominciata una lenta ripresa grazie ad una sensibilizzazione<br />
dell’uomo nei confronti <strong>di</strong> specie a rischio d’estinzione, a programmi <strong>di</strong><br />
reintroduzione e all’incremento del numero <strong>di</strong> ungulati.<br />
Attualmente la specie è <strong>di</strong>stribuita uniformemente nei Paesi Scan<strong>di</strong>navi e in<br />
Russia, mentre popolazioni isolate e frammentate si mantengono in Europa<br />
centro-occidentale e meri<strong>di</strong>onale (Breitenmoser et al., 2000).<br />
In Svizzera (dal 1971 al 1976) e Slovenia (1973) si attuarono delle operazioni <strong>di</strong><br />
reintroduzione che furono coronate da un successo, giunto anche oltre le<br />
aspettative. Inizialmente non incontrarono il favore dell’opinione venatoria, a<br />
causa <strong>della</strong> elevata pressione predatoria <strong>di</strong> questi animali sulle popolazioni <strong>di</strong><br />
ungulati, ma negli anni l’atteggiamento si fece più tollerante.<br />
Dopo le reintroduzioni in Svizzera e in Slovenia si tentò <strong>di</strong> attuarne ancora in altri<br />
Paesi, ma senza (o con poco) successo: in Italia nel 1975, in Austria dal 1976 al<br />
1979, infine in Francia e in Baviera.<br />
Fino a tutti gli anni ottanta le neopopolazioni provenienti da Slovenia e Svizzera<br />
<strong>di</strong>edero prova <strong>di</strong> una crescita molto consistente, anche se successivamente<br />
l’espansione subì un rallentamento, per riprendere solo in tempi recenti .<br />
Nel caso svizzero, la popolazione si espanse anche sulle Alpi francesi, dove la<br />
<strong>lince</strong> era scomparsa all’inizio del ventesimo secolo. In questo modo anche in<br />
Francia nel giro <strong>di</strong> un ventennio si è osservato un incremento demografico<br />
generale, con conseguente espansione <strong>della</strong> specie verso il sud del paese <strong>di</strong><br />
circa 200km, anche se in aree <strong>di</strong>scontinue e con osservazioni frammentarie (Stahl<br />
e Vandel, 1998).<br />
Oggigiorno le popolazioni <strong>di</strong> linci alpine consistono in 2 principali sottopopolazioni<br />
originate dalle suddette reintroduzioni e le 2 core area si trovano nelle Alpi<br />
occidentali (Svizzera e Francia) e nelle Alpi <strong>della</strong> Slovenia.<br />
In Italia le popolazioni <strong>di</strong> linci autoctone scomparvero tra la fine del XIX secolo ed il primo<br />
quarto del XX secolo (Ragni et al., 1987; Ragni et al., 1998); gli ultimi abbattimenti noti<br />
nella zona delle Alpi Orientali risalgono al 1872 in Alto A<strong>di</strong>ge.<br />
Il primo segno <strong>di</strong> un evidente ritorno, a partire dall’area alpina orientale, <strong>della</strong> specie si<br />
ebbe nei primi anni ’80, come risultato delle reintroduzioni effettuate negli anni ’70 dai<br />
paesi confinanti (Austria, Slovenia, Svizzera). Segnalazioni frammentarie si sono avute in<br />
Trentino Alto A<strong>di</strong>ge, Val d’Aosta, Piemonte (Val d’Ossola), Veneto (provincia <strong>di</strong> Belluno) e<br />
Friuli V.G. (Molinari et al., 2001; Ragni et al., 1987).<br />
Per quanto concerne il Friuli Venezia Giulia (Alpi Giulie) il primo segno <strong>di</strong><br />
<strong>presenza</strong> <strong>della</strong> <strong>lince</strong> risale al 1979 e rimase un caso isolato per <strong>di</strong>versi anni. Non<br />
è mai stato possibile definire da quale popolazione, se quella austriaca o quella<br />
slovena, derivasse tale animale.<br />
La colonizzazione <strong>della</strong> <strong>lince</strong> in Friuli sembrò inizialmente seguire due <strong>di</strong>rettrici<br />
preferenziali <strong>di</strong> spostamento <strong>degli</strong> in<strong>di</strong>vidui migranti, centrate sul Carso triestino-goriziano<br />
e sulle Prealpi Giulie (Ragni et al., 1987). La prima segnalazione certa è datata<br />
1989, anno nel quale viene fotografato un in<strong>di</strong>viduo che preda una marmotta<br />
nelle Alpi carniche a nord <strong>di</strong> Pontebba.<br />
Il primo stu<strong>di</strong>o intensivo svolto riguardo la <strong>presenza</strong> <strong>della</strong> <strong>lince</strong> in Friuli Venezia<br />
Giulia si è fondato <strong>sulla</strong> catalogazione e la successiva analisi <strong>di</strong> tutti i segni <strong>di</strong><br />
<strong>presenza</strong> dal 1986 al 1995 (Molinari, 1998). In particolare l’area principale <strong>di</strong><br />
raccolta dati comprendeva il tarvisiano e in maniera meno accurata il resto <strong>della</strong><br />
regione. I meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> rilevamento come: transetti prevalentemente su neve,<br />
sopralluoghi nelle località nelle quali fosse stata segnalata la <strong>lince</strong> e uso <strong>di</strong><br />
3