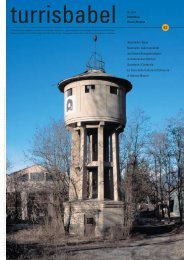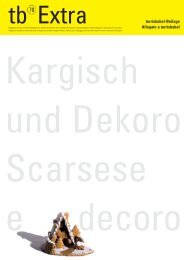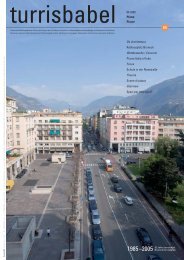Download turrisbabel 69
Download turrisbabel 69
Download turrisbabel 69
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>turrisbabel</strong> <strong>69</strong> März Marzo 2006 Statements 17<br />
Particelle di posizione:<br />
Nella lingua ladina,<br />
l’essere “qui” di un oggetto<br />
viene espresso in<br />
relazione alla struttura del<br />
suolo (in orizzontale) e<br />
rispetto al suo intorno<br />
immediato (in verticale).<br />
Loredana Ponticelli<br />
Paesaggi_Linguaggi<br />
C’è un nesso stretto fra la rappresentazione<br />
mentale dello spazio dove si vive e<br />
la rappresentazione di sé. L’identità di un<br />
territorio è data, in primis, dal dominio del<br />
proprio spazio abitabile tramite pratiche la<br />
cui efficacia è convalidata dall’esperienza.<br />
Questo fatto si pone con molta chiarezza<br />
nei territori abitati da culture di tradizione<br />
orale: lingua e spazio esistono e acquistano<br />
senso solo praticandoli. Parlare la lingua<br />
del luogo è porre in essere un processo di<br />
rappresentazione dello spazio, che si alimenta<br />
con la proiezione di sé sul territorio.<br />
Questo circolo virtuoso fra rappresentazione<br />
dello spazio e rappresentazione di sé è<br />
un vero e proprio processo di produzione<br />
del territorio. C’è infatti una stretta analogia<br />
fra le strutture logiche del “parlare” e<br />
le strutture organizzative dell’“abitare” il<br />
territorio, ma il catalizzatore che fa reagire<br />
l’insieme, è rappresentato dal forte investimento<br />
simbolico – individuale e collettivo –<br />
che continuamente si proietta sul paesaggio.<br />
Paesaggi frattali<br />
La visione che un gruppo ha dello spazio<br />
si imprime infatti nelle strutture della sua<br />
lingua. Le lingue variano molto in relazione<br />
alla necessità di veicolare informazioni spaziali<br />
e quelle delle comunità montane sono<br />
particolarmente ricche e precise. Infatti,<br />
nel caso di uno spazio “spiegazzato” come<br />
quello di una valle montana, le categorie<br />
grammaticali – per essere espressive – devono<br />
mettere in atto strategie particolarmente<br />
sottili, che si specializzano per una<br />
struttura così complessa. Prendiamo un<br />
caso paradigmatico: le Dolomiti. Qui abbiamo<br />
una situazione molto particolare: una<br />
lingua a prevalente tradizione orale, il ladino,<br />
espressione di una cultura fortemente<br />
materiale e tuttavia identificabile con un<br />
territorio ed una popolazione assolutamente<br />
immersi nella contemporaneità. Queste<br />
montagne – da secoli abitate e “sottoposte”<br />
alla responsabilità di società contadine –<br />
nel giro di pochi decenni hanno subìto (ma<br />
anche scelto) lo stress di un processo di<br />
fortissimo rinnovamento socio-economico<br />
in senso urbano. Sotto l’immagine consunta<br />
e un pò oleografica che lega queste<br />
montagne allo jodel e ai gerani sul balcone,<br />
ci sono infatti dei territori specialistici<br />
in cui la competizione è feroce, dove nell’alta<br />
stagione la pressione demografica è<br />
fortissima, dove il consumo – anche culturale<br />
– del paesaggio è la base dell’economia.<br />
In questi territori “plurimi”, l’accostamento<br />
e la sovrapposizione di diverse percezioni<br />
dello spazio (quella interna della lingua del<br />
luogo e quella esterna delle lingue cosiddette<br />
“di relazione”), rivela la coesistenza<br />
di immaginari del territorio fra loro del<br />
tutto diversi, la cui convivenza è conflittuale<br />
e tuttavia possibile. Ogni singola valle<br />
non rivela un paesaggio unico, ma piuttosto<br />
un paesaggio multiplo, frattale.