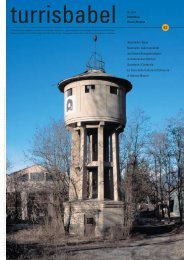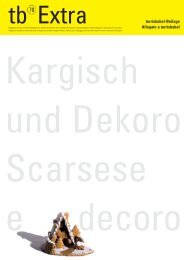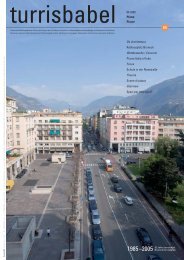Download turrisbabel 69
Download turrisbabel 69
Download turrisbabel 69
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>turrisbabel</strong> <strong>69</strong> März Marzo 2006 Paesaggi_Linguaggi – Statements 21<br />
Mappa di preposizioni:<br />
schema anti-tipologico per<br />
classificare i rapporti fra<br />
oggetti (a sinistra) e fra gli<br />
oggetti e il suolo (a<br />
destra), esplicitato per<br />
mezzo di preposizioni.<br />
Strategie di relazione<br />
Tuttavia, proprio perché si basa sulla<br />
struttura degli spazi aperti, la cultura di<br />
montagna – “dimensione” paesaggistica<br />
per eccellenza – non ha mai sentito la<br />
necessità di elaborare un’estetica del paesaggio.<br />
Tant’è che, cercando nel lessico<br />
delle lingue locali, è difficile trovare persino<br />
il termine “indigeno” per denominarlo<br />
esattamente. Non è una semplice questione<br />
lessicale ma una vera e propria visione<br />
del mondo. Ad esempio, nel caso del ladino<br />
dolomitico, il termine che più si avvicina<br />
al significato di “paesaggio” è contràda<br />
che può significare anche “via, strada<br />
cittadina”. L’interpretazione etimologica<br />
che ne dà il catalano J. Coromines è piuttosto<br />
interessante. La forma originaria<br />
non sarebbe contrata (da contra “ambito<br />
di fronte all’osservatore”) ma encontrata:<br />
“territorio nel quale ci incontriamo, nel<br />
quale ci troviamo tutti insieme”. L’idea che<br />
il paesaggio sia percepito psicologicamente<br />
non come un luogo da osservare ma<br />
come il luogo dove ci si incontra e dove<br />
si stabiliscono delle relazioni che rafforzano<br />
i legami sociali, è molto significativa.<br />
Anche l’ambivalenza del significato di “paesaggio”<br />
e “strada” è piuttosto interessante.<br />
Non solo indica l’idea che il concetto di<br />
paesaggio si può accostare a quello di<br />
“opera”, cioè di costruzione artificiale dall’uomo,<br />
ma si potrebbe addirittura ipotizzare<br />
che nell’immaginario montano non<br />
ci sia contraddizione fra strada e paesaggio<br />
quando si considerano anche nel loro<br />
valore funzionale, cioè come “(infra)strutture<br />
di relazione”.<br />
In montagna il paesaggio, al pari del linguaggio,<br />
è piuttosto una “strategia di relazione”<br />
fra uomo e spazio aperto. Nella lingua<br />
infatti, le forme che meglio esprimono<br />
le relazioni sono le preposizioni ed è davvero<br />
sorprendente il numero di preposizioni<br />
e avverbi di luogo della grammatica delle<br />
lingue montane (retoromanze ma anche alemanno-baiuvare)<br />
così come stupisce la ricchezza<br />
delle loro possibilità combinatorie.<br />
Allo stesso modo, meraviglia l’“appropriatezza”<br />
lessicale, cioè la notevolissima varietà<br />
terminologica che rende possibile classificare<br />
esattamente un vastissimo repertorio<br />
di “tipologie paesaggistiche” oltre che archi-<br />
tettoniche. Le lingue montane esprimono<br />
una grande raffinatezza percettiva e allo<br />
stesso tempo sono linguaggi “tecnici”, specifici<br />
per questo tipo di struttura spaziale<br />
del territorio. Allo stesso modo lo spazio,<br />
“destrutturato” attraverso l’analisi del linguaggio<br />
del luogo, rivela completamente<br />
la sua struttura frammentata, fessurata,<br />
interrotta, spiegazzata. Rivela un paesaggio<br />
che per essere vissuto necessita innanzitutto<br />
di relazioni. Per questo, la cultura<br />
montana non riconosce la sua identità<br />
nell’immagine dei luoghi ma nel tipo di<br />
relazioni con i luoghi. La sua originalità si<br />
basa nell’eredità di un rapporto simbiotico<br />
con lo spazio aperto ed è proprio per questo,<br />
che la cultura montana è portatrice<br />
di una concezione di paesaggio che non<br />
è (solo) di natura estetica.<br />
Questo spostamento dell’attenzione dalle<br />
forme alle relazioni è un punto davvero<br />
nodale nel caso della montagna turistica.<br />
La necessità di mettere in scena un’identità<br />
“organizzata” ha permeato a tal punto l’immaginario<br />
turistico e locale da diventare il<br />
problema principale della programmazione<br />
urbanistica non solo dei centri storici ma anche<br />
del territorio aperto. L’attenzione si concentra<br />
sull’elemento più evidente e come<br />
conseguenza – complice un certo pregiudizio<br />
culturale che vede il pittoresco ed il kitsch<br />
come un nemico da combattere all’ultimo<br />
sangue – le energie si disperdono nello stabilire<br />
le forme e le dimensioni consigliate<br />
per le verande e le aperture, il disegno dei<br />
balconi, la geometria dei tetti, l’articolazione<br />
dei volumi e così via. Ci si ferma all’immagine<br />
dei luoghi e, nel tentativo di preservarne<br />
una certa originalità, non si fa altro che<br />
perseguire la mistificazione del “falso autentico”,<br />
processo che peraltro continua comunque.<br />
Insomma: si sbaglia obiettivo.<br />
Considerare il sistema reale di reciprocità<br />
che lega lingua, spazio e insediamento aiuta<br />
invece a rivelare l’identità “naturale” dei luoghi,<br />
che è poco visibile proprio perché risiede<br />
nei rapporti e non nelle forme. In altre<br />
parole, è tenendo presenti i caratteri e<br />
le “limitazioni” del caso specifico che si può<br />
pensare una continuità culturale capace di<br />
strutturare veramente lo spazio. Oppure si<br />
può continuare a guardare il tema da fuori, e<br />
insistere nell’occuparsi di abbaini e fioriere.