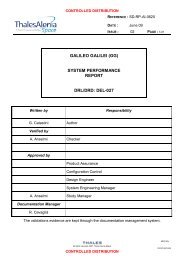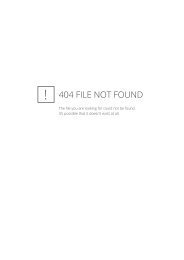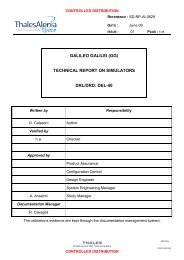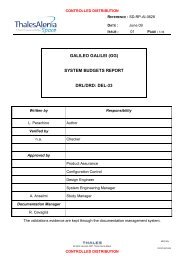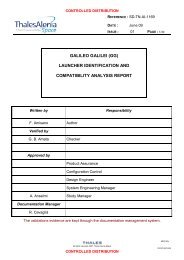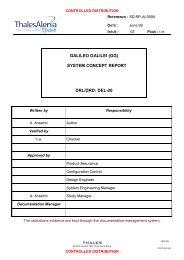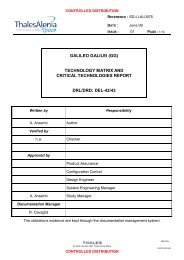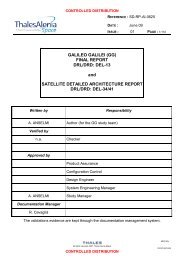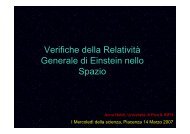Sommario 1. Fisica, metodo scientifico, grandezze fisiche ...
Sommario 1. Fisica, metodo scientifico, grandezze fisiche ...
Sommario 1. Fisica, metodo scientifico, grandezze fisiche ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Anna Nobili, Pisa 19 Maggio 2011dd(ssssssss)dddd= θθ̇ccccccccdd(cccccccc)dddd= −θθ̇ssssssss (4.40)dd 2 (ssssssss)ddtt 2= dd(cccccccc)dddd= −θθ̇ 2 ssssssssdd 2 (cccccccc)ddtt 2= dd(ssssssss)dddd= −θθ̇ 2 cccccccc (4.41)e θθ̇ ha le dimensioni di rrrrrr/ss , cioè si tratta una velocità angolare, che indichiamo con il simbolo ωω.Proviamo perciò a scrivere una soluzione dell’equazione del moto del pendolo (4.37) come:θθ = θθ oo cccccccccc (4.42)(at tempo tt = 0 il pendolo è spostato rispetto alla verticale di un angolo θθ oo ). Inserendola nell’equazionedel moto abbiamo:θθ̇ = −ωωθθ oo ssssssssss θθ̈ = −ωω 2 θθ oo cccccccccc ee ccccccè θθ̈ = −ωω 2 θθ ee ccccccè θθ̈ + ωω 2 θθ = 0 (4.43)Abbiamo quindi trovato una soluzione dell’equazione del pendolo (4.37) −equazione valida solo per piccoleoscillazioni− del tipo θθ = θθ oo cccccccccc dove θθ oo è l’angolo di spostamento dalla verticale all’istante iniziale evale:ωω 2 = gg l, ωω = gg l(4.44)cioè ωω = gg/l è la velocità angolare del pendolo, e quindi il suo periodo di oscillazione (= il tempoimpiegato per fare un giro completo di 2ππ radianti andando alla velocità angolare ωω) è:TT = 2222 ll gg(4.45)che risulta dipendere soltanto dalla lunghezza del filo di sospensione (oltre che dalla locale accelerazione digravità), ma non dalla ampiezza delle oscillazioni.Sebbene questo sia vero solo per piccole oscillazioni (quando il moto è descritto dall’equazione (4.37), incui ssssssss è stato sostituito da θθ ), si tratta di una scoperta fondamentale (fatta da Galileo, probabilmentenel Duomo di Pisa osservando il moto dei candelabri appesi a dall’altissimo soffitto e rilasciato dopol’accensione). L’importanza della scoperta sta nel fatto di poter disporre di un “oggetto” che compie lastessa azione in maniera ripetitiva e ad un tasso di ripetitività regolare, cioè di un orologio che infatti doponon molti anni (ma Galileo era già morto), una volta reso di dimensioni modeste e risolto il problema dimantenere le oscillazioni (con la carica), entrò in moltissime case. E fu la prima volta nella storia che unorologio piuttosto preciso divenne alla portata di quasi tutti.5. Lavoro ed energiaIn un tempo infinitesimo dddd un corpo compie uno spostamento infinitesimo dss⃗ e su di esso agisce unaforza (totale) FF⃗. Definiamo ddL:ddL = FF⃗ ⋅ dddd ⃗ (5.1)24