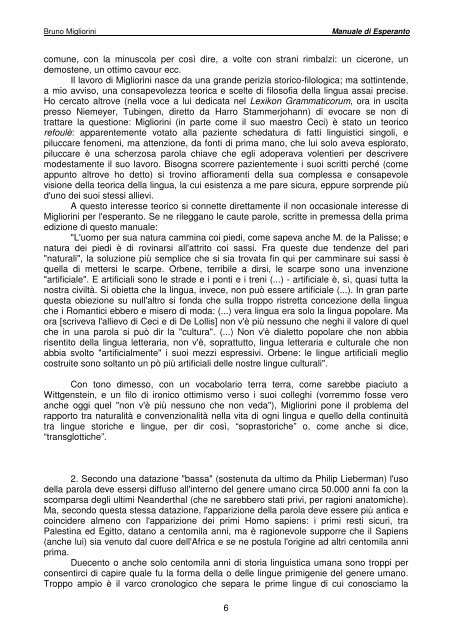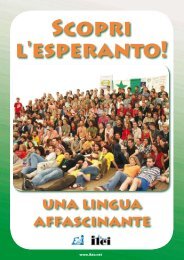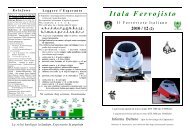Manuale di Esperanto (pdf) - Federazione Esperantista Italiana
Manuale di Esperanto (pdf) - Federazione Esperantista Italiana
Manuale di Esperanto (pdf) - Federazione Esperantista Italiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bruno Migliorini <strong>Manuale</strong> <strong>di</strong> <strong>Esperanto</strong><br />
comune, con la minuscola per così <strong>di</strong>re, a volte con strani rimbalzi: un cicerone, un<br />
demostene, un ottimo cavour ecc.<br />
Il lavoro <strong>di</strong> Migliorini nasce da una grande perizia storico-filologica; ma sottintende,<br />
a mio avviso, una consapevolezza teorica e scelte <strong>di</strong> filosofia della lingua assai precise.<br />
Ho cercato altrove (nella voce a lui de<strong>di</strong>cata nel Lexikon Grammaticorum, ora in uscita<br />
presso Niemeyer, Tubingen, <strong>di</strong>retto da Harro Stammerjohann) <strong>di</strong> evocare se non <strong>di</strong><br />
trattare la questione: Migliorini (in parte come il suo maestro Ceci) è stato un teorico<br />
refoulè: apparentemente votato alla paziente schedatura <strong>di</strong> fatti linguistici singoli, e<br />
piluccare fenomeni, ma attenzione, da fonti <strong>di</strong> prima mano, che lui solo aveva esplorato,<br />
piluccare è una scherzosa parola chiave che egli adoperava volentieri per descrivere<br />
modestamente il suo lavoro. Bisogna scorrere pazientemente i suoi scritti perché (come<br />
appunto altrove ho detto) si trovino affioramenti della sua complessa e consapevole<br />
visione della teorica della lingua, la cui esistenza a me pare sicura, eppure sorprende più<br />
d'uno dei suoi stessi allievi.<br />
A questo interesse teorico si connette <strong>di</strong>rettamente il non occasionale interesse <strong>di</strong><br />
Migliorini per l'esperanto. Se ne rileggano le caute parole, scritte in premessa della prima<br />
e<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> questo manuale:<br />
"L'uomo per sua natura cammina coi pie<strong>di</strong>, come sapeva anche M. de la Palisse; e<br />
natura dei pie<strong>di</strong> è <strong>di</strong> rovinarsi all'attrito coi sassi. Fra queste due tendenze del pari<br />
"naturali", la soluzione più semplice che si sia trovata fin qui per camminare sui sassi è<br />
quella <strong>di</strong> mettersi le scarpe. Orbene, terribile a <strong>di</strong>rsi, le scarpe sono una invenzione<br />
"artificiale". E artificiali sono le strade e i ponti e i treni (...) - artificiale è, sì, quasi tutta la<br />
nostra civiltà. Si obietta che la lingua, invece, non può essere artificiale (...). In gran parte<br />
questa obiezione su null'altro si fonda che sulla troppo ristretta concezione della lingua<br />
che i Romantici ebbero e misero <strong>di</strong> moda: (...) vera lingua era solo la lingua popolare. Ma<br />
ora [scriveva l'allievo <strong>di</strong> Ceci e <strong>di</strong> De Lollis] non v'è più nessuno che neghi il valore <strong>di</strong> quel<br />
che in una parola si può <strong>di</strong>r la "cultura". (...) Non v'è <strong>di</strong>aletto popolare che non abbia<br />
risentito della lingua letteraria, non v'è, soprattutto, lingua letteraria e culturale che non<br />
abbia svolto "artificialmente" i suoi mezzi espressivi. Orbene: le lingue artificiali meglio<br />
costruite sono soltanto un pò più artificiali delle nostre lingue culturali".<br />
Con tono <strong>di</strong>messo, con un vocabolario terra terra, come sarebbe piaciuto a<br />
Wittgenstein, e un filo <strong>di</strong> ironico ottimismo verso i suoi colleghi (vorremmo fosse vero<br />
anche oggi quel "non v'è più nessuno che non veda"), Migliorini pone il problema del<br />
rapporto tra naturalità e convenzionalità nella vita <strong>di</strong> ogni lingua e quello della continuità<br />
tra lingue storiche e lingue, per <strong>di</strong>r così, “soprastoriche” o, come anche si <strong>di</strong>ce,<br />
“transglottiche”.<br />
2. Secondo una datazione "bassa" (sostenuta da ultimo da Philip Lieberman) l'uso<br />
della parola deve essersi <strong>di</strong>ffuso all'interno del genere umano circa 50.000 anni fa con la<br />
scomparsa degli ultimi Neanderthal (che ne sarebbero stati privi, per ragioni anatomiche).<br />
Ma, secondo questa stessa datazione, l'apparizione della parola deve essere più antica e<br />
coincidere almeno con l'apparizione dei primi Homo sapiens: i primi resti sicuri, tra<br />
Palestina ed Egitto, datano a centomila anni, ma è ragionevole supporre che il Sapiens<br />
(anche lui) sia venuto dal cuore dell'Africa e se ne postula l'origine ad altri centomila anni<br />
prima.<br />
Duecento o anche solo centomila anni <strong>di</strong> storia linguistica umana sono troppi per<br />
consentirci <strong>di</strong> capire quale fu la forma della o delle lingue primigenie del genere umano.<br />
Troppo ampio è il varco cronologico che separa le prime lingue <strong>di</strong> cui conosciamo la<br />
6