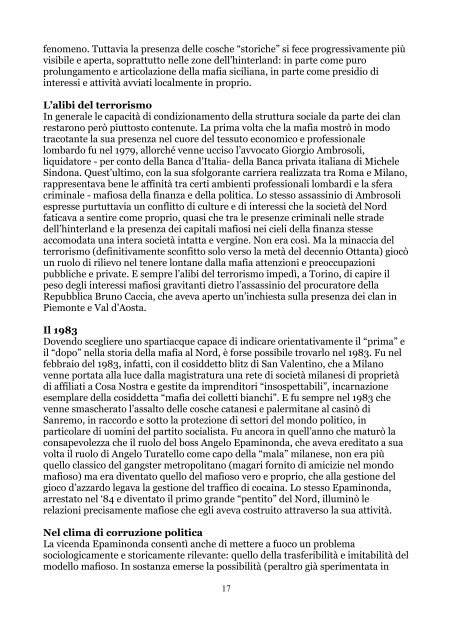Ndrangheta a Lecco_#7E45 - Trasparente
Ndrangheta a Lecco_#7E45 - Trasparente
Ndrangheta a Lecco_#7E45 - Trasparente
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
fenomeno. Tuttavia la presenza delle cosche “storiche” si fece progressivamente più<br />
visibile e aperta, soprattutto nelle zone dell’hinterland: in parte come puro<br />
prolungamento e articolazione della mafia siciliana, in parte come presidio di<br />
interessi e attività avviati localmente in proprio.<br />
L’alibi del terrorismo<br />
In generale le capacità di condizionamento della struttura sociale da parte dei clan<br />
restarono però piuttosto contenute. La prima volta che la mafia mostrò in modo<br />
tracotante la sua presenza nel cuore del tessuto economico e professionale<br />
lombardo fu nel 1979, allorché venne ucciso l’avvocato Giorgio Ambrosoli,<br />
liquidatore - per conto della Banca d’Italia- della Banca privata italiana di Michele<br />
Sindona. Quest’ultimo, con la sua sfolgorante carriera realizzata tra Roma e Milano,<br />
rappresentava bene le affinità tra certi ambienti professionali lombardi e la sfera<br />
criminale - mafiosa della finanza e della politica. Lo stesso assassinio di Ambrosoli<br />
espresse purtuttavia un conflitto di culture e di interessi che la società del Nord<br />
faticava a sentire come proprio, quasi che tra le presenze criminali nelle strade<br />
dell’hinterland e la presenza dei capitali mafiosi nei cieli della finanza stesse<br />
accomodata una intera società intatta e vergine. Non era così. Ma la minaccia del<br />
terrorismo (definitivamente sconfitto solo verso la metà del decennio Ottanta) giocò<br />
un ruolo di rilievo nel tenere lontane dalla mafia attenzioni e preoccupazioni<br />
pubbliche e private. E sempre l’alibi del terrorismo impedì, a Torino, di capire il<br />
peso degli interessi mafiosi gravitanti dietro l’assassinio del procuratore della<br />
Repubblica Bruno Caccia, che aveva aperto un’inchiesta sulla presenza dei clan in<br />
Piemonte e Val d’Aosta.<br />
Il 1983<br />
Dovendo scegliere uno spartiacque capace di indicare orientativamente il “prima” e<br />
il “dopo” nella storia della mafia al Nord, è forse possibile trovarlo nel 1983. Fu nel<br />
febbraio del 1983, infatti, con il cosiddetto blitz di San Valentino, che a Milano<br />
venne portata alla luce dalla magistratura una rete di società milanesi di proprietà<br />
di affiliati a Cosa Nostra e gestite da imprenditori “insospettabili”, incarnazione<br />
esemplare della cosiddetta “mafia dei colletti bianchi”. E fu sempre nel 1983 che<br />
venne smascherato l’assalto delle cosche catanesi e palermitane al casinò di<br />
Sanremo, in raccordo e sotto la protezione di settori del mondo politico, in<br />
particolare di uomini del partito socialista. Fu ancora in quell’anno che maturò la<br />
consapevolezza che il ruolo del boss Angelo Epaminonda, che aveva ereditato a sua<br />
volta il ruolo di Angelo Turatello come capo della “mala” milanese, non era più<br />
quello classico del gangster metropolitano (magari fornito di amicizie nel mondo<br />
mafioso) ma era diventato quello del mafioso vero e proprio, che alla gestione del<br />
gioco d’azzardo legava la gestione del traffico di cocaina. Lo stesso Epaminonda,<br />
arrestato nel ‘84 e diventato il primo grande “pentito” del Nord, illuminò le<br />
relazioni precisamente mafiose che egli aveva costruito attraverso la sua attività.<br />
Nel clima di corruzione politica<br />
La vicenda Epaminonda consentì anche di mettere a fuoco un problema<br />
sociologicamente e storicamente rilevante: quello della trasferibilità e imitabilità del<br />
modello mafioso. In sostanza emerse la possibilità (peraltro già sperimentata in<br />
17