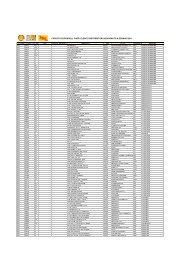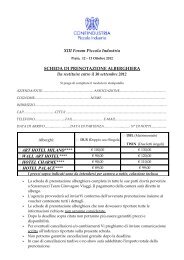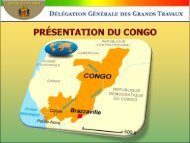capitolo 4.pdf - Confindustria
capitolo 4.pdf - Confindustria
capitolo 4.pdf - Confindustria
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
In Italia questo fenomeno presenta una particolare accentuazione, tanto<br />
più notevole in quanto l’Italia era già, all’inizio degli anni Settanta, il<br />
paese — tra quelli presi qui in considerazione — in cui la struttura industriale<br />
era più spostata verso la piccola dimensione.<br />
Un primo fattore da tenere presente a questo riguardo è il ritardo di<br />
sviluppo che l’Italia scontava, ancora alla fine degli anni Sessanta, rispetto<br />
al gruppo dei paesi di più antica industrializzazione. Questo ritardo si<br />
esprime in due caratteristiche, strettamente interrelate tra loro: la specializzazione<br />
in produzioni di tipo «tradizionale», e l’estesa presenza di microimprese<br />
di origine artigianale. Il processo di modernizzazione della struttura<br />
produttiva che aveva avviato l’Italia verso l’industrializzazione fin dai<br />
primi anni del dopoguerra, da questo punto di vista, non aveva assorbito<br />
che una quota complessivamente modesta dell’occupazione industriale (come<br />
le stesse tavole qui riportate indicano). Lo sviluppo della grande industria<br />
meccanica nel c.d. «triangolo» nord-occidentale e il tentativo di forzare<br />
attraverso l’impresa pubblica il processo di industrializzazione nel Mezzogiorno<br />
avevano sottratto alle produzioni più semplici una quota apprezzabile<br />
dei loro occupati, ma senza che questo si traducesse in un loro ridimensionamento<br />
significativo.<br />
Quando iniziano a propagarsi gli shock più sopra evocati che cominciano<br />
a mettere in crisi la produzione di grande scala, nell’industria italiana<br />
lo small business sector è ancora assai esteso; certamente molto più esteso<br />
di quanto non sia più nei paesi in cui il processo di industrializzazione<br />
si è realizzato più anticamente. Gli shock svolgono in questo contesto un<br />
ruolo asimmetrico: mentre penalizzano la grande impresa su cui si fondano<br />
le produzioni più «moderne», enfatizzano i vantaggi differenziali specifici<br />
(massimamente in termini di flessibilità) delle imprese minori, rendendole<br />
relativamente più competitive. L’effetto è quello di ampliare le opportunità<br />
di sviluppo dello small business sector che in Italia svolge ancora<br />
un ruolo importante. Dapprima attraverso il semplice trasferimento di<br />
fasi di produzione dalle grandi imprese a nuove picole unità che ad esse<br />
«subentrano» nel ruolo di produttori, e poi sempre più attraverso la creazione<br />
di mercati di input intermedi (che alimentano scambi tra piccole imprese<br />
per la realizzazione di un unico bene finale), si realizza così un processo<br />
di radicale riorganizzazione della struttura produttiva. Quello che per<br />
l’Italia era un fattore di «ritardo» diventa nelle nuove condizioni di contesto<br />
un fattore che contribuisce notevolmente all’adattamento dell’industria<br />
italiana agli shock degli anni settanta.<br />
Questi processi sono stati anche sostenuti dall’operare di istituzioni<br />
intermedie (ad esempio associazioni imprenditoriali, enti locali, consorzi<br />
di vario genere) che, in varie realtà locali, hanno saputo creare un sistema<br />
di esternalità appropriabili dalle imprese di dimensione ridotta 3 . Ciò<br />
ha contribuito al consolidarsi, all’interno di aree territoriali specifiche, di<br />
quei sistemi localizzati di impresa che vengono in generale compresi sotto<br />
il termine di distretti industriali, in cui risulta efficiente una articolazione<br />
dell’organizzazione industriale tra numerose imprese la cui dimensione,<br />
se considerate singolarmente, non necessariamente sarebbe ottimale.<br />
3<br />
Ci si riferisce al caso in cui le imprese più piccole non sono in grado di internalizzare<br />
i vantaggi derivanti dall’esistenza di beni pubblici indifferenziati. Cfr. su questo punto in particolare<br />
A. Arrrighetti e G. Seravalli, in F. Barca (a cura di), Storia del capitalismo italiano,<br />
Roma, Donzelli (1997).<br />
176