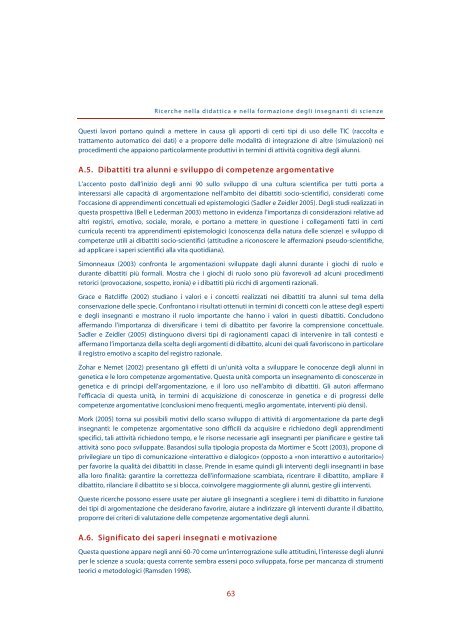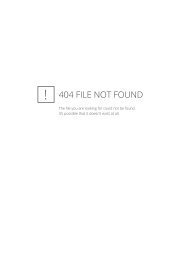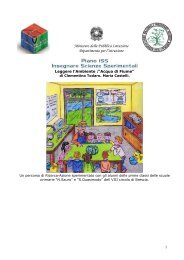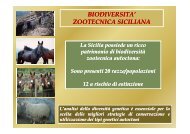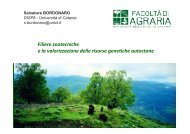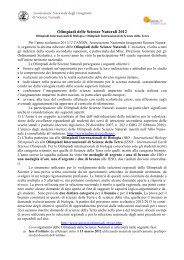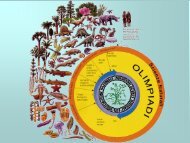L'insegnamento delle scienze nelle scuole in Europa - Indire
L'insegnamento delle scienze nelle scuole in Europa - Indire
L'insegnamento delle scienze nelle scuole in Europa - Indire
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ricerche nella didattica e nella formazione degli <strong>in</strong>segnanti di <strong>scienze</strong>Questi lavori portano qu<strong>in</strong>di a mettere <strong>in</strong> causa gli apporti di certi tipi di uso <strong>delle</strong> TIC (raccolta etrattamento automatico dei dati) e a proporre <strong>delle</strong> modalità di <strong>in</strong>tegrazione di altre (simulazioni) neiprocedimenti che appaiono particolarmente produttivi <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di attività cognitiva degli alunni.A.5. Dibattiti tra alunni e sviluppo di competenze argomentativeL’accento posto dall’<strong>in</strong>izio degli anni 90 sullo sviluppo di una cultura scientifica per tutti porta a<strong>in</strong>teressarsi alle capacità di argomentazione nell’ambito dei dibattiti socio-scientifici, considerati comel’occasione di apprendimenti concettuali ed epistemologici (Sadler e Zeidler 2005). Degli studi realizzati <strong>in</strong>questa prospettiva (Bell e Lederman 2003) mettono <strong>in</strong> evidenza l’importanza di considerazioni relative adaltri registri, emotivo, sociale, morale, e portano a mettere <strong>in</strong> questione i collegamenti fatti <strong>in</strong> certicurricula recenti tra apprendimenti epistemologici (conoscenza della natura <strong>delle</strong> <strong>scienze</strong>) e sviluppo dicompetenze utili ai dibattiti socio-scientifici (attitud<strong>in</strong>e a riconoscere le affermazioni pseudo-scientifiche,ad applicare i saperi scientifici alla vita quotidiana).Simonneaux (2003) confronta le argomentazioni sviluppate dagli alunni durante i giochi di ruolo edurante dibattiti più formali. Mostra che i giochi di ruolo sono più favorevoli ad alcuni procedimentiretorici (provocazione, sospetto, ironia) e i dibattiti più ricchi di argomenti razionali.Grace e Ratcliffe (2002) studiano i valori e i concetti realizzati nei dibattiti tra alunni sul tema dellaconservazione <strong>delle</strong> specie. Confrontano i risultati ottenuti <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di concetti con le attese degli espertie degli <strong>in</strong>segnanti e mostrano il ruolo importante che hanno i valori <strong>in</strong> questi dibattiti. Concludonoaffermando l’importanza di diversificare i temi di dibattito per favorire la comprensione concettuale.Sadler e Zeidler (2005) dist<strong>in</strong>guono diversi tipi di ragionamenti capaci di <strong>in</strong>tervenire <strong>in</strong> tali contesti eaffermano l’importanza della scelta degli argomenti di dibattito, alcuni dei quali favoriscono <strong>in</strong> particolareil registro emotivo a scapito del registro razionale.Zohar e Nemet (2002) presentano gli effetti di un’unità volta a sviluppare le conocenze degli alunni <strong>in</strong>genetica e le loro competenze argomentative. Questa unità comporta un <strong>in</strong>segnamento di conoscenze <strong>in</strong>genetica e di pr<strong>in</strong>cipi dell’argomentazione, e il loro uso nell’ambito di dibattiti. Gli autori affermanol’efficacia di questa unità, <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di acquisizione di conoscenze <strong>in</strong> genetica e di progressi <strong>delle</strong>competenze argomentative (conclusioni meno frequenti, meglio argomentate, <strong>in</strong>terventi più densi).Mork (2005) torna sui possibili motivi dello scarso sviluppo di attività di argomentazione da parte degli<strong>in</strong>segnanti: le competenze argomentative sono difficili da acquisire e richiedono degli apprendimentispecifici, tali attività richiedono tempo, e le risorse necessarie agli <strong>in</strong>segnanti per pianificare e gestire taliattività sono poco sviluppate. Basandosi sulla tipologia proposta da Mortimer e Scott (2003), propone diprivilegiare un tipo di comunicazione «<strong>in</strong>terattivo e dialogico» (opposto a «non <strong>in</strong>terattivo e autoritario»)per favorire la qualità dei dibattiti <strong>in</strong> classe. Prende <strong>in</strong> esame qu<strong>in</strong>di gli <strong>in</strong>terventi degli <strong>in</strong>segnanti <strong>in</strong> basealla loro f<strong>in</strong>alità: garantire la correttezza dell’<strong>in</strong>formazione scambiata, ricentrare il dibattito, ampliare ildibattito, rilanciare il dibattito se si blocca, co<strong>in</strong>volgere maggiormente gli alunni, gestire gli <strong>in</strong>terventi.Queste ricerche possono essere usate per aiutare gli <strong>in</strong>segnanti a scegliere i temi di dibattito <strong>in</strong> funzionedei tipi di argomentazione che desiderano favorire, aiutare a <strong>in</strong>dirizzare gli <strong>in</strong>terventi durante il dibattito,proporre dei criteri di valutazione <strong>delle</strong> competenze argomentative degli alunni.A.6. Significato dei saperi <strong>in</strong>segnati e motivazioneQuesta questione appare negli anni 60-70 come un’<strong>in</strong>terrograzione sulle attitud<strong>in</strong>i, l’<strong>in</strong>teresse degli alunniper le <strong>scienze</strong> a scuola; questa corrente sembra essersi poco sviluppata, forse per mancanza di strumentiteorici e metodologici (Ramsden 1998).63