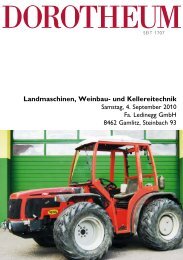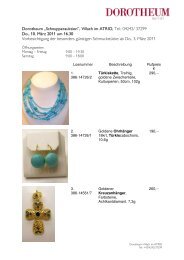Dipinti antichi 7 aprile 2006, ore 10:30 - Dorotheum
Dipinti antichi 7 aprile 2006, ore 10:30 - Dorotheum
Dipinti antichi 7 aprile 2006, ore 10:30 - Dorotheum
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
aderente alla stampa. Per i confronti col quadro citato e l’ incisione si possono esaminare il<br />
catalogo, curato dal sottoscritto, della mostra sull’aut<strong>ore</strong>, tenutasi a Gaeta nel 1981<br />
(‘Sebastiano Conca 1680 – 1764’, Centro Storico Culturale ‘Gaeta’, n. 24, pp. 138–139); e il<br />
‘Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento’, a cura di G.<br />
Sestieri, Allemandi ed., Torino 1994, II, fig. 298), in cui ho ripubblicato il quadro della<br />
collezione di Vigevano. Nel caso di una mia aggiornata redazione di una monografia su<br />
Sebastiano Conca, vi includerò senza meno questa opera; della quale avrei piacere di potere<br />
avere un trasparente per una sua una pubblicazione a colori.<br />
Bibliografia: si veda l’analoga composizione rovesciata nella collezione Ingold a Vigevano,<br />
riprodotta in Giancarlo Sestieri, “Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e<br />
del Settecento”, 1993, Roma, tomo II, n. 298.<br />
Provenienza: collezione privata viennese<br />
[EOT]<br />
53<br />
Francesco Trevisani (Capodistria 1655 – 1746 Roma)<br />
“Apollo e Marsia” e “Apollo e Pan”; pendants, olio su tela, ognuno “ 174 x 123 cm, con<br />
cornice, (2), (Wo)<br />
EURO 50.000 – 60.000 US$ 60.700 – 72.900<br />
Perizia: Prof. Giancarlo Sestieri, 8 febbraio 1999: “questi due notevoli quadri rappresentano<br />
due nuove importanti acquisizioni al catalogo di Francesco Trevisani, che fu uno dei<br />
caposcuola della pittura romana durante la prima metà del Settecento. Le due tele<br />
appartengono evidentemente alla sua prima fase romana (si trasferì nell’Urbe nel 1678),<br />
ancora sotto il diretto ascendente del suo maestro A. Zanchi - nella cui bottega si era<br />
educato giovinetto a Venezia - e antecedenti il suo esordio ufficiale romano in S. Silvestri in<br />
Capite (1695–96). Comunque esemplificativo è il confronto tra i due quadri, qui presi in<br />
esame, e i modelletti per il suddetto ciclo chiesastico (vedi G. Sestieri, ‘Repertorio della<br />
Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento’, III, figg. <strong>10</strong>84–<strong>10</strong>85). Sono due<br />
opere quindi che, oltre al loro alto livello qualitativo, esplicano significativamente il passaggio<br />
del Trevisani dalla primitiva matrice veneta, di cui si può godere il pregnante pittoricismo,<br />
alle successive raffinatezze di un dipingere più decantato e filtrato dalla chiarezza espositiva<br />
marattesca. In definitiva due testimonianze basilari per penetrare nella prima maturazione del<br />
maestro di Capodistria, che in effetti, grazie a questa sua commistione veneto-romana,<br />
costituì l’elemento più rivitalizzante del piuttosto monotono panorama tardo-barocco della<br />
pittura romana. Le due scene si riferiscono, la prima, alla punizione di Apollo, mentre si<br />
accinge a scorticare Marsia, che aveva osato sfidarlo a una gara di musica; e la seconda<br />
all’altra tenzone musicale tra il dio e Pan, con al centro il re Mida, ancora senza le <strong>ore</strong>cchie<br />
asinine, inflittegli quale punizione per il suo giudizio fav<strong>ore</strong>vole al satiro.”<br />
Provenienza: collezione privata europea<br />
[EOT]<br />
54