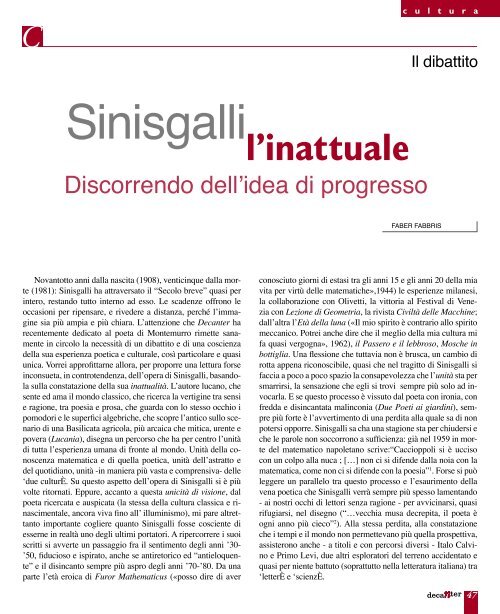decanter 2, giugno 2006
decanter 2, giugno 2006
decanter 2, giugno 2006
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
C<br />
Sinisgalli l’inattuale<br />
Discorrendo dell’idea di progresso<br />
Novantotto anni dalla nascita (1908), venticinque dalla morte<br />
(1981): Sinisgalli ha attraversato il “Secolo breve” quasi per<br />
intero, restando tutto interno ad esso. Le scadenze offrono le<br />
occasioni per ripensare, e rivedere a distanza, perché l’immagine<br />
sia più ampia e più chiara. L’attenzione che Decanter ha<br />
recentemente dedicato al poeta di Montemurro rimette sanamente<br />
in circolo la necessità di un dibattito e di una coscienza<br />
della sua esperienza poetica e culturale, così particolare e quasi<br />
unica. Vorrei approfittarne allora, per proporre una lettura forse<br />
inconsueta, in controtendenza, dell’opera di Sinisgalli, basandola<br />
sulla constatazione della sua inattualità. L’autore lucano, che<br />
sente ed ama il mondo classico, che ricerca la vertigine tra sensi<br />
e ragione, tra poesia e prosa, che guarda con lo stesso occhio i<br />
pomodori e le superfici algebriche, che scopre l’antico sullo scenario<br />
di una Basilicata agricola, più arcaica che mitica, urente e<br />
povera (Lucania), disegna un percorso che ha per centro l’unità<br />
di tutta l’esperienza umana di fronte al mondo. Unità della conoscenza<br />
matematica e di quella poetica, unità dell’astratto e<br />
del quotidiano, unità -in maniera più vasta e comprensiva- delle<br />
‘due culturÈ. Su questo aspetto dell’opera di Sinisgalli si è più<br />
volte ritornati. Eppure, accanto a questa unicità di visione, dal<br />
poeta ricercata e auspicata (la stessa della cultura classica e rinascimentale,<br />
ancora viva fino all’ illuminismo), mi pare altrettanto<br />
importante cogliere quanto Sinisgalli fosse cosciente di<br />
esserne in realtà uno degli ultimi portatori. A ripercorrere i suoi<br />
scritti si avverte un passaggio fra il sentimento degli anni ’30-<br />
’50, fiducioso e ispirato, anche se antiretorico ed “antieloquente”<br />
e il disincanto sempre più aspro degli anni ’70-’80. Da una<br />
parte l’età eroica di Furor Mathematicus («posso dire di aver<br />
c u l t u r a<br />
Il dibattito<br />
FABER FABBRIS<br />
conosciuto giorni di estasi tra gli anni 15 e gli anni 20 della mia<br />
vita per virtù delle matematiche»,1944) le esperienze milanesi,<br />
la collaborazione con Olivetti, la vittoria al Festival di Venezia<br />
con Lezione di Geometria, la rivista Civiltà delle Macchine;<br />
dall’altra l’Età della luna («Il mio spirito è contrario allo spirito<br />
meccanico. Potrei anche dire che il meglio della mia cultura mi<br />
fa quasi vergogna», 1962), il Passero e il lebbroso, Mosche in<br />
bottiglia. Una flessione che tuttavia non è brusca, un cambio di<br />
rotta appena riconoscibile, quasi che nel tragitto di Sinisgalli si<br />
faccia a poco a poco spazio la consapevolezza che l’unità sta per<br />
smarrirsi, la sensazione che egli si trovi sempre più solo ad invocarla.<br />
E se questo processo è vissuto dal poeta con ironia, con<br />
fredda e disincantata malinconia (Due Poeti ai giardini), sempre<br />
più forte è l’avvertimento di una perdita alla quale sa di non<br />
potersi opporre. Sinisgalli sa cha una stagione sta per chiudersi e<br />
che le parole non soccorrono a sufficienza: già nel 1959 in morte<br />
del matematico napoletano scrive:“Caccioppoli si è ucciso<br />
con un colpo alla nuca ; […] non ci si difende dalla noia con la<br />
matematica, come non ci si difende con la poesia” 1 . Forse si può<br />
leggere un parallelo tra questo processo e l’esaurimento della<br />
vena poetica che Sinisgalli verrà sempre più spesso lamentando<br />
- ai nostri occhi di lettori senza ragione - per avvicinarsi, quasi<br />
rifugiarsi, nel disegno (“…vecchia musa decrepita, il poeta è<br />
ogni anno più cieco” 2 ). Alla stessa perdita, alla constatazione<br />
che i tempi e il mondo non permettevano più quella prospettiva,<br />
assisterono anche - a titoli e con percorsi diversi - Italo Calvino<br />
e Primo Levi, due altri esploratori del terreno accidentato e<br />
quasi per niente battuto (soprattutto nella letteratura italiana) tra<br />
‘letterÈ e ‘scienzÈ.<br />
47