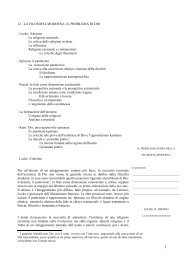Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3. La distruzione del<strong>la</strong> cosmologia aristotelico-tolemaica.<br />
Galileo aveva intuito <strong>la</strong> verità del copernicanesimo sin dall’inizio dei suoi studi. In<br />
seguito, grazie all’uso del telescopio, che gli permetteva di scrutare i vasti spazi del<br />
cielo con più acuta vista, egli pervenne a delle scoperte — comunicate nel Sidereus<br />
Nuncius (Ragguaglio astronomico) del 1610 — le quali rappresentano al tempo<br />
stesso <strong>la</strong> verifica empirica del copernicanesimo ed il colpo decisivo al<strong>la</strong> vecchia<br />
cosmologia, tutta fondata sul dualismo fra cieli e terra.<br />
3.1. ________________________________________________________<br />
Tradizionalmente si riteneva che <strong>la</strong> Luna, analogamente agli altri corpi celesti e a<br />
differenza del<strong>la</strong> terra, fosse rivestita di una superficie «liscia e levigata». Invece, le<br />
osservazioni telescopiche di Galileo mostrano come molte delle macchie scure di essa,<br />
visibili ad occhio nudo, siano ombre proiettate dalle montagne lunari sotto effetto<br />
del<strong>la</strong> luce del sole, come <strong>la</strong> superficie del<strong>la</strong> Luna sia quindi «rugosa» ed ricoperta,<br />
allo stesso modo del<strong>la</strong> terra, di prominenze, valli ed anfratti. Ovviamente, al<strong>la</strong> luce<br />
di queste scoperte, l'ipotesi escogitata dal gesuita Cristoforo C<strong>la</strong>vio - che per<br />
salvare <strong>la</strong> presunta «perfezione» dei cieli aveva supposto che <strong>la</strong> Luna fosse rivestita<br />
di una materia cristallina trasparente e sferoidale - appariva a Galileo soltanto uno<br />
scorretto sotterfugio di menti ormai costrette al<strong>la</strong> difensiva.<br />
Aristotele credeva che soltanto <strong>la</strong> terra, essendo immobile, fosse centro di moti astrali e<br />
che un corpo in movimento nello spazio non potesse costituire un nucleo di<br />
movimento per altri corpi. Invece, Galileo scopre i quattro satelliti di Giove,<br />
battezzati «pianeti medicei», che compivano attorno ad esso movimenti analoghi a<br />
quelli che <strong>la</strong> Luna compie attorno al<strong>la</strong> terra. Ma se Giove ruota insieme ai propri<br />
satelliti intorno al Sole, come suppone Copernico, nul<strong>la</strong> vieta di pensare, secondo<br />
Galileo, che anche <strong>la</strong> terra, con il suo satellite, possa ruotare intorno al Sole.<br />
La cosmologia tolemaica sosteneva che i corpi celesti, essendo perfetti, fossero<br />
incorruttibili e non soggetti al divenire. Questo pregiudizio era già stato messo in<br />
dubbio dal<strong>la</strong> tarda Sco<strong>la</strong>stica (Ockham) ed esplicitamente negato, su base teorica, da<br />
Cusano, Leonardo e Bruno. Ma è soltanto con Galileo che riceve il suo colpo di<br />
grazia su base sperimentale. Infatti, grazie all'uso del telescopio, lo scienziato<br />
toscano scoprì macchie oscure sul<strong>la</strong> superficie so<strong>la</strong>re che si formavano e scomparivano,<br />
attestando l'esistenza di un processo di trasformazione in atto e dimostrando<br />
c<strong>la</strong>morosamente come anche i corpi celesti fossero soggetti a fenomeni di alterazione e<br />
mutamento. E poiché Galileo parlò subito — a ragione — di «funerali» del<strong>la</strong> <strong>scienza</strong><br />
aristotelica, i rappresentanti del<strong>la</strong> cultura peripatetico-sco<strong>la</strong>stica reagirono sdegnati.<br />
Vi fu chi si rifiutò di guardare al telescopio, ritenendolo strumento «diabolico» o<br />
deformante» delle immagini; chi disse di non vedere ciò che vedeva Galileo e chi,<br />
come il gesuita padre Cristoforo Scheiner, formulò l'ingegnosa ipotesi secondo cui le<br />
macchie non erano dovute al Sole, bensì al passaggio di altri corpi celesti davanti ad esso.<br />
Ma Galileo fece notare, contro Scheiner, che le macchie, nel loro apparire e<br />
scomparire, erano intermittenti, ed apparivano difformi fra di loro, per cui non<br />
potevano essere attribuite a passaggi rego<strong>la</strong>ri diastri.<br />
Nell'antichità e nel Medioevo si era sempre creduto che soltanto <strong>la</strong> terra fosse un<br />
corpo opaco, illuminato dal Sole e privo di luce propria. Invece <strong>la</strong> scoperta<br />
galileiana delle fasi di Venere, inducendo a pensare che tale astro ricevesse <strong>la</strong> luce<br />
girandovi attorno, offriva lo spunto per ritenere che tale spiegazione fosse valida anche<br />
per gli altri pianeti, «tenebrosi» per natura e illuminati esclusivamentedalSole.<br />
Sempre grazie al telescopio, Galileo riuscì a scoprire che oltre le stelle fisse, visibili ad<br />
occhio nudo, esistevano innumerevoli altre stelle, mai scorte prima e che si<br />
«affol<strong>la</strong>vano» davanti al mezzo d'osservazione. Inoltre, si rese conto che <strong>la</strong> ga<strong>la</strong>ssia è<br />
nient'altro che una congerie di innumerevoli stelle disseminate a gruppi negli spazi e<br />
che le nebulose sono parimenti «greggi» di piccole stelle.<br />
56