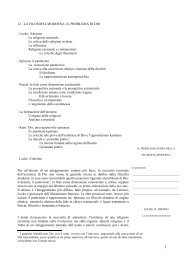Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
talora a delle ipotesi mediante cui deduce il comportamento probabile dei fatti, che in<br />
seguito si propone di verificare.<br />
Tipica, in questo senso, è <strong>la</strong> via seguita da Galileo nell'intuizione teorica del<br />
principio di inerzia, da lui riportata in modo minuzioso e suadente in un passo del<br />
Dialogo. Immaginiamo — scrive Galileo — una superficie « piana, pulitissima come<br />
uno specchio e di materia dura come l'acciaio, e che fusse non paralle<strong>la</strong> all'orizzonte,<br />
ma alquanto inclinata, e che sopra di essa voi poneste una pal<strong>la</strong> perfettamente<br />
sferica e di materia grave e durissima, come, verbigrazia, di bronzo». Come<br />
deduciamo si comporterà tale pal<strong>la</strong>? Starà ferma o si muoverà? Anche senza fare<br />
l'esperimento concreto, argomenta Galileo, sappiamo che si muoverà lungo <strong>la</strong><br />
superficie. E se ipotizziamo mentalmente che sia tolta anche l'azione frenante<br />
dell'aria e di altri possibili «impedimenti esterni ed accidentali», come pensiamo si<br />
comporterà? Ovviamente «el<strong>la</strong> continuerebbe a muoversi all'infinito, se tanto<br />
durasse <strong>la</strong> inclinazione del piano e con movimento accelerato continuamente; che tale<br />
è <strong>la</strong> natura dei mobili gravi, che acquistano forza muovendosi: che quanto maggior<br />
fusse <strong>la</strong> declività, maggior sarebbe <strong>la</strong> velocità». Sostituendo poi <strong>la</strong> superficie<br />
inclinata con una orizzontale, si potrà anche dedurre che <strong>la</strong> medesima pal<strong>la</strong><br />
«perfettissimamente rotonda», se fosse spinta sul medesimo piano «esquisitamente<br />
pulito», continuerebbe indefinitamente il suo moto, ammesso che lo spazio «fosse<br />
interminato» e che non intervenisse una forza esterna a variarne o arrestarne il<br />
moto. Procedendo teoricamente e giustificando tramite un esperimento «ideale» una<br />
propria intuizione, Galileo è quindi pervenuto ad una basi<strong>la</strong>re scoperta fisica.<br />
4.2 ___________________________________________________________<br />
La compresenza, nel<strong>la</strong> visione metodologica di Galileo, delle «sensate esperienze» e<br />
delle «necessarie dimostrazioni» ha fatto sì che nel<strong>la</strong> storiografia del passato Galileo<br />
sia stato presentato talora come un sostanziale «induttivista», cioè come un ricercatore<br />
che dall'osservazione instancabile dei fatti naturali perviene a scoprire le leggi che<br />
rego<strong>la</strong>no i fenomeni; oppure, al contrario, come un convinto «deduttivista», più<br />
fiducioso nelle capacità del<strong>la</strong> ragione che in quelle dell'osservazione.<br />
In realtà Galileo non è solo, o prevalentemente, induttivista, né solo, o prevalentemente,<br />
deduttivista, poiché è tutte e due le cose insieme. Certo, in Galileo vi<br />
è talora, sia nel<strong>la</strong> prassi concreta del<strong>la</strong> scoperta scientifica, sia nel<strong>la</strong> sua<br />
consapevolizzazione metodologica, un'innegabile prevalenza del momento<br />
sperimentale osservativo-induttivo, oppure di quello teorico, ipotetico-deduttìvo. In un<br />
punto del Dialogo egli sostiene ad esempio che «quello che l'esperienza e il senso ci<br />
dimostra si deve anteporre ad ogni discorso ancorché ne paresse assai bene fondato»,<br />
mentre in un altro luogo fa dire a Salviati che «senza esperienza son sicuro che<br />
l'effetto seguirà come vi dico, perché così è necessario che segua». Ma questa<br />
alternata e talora enfatizzata prevalenza dell'induzione sperimentale sul<strong>la</strong> deduzione<br />
teorica o viceversa, che si può riscontrare nei testi di Galileo, non esclude tuttavia <strong>la</strong><br />
reciproca ed indissolubile implicanza di fatto.<br />
Innanzitutto, le «sensate esperienze» presuppongono sempre un riferimento alle<br />
«necessarie dimostrazioni», in quanto vengono assunte e rie<strong>la</strong>borate in un cotesto<br />
matematico-razionale e quindi spogliate dei loro caratteri qualitativi e ridotte al<strong>la</strong><br />
loro struttura puramente quantitativa. In secondo luogo esse, sin dall'inizio sono<br />
«cariche di teoria», in quanto illuminate da un'ipotesi che le sceglie e le seleziona<br />
fungendo, nei loro confronti, da freccia indicatrice e setaccio discriminatore. E’vero,<br />
ad esempio, che Galileo scoprì ignoti fenomeni astronomici basandosi sul senso<br />
del<strong>la</strong> vista — potenziata dal telescopio — , ma <strong>la</strong> decisione stessa di studiare i cieli<br />
e di puntare il cannocchiale su determinati fenomeni e di interpretarli in un certi modo<br />
deriva dal<strong>la</strong> preliminare accettazione dell'ipotesi copernicana.<br />
Anche le «certe dimostrazioni» presuppongono sempre un loro implicito od esplicito<br />
richiamo alle «sensate esperienze». Innanzitutto, l'esperienza fornisce <strong>la</strong> base e lo<br />
spunto per le ipotesi poiché le stesse intuizioni «geniali» non nascono nel vuoto, ma a<br />
60