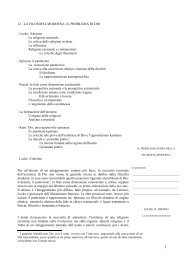Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
velocità; che (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi<br />
non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti, né da alcuno<br />
di quelli potrete comprender se <strong>la</strong> nave cammina o pure sta ferma... le gocciole<br />
cadranno come prima nel vaso inferiore, senza caderne pur una verso poppa, benché,<br />
mentre <strong>la</strong> goccio<strong>la</strong> è per aria, <strong>la</strong> nave scorra di molti palmi... » .<br />
Pertanto, in base a questo principio di re<strong>la</strong>tività, possiamo affermare che, in quel<br />
sistema quasi inerziale che è <strong>la</strong> Terra, l'aria circostante si muove insieme con <strong>la</strong> Terra<br />
stessa e i gravi cadono comportandosi, approssimativamente, come se essa fosse<br />
immobile.<br />
Nel<strong>la</strong> terza giornata del Dialogo viene dimostrato il moto di rotazione del<strong>la</strong> terra ed<br />
esaltata <strong>la</strong> concezione copernicana, capace, secondo Galileo, di fornire spiegazioni di<br />
fenomeni altrimenti inspiegabili e di chiarire con rigore e matematica «semplicità»<br />
problemi inutilmente complicati e «sofisticati» dal sistema tolemaico.<br />
Nel<strong>la</strong> quarta giornata Galileo espone <strong>la</strong> sua dottrina delle maree.<br />
3.3 ___________________________________________________<br />
<strong>Il</strong> fatto che Galileo non avrebbe potuto rivoluzionare l'astronomia senza il<br />
cannocchiale è già di per sé una manifestazione dell'importanza assunta dagli<br />
strumenti d'osservazione nel corso del<strong>la</strong> Rivoluzione scientifica ed una prova<br />
ulteriore del<strong>la</strong> convergenza, da essa promossa, fra sapere e tecnica.<br />
Tali strumenti si rive<strong>la</strong>rono subito decisivi non solo per l'osservazione, ma anche<br />
per il «cimento» sperimentale, cioè per <strong>la</strong> possibilità di riprodurre il fenomeno<br />
studiato nelle condizioni volute. Ciò comportò un'esplicita attribuzione di valore<br />
conoscitivo nei loro confronti, affatto nuova per i tempi. Infatti, ciò che ai nostri occhi può<br />
apparire ovvio — lo strumento come aiuto per <strong>la</strong> <strong>scienza</strong> — non lo era affatto<br />
nell'epoca di Galileo, a causa di pregiudizi seco<strong>la</strong>ri. Di ciò risulta emblematica<br />
espressione <strong>la</strong> vicenda del cannocchiale.<br />
Nel Saggiatore Galileo scrive che venuto a conoscenza del fatto che un o<strong>la</strong>ndese<br />
aveva presentato un «occhiale» mediante cui «le cose lontane si vedevano così<br />
perfettamente come se fossero state molto vicine», aveva proceduto, grazie a<br />
deduzioni teoriche, a costruirne uno per proprio conto, all'inizio poco capace e poi<br />
così potente, rispetto al<strong>la</strong> vista naturale, da riuscire ad ottenere oltre trenta ingrandimenti<br />
lineari (che, in termini di superfici, forniscono immagini mille volte più<br />
grandi). La discussione sul<strong>la</strong> paternità storica del cannocchiale è tuttora aperta tra gli<br />
studiosi. Tuttavia, come ha fatto notare soprattutto Vasco Ronchi in una ricerca<br />
apposita, <strong>la</strong> grandezza di Galileo non consiste tanto nell'aver «costruito» il<br />
cannocchiale, ma nell’averlo usato scientificamente. Infatti, le lenti erano note fin dal<br />
XIII secolo o, forse, dal XII, tuttavia esse, come «l'occhiale» o<strong>la</strong>ndese di cui par<strong>la</strong><br />
Galileo, erano state considerate semplicemente come fonti di divertimento o di<br />
piacevoli giochi di società da parte dei nobili di corte. Gli stessi navigatori e<br />
militari ne avevano fatto un uso limitato, mentre <strong>la</strong> cultura «ufficiale» li guardava<br />
con distacco, per l'inveterato pregiudizio contro gli «ordigni meccanici», oppure li<br />
condannava esplicitamente, ritenendoli fonti di illusioni ottiche. Molti teologi li<br />
consideravano «diabolici» sostituti degli occhi naturali creati da Dio. Da ciò il<br />
«rifiuto», da parte di alcuni dotti, di accostare i loro occhi al nuovo mezzo.<br />
Invece Galileo ebbe <strong>la</strong> genialità ed il coraggio di puntare il cannocchiale verso il<br />
cielo, trasformandolo così in telescopio, ossia in uno strumento primario dell'osservazione<br />
astronomica e facendo, grazie ad esso, le sensazionali scoperte<br />
divulgate dal Sidereus Nuncius. Ma è proprio il diritto ad usare il cannocchiale come<br />
mezzo scientifico che gli sarà, tra l'altro, duramente contestato e che costituirà una<br />
delle ragioni di fondo del<strong>la</strong> reciproca incomprensione fra lo scienziato da un <strong>la</strong>to e i<br />
teologi e gli aristotelici dall'altro. Come ci si poteva fidare più di Galileo e dei<br />
suoi strumenti che del<strong>la</strong> Bibbia? Come si poteva «seppellire» <strong>la</strong> <strong>scienza</strong><br />
astronomica di Aristotele sul<strong>la</strong> base di un discutibile congegno «meccanico»?<br />
58