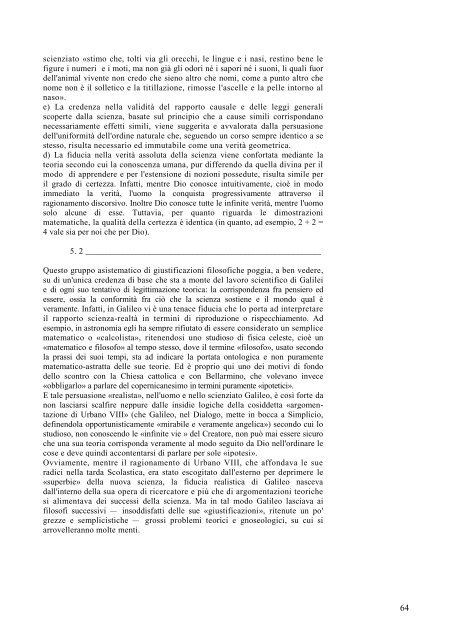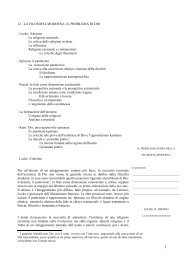Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
scienziato «stimo che, tolti via gli orecchi, le lingue e i nasi, restino bene le<br />
figure i numeri e i moti, ma non già gli odori né i sapori né i suoni, li quali fuor<br />
dell'animal vivente non credo che sieno altro che nomi, come a punto altro che<br />
nome non è il solletico e <strong>la</strong> titil<strong>la</strong>zione, rimosse l'ascelle e <strong>la</strong> pelle intorno al<br />
naso».<br />
e) La credenza nel<strong>la</strong> validità del rapporto causale e delle leggi generali<br />
scoperte dal<strong>la</strong> <strong>scienza</strong>, basate sul principio che a cause simili corrispondano<br />
necessariamente effetti simili, viene suggerita e avvalorata dal<strong>la</strong> persuasione<br />
dell'uniformità dell'ordine naturale che, seguendo un corso sempre identico a se<br />
stesso, risulta necessario ed immutabile come una verità geometrica.<br />
d) La fiducia nel<strong>la</strong> verità assoluta del<strong>la</strong> <strong>scienza</strong> viene confortata mediante <strong>la</strong><br />
teoria secondo cui <strong>la</strong> conoscenza umana, pur differendo da quel<strong>la</strong> divina per il<br />
modo di apprendere e per l'estensione di nozioni possedute, risulta simile per<br />
il grado di certezza. Infatti, mentre Dio conosce intuitivamente, cioè in modo<br />
immediato <strong>la</strong> verità, l'uomo <strong>la</strong> conquista progressivamente attraverso il<br />
ragionamento discorsivo. Inoltre Dio conosce tutte le infinite verità, mentre l'uomo<br />
solo alcune di esse. Tuttavia, per quanto riguarda le dimostrazioni<br />
matematiche, <strong>la</strong> qualità del<strong>la</strong> certezza è identica (in quanto, ad esempio, 2 + 2 =<br />
4 vale sia per noi che per Dio).<br />
5. 2 ______________________________________________________<br />
Questo gruppo asistematico di giustificazioni filosofiche poggia, a ben vedere,<br />
su di un'unica credenza di base che sta a monte del <strong>la</strong>voro scientifico di Galilei<br />
e di ogni suo tentativo di legittimazione teorica: <strong>la</strong> corrispondenza fra pensiero ed<br />
essere, ossia <strong>la</strong> conformità fra ciò che <strong>la</strong> <strong>scienza</strong> sostiene e il mondo qual è<br />
veramente. Infatti, in Galileo vi è una tenace fiducia che lo porta ad interpretare<br />
il rapporto <strong>scienza</strong>-realtà in termini di riproduzione o rispecchiamento. Ad<br />
esempio, in astronomia egli ha sempre rifiutato di essere considerato un semplice<br />
matematico o «calcolista», ritenendosi uno studioso di fisica celeste, cioè un<br />
«matematico e filosofo» al tempo stesso, dove il termine «filosofo», usato secondo<br />
<strong>la</strong> prassi dei suoi tempi, sta ad indicare <strong>la</strong> portata ontologica e non puramente<br />
matematico-astratta delle sue teorie. Ed è proprio qui uno dei motivi di fondo<br />
dello scontro con <strong>la</strong> Chiesa cattolica e con Bel<strong>la</strong>rmino, che volevano invece<br />
«obbligarlo» a par<strong>la</strong>re del copernicanesimo in termini puramente «ipotetici».<br />
E tale persuasione «realista», nell'uomo e nello scienziato Galileo, è così forte da<br />
non <strong>la</strong>sciarsi scalfire neppure dalle insidie logiche del<strong>la</strong> cosiddetta «argomentazione<br />
di Urbano VIII» (che Galileo, nel Dialogo, mette in bocca a Simplicio,<br />
definendo<strong>la</strong> opportunisticamente «mirabile e veramente angelica») secondo cui lo<br />
studioso, non conoscendo le «infinite vie » del Creatore, non può mai essere sicuro<br />
che una sua teoria corrisponda veramente al modo seguito da Dio nell'ordinare le<br />
cose e deve quindi accontentarsi di par<strong>la</strong>re per sole «ipotesi».<br />
Ovviamente, mentre il ragionamento di Urbano VIII, che affondava le sue<br />
radici nel<strong>la</strong> tarda Sco<strong>la</strong>stica, era stato escogitato dall'esterno per deprimere le<br />
«superbie» del<strong>la</strong> nuova <strong>scienza</strong>, <strong>la</strong> fiducia realistica di Galileo nasceva<br />
dall'interno del<strong>la</strong> sua opera di ricercatore e più che di argomentazioni teoriche<br />
si alimentava dei successi del<strong>la</strong> <strong>scienza</strong>. Ma in tal modo Galileo <strong>la</strong>sciava ai<br />
filosofi successivi — insoddisfatti delle sue «giustificazioni», ritenute un po'<br />
grezze e semplicistiche — grossi problemi teorici e gnoseologici, su cui si<br />
arrovelleranno molte menti.<br />
64