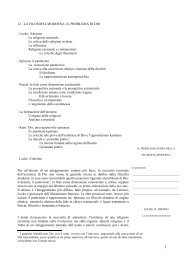Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Il Rinascimento e la nascita della scienza moderna - 1
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4. <strong>Il</strong> metodo del<strong>la</strong> <strong>scienza</strong>.<br />
Un altro risultato storicamente decisivo dell'opera di Galileo — che fa di lui il<br />
padre del<strong>la</strong> <strong>scienza</strong> <strong>moderna</strong> — è l'individuazione del metodo del<strong>la</strong> fisica, ossia il<br />
procedimento che ha spa<strong>la</strong>ncato le porte ai maggiori progressi scientifici<br />
dell’umanità, da Newton ad Einstein e ai giorni nostri.<br />
Tuttavia, in Galileo, non vi è una teoria organica del metodo, analoga ad esempio a<br />
quel<strong>la</strong> che Bacone svolgerà nel Novum Organum (Nuovo Organo), poiché egli,<br />
tutto preso dalle sue ricerche concrete di fisica ed astronomia, applica il metodo,<br />
più che teorizzarlo filosoficamente. Ciò nonostante, nelle sue opere si trovano<br />
disseminati qua e là, talune preziose osservazioni metodologiche e alcuni tentativi<br />
di sintetizzare il procedimento del<strong>la</strong> <strong>scienza</strong>. Ad esempio nel Saggiatore, nel<br />
Dialogo e nei Discorsi, Galileo tende ad artico<strong>la</strong>re il <strong>la</strong>voro del<strong>la</strong> <strong>scienza</strong> in due<br />
parti fondamentali: il momento «risolutivo» o analitico e quello «compositivo»o<br />
sintetico. <strong>Il</strong> primo consiste nel risolvere un fenomeno complesso nei suoi elementi<br />
semplici, quantitativi e misurabili, formu<strong>la</strong>ndo un'ipotesi matematica sul<strong>la</strong> legge da<br />
cui dipende. <strong>Il</strong> secondo momento risiede nel<strong>la</strong> verifica e nell'esperimento attraverso<br />
cui si tenta di comporre o riprodurre artificialmente il fenomeno, in modo che se<br />
l'ipotesi supera <strong>la</strong> prova, risultando quindi veri-ficata (= fatta vera), essa venga<br />
accettata e formu<strong>la</strong>ta in termini di legge, mentre se non supera <strong>la</strong> prova risultando<br />
smentita o falsificata (= non verificata), venga sostituita da un’altra ipotesi.<br />
Questo schema, su cui si sono basate soprattutto le presentazioni tradizionali, pur<br />
descrivendo in modo formalmente corretto il procedimento del<strong>la</strong> fisica<br />
sperimentale (osservazione dei fenomeni - misurazione matematica dei dati -<br />
ipotesi verifica - legge), appare un po' generico ed incapace di far comprendere le<br />
vie concrete e i modi originali seguiti da Galileo nelle sue scoperte. Di<br />
conseguenza, data l'importanza dell'argomento, risulta indispensabile scavare più a<br />
fondo.<br />
4.1- ____________________________________________________<br />
Nel<strong>la</strong> lettera a Cristina di Lorena Galileo scrive: «Pare che quello degli effetti<br />
naturali che o <strong>la</strong> sensata esperienza ci pone dinanzi agli occhi o le necessarie<br />
dimostrazioni ci concludono, non debba in conto alcuno esser revocato in dubbi»<br />
Questo passo, come tendono a riconoscere gli studi più recenti, è altamente<br />
significativo, poiché in esso Galileo ha racchiuso il cuore stesso del suo metodo e<br />
<strong>la</strong> strada effettivamente seguita nelle sue scoperte.<br />
Con l'espressione «sensate esperienze», che al<strong>la</strong> lettera significa «esperienze dei<br />
sensi», con primario riferimento al<strong>la</strong> vista, Galileo ha voluto evidenziare il<br />
momento osservativo-induttivo del<strong>la</strong> <strong>scienza</strong>, preponderante in talune<br />
scoperte (come quelle re<strong>la</strong>tive ai corpi celesti). Infatti, in certi casi, <strong>la</strong> <strong>scienza</strong><br />
galileiana, attraverso un'attenta ricognizione dei fatti e dei casi partico<strong>la</strong>ri<br />
induce, sul<strong>la</strong> base dello osservazione, una legge generale (ad esempio quel<strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>tiva alle fasi di Venere)<br />
E’questo il momento più comunemente noto del metodo scientifico, denominato<br />
appunto «sperimentale».<br />
Con l'espressione «necessarie dimostrazioni» Galileo ha voluto evidenziare il<br />
momento raziocinativo o ipotetico-deduttivo del<strong>la</strong> <strong>scienza</strong>, preponderante in altre<br />
scoperte (ad esempio quel<strong>la</strong> sul principio d'inerzia o sul<strong>la</strong> caduta dei gravi). È questa<br />
<strong>la</strong> parte meno nota, ma anche <strong>la</strong> più affascinante — ed in taluni casi decisiva — del<br />
metodo galileiano. Le «necessarie dimostrazioni», o «matematiche dimostrazioni»,<br />
sono i ragionamenti logici, condotti su base matematica, attraverso cui il ricercatore,<br />
partendo da una intuizione di base e procedendo per una «supposizione», formu<strong>la</strong> in<br />
teoria le sue ipotesi, riservandosi di verificarle nel<strong>la</strong> pratica. In altre parole, «intuendo»<br />
e «ragionando» lo scienziato, anche sul<strong>la</strong> scorta di pochi dati empirici, perviene<br />
59