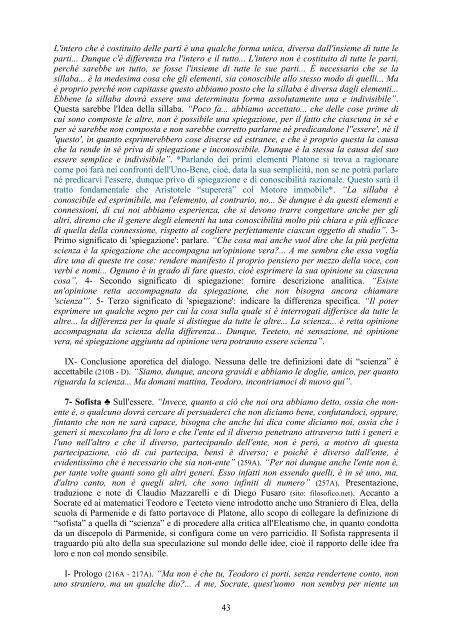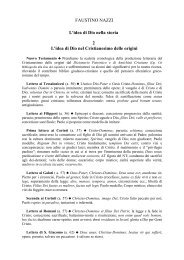Introduzione, Eutifrone, Apologia di Socrate, Critone, Fedone ...
Introduzione, Eutifrone, Apologia di Socrate, Critone, Fedone ...
Introduzione, Eutifrone, Apologia di Socrate, Critone, Fedone ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L'intero che è costituito delle parti è una qualche forma unica, <strong>di</strong>versa dall'insieme <strong>di</strong> tutte le<br />
parti... Dunque c'è <strong>di</strong>fferenza tra l'intero e il tutto... L'intero non è costituito <strong>di</strong> tutte le parti,<br />
perché sarebbe un tutto, se fosse l'insieme <strong>di</strong> tutte le sue parti... È necessario che se la<br />
sillaba... è la medesima cosa che gli elementi, sia conoscibile allo stesso modo <strong>di</strong> quelli... Ma<br />
è proprio perché non capitasse questo abbiamo posto che la sillaba è <strong>di</strong>versa dagli elementi...<br />
Ebbene la sillaba dovrà essere una determinata forma assolutamente una e in<strong>di</strong>visibile”.<br />
Questa sarebbe l'Idea della sillaba. “Poco fa... abbiamo accettato... che delle cose prime <strong>di</strong><br />
cui sono composte le altre, non è possibile una spiegazione, per il fatto che ciascuna in sé e<br />
per sé sarebbe non composta e non sarebbe corretto parlarne né pre<strong>di</strong>candone l''essere', né il<br />
'questo', in quanto esprimerebbero cose <strong>di</strong>verse ed estranee, e che è proprio questa la causa<br />
che la rende in sé priva <strong>di</strong> spiegazione e inconoscibile. Dunque è la stessa la causa del suo<br />
essere semplice e in<strong>di</strong>visibile”. *Parlando dei primi elementi Platone si trova a ragionare<br />
come poi farà nei confronti dell'Uno-Bene, cioè, data la sua semplicità, non se ne potrà parlare<br />
né pre<strong>di</strong>carvi l'essere, dunque privo <strong>di</strong> spiegazione e <strong>di</strong> conoscibilità razionale. Questo sarà il<br />
tratto fondamentale che Aristotele “supererà” col Motore immobile*. “La sillaba è<br />
conoscibile ed esprimibile, ma l'elemento, al contrario, no... Se dunque è da questi elementi e<br />
connessioni, <strong>di</strong> cui noi abbiamo esperienza, che si devono trarre congetture anche per gli<br />
altri, <strong>di</strong>remo che il genere degli elementi ha una conoscibilità molto più chiara e più efficace<br />
<strong>di</strong> quella della connessione, rispetto al cogliere perfettamente ciascun oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o”. 3-<br />
Primo significato <strong>di</strong> 'spiegazione': parlare. “Che cosa mai anche vuol <strong>di</strong>re che la più perfetta<br />
scienza è la spiegazione che accompagna un'opinione vera?... A me sembra che essa voglia<br />
<strong>di</strong>re una <strong>di</strong> queste tre cose: rendere manifesto il proprio pensiero per mezzo della voce, con<br />
verbi e nomi... Ognuno è in grado <strong>di</strong> fare questo, cioè esprimere la sua opinione su ciascuna<br />
cosa”. 4- Secondo significato <strong>di</strong> spiegazione: fornire descrizione analitica. “Esiste<br />
un'opinione retta accompagnata da spiegazione, che non bisogna ancora chiamare<br />
'scienza'”. 5- Terzo significato <strong>di</strong> 'spiegazione': in<strong>di</strong>care la <strong>di</strong>fferenza specifica. “Il poter<br />
esprimere un qualche segno per cui la cosa sulla quale si è interrogati <strong>di</strong>fferisce da tutte le<br />
altre... la <strong>di</strong>fferenza per la quale si <strong>di</strong>stingue da tutte le altre... La scienza... è retta opinione<br />
accompagnata da scienza della <strong>di</strong>fferenza... Dunque, Teeteto, né sensazione, né opinione<br />
vera, né spiegazione aggiunta ad opinione vera potranno essere scienza”.<br />
IX- Conclusione aporetica del <strong>di</strong>alogo. Nessuna delle tre definizioni date <strong>di</strong> “scienza” è<br />
accettabile (210B - D). “Siamo, dunque, ancora gravi<strong>di</strong> e abbiamo le doglie, amico, per quanto<br />
riguarda la scienza... Ma domani mattina, Teodoro, incontriamoci <strong>di</strong> nuovo qui”.<br />
7- Sofista ♣ Sull'essere. “Invece, quanto a ciò che noi ora abbiamo detto, ossia che nonente<br />
è, o qualcuno dovrà cercare <strong>di</strong> persuaderci che non <strong>di</strong>ciamo bene, confutandoci, oppure,<br />
fintanto che non ne sarà capace, bisogna che anche lui <strong>di</strong>ca come <strong>di</strong>ciamo noi, ossia che i<br />
generi si mescolano fra <strong>di</strong> loro e che l'ente ed il <strong>di</strong>verso penetrano attraverso tutti i generi e<br />
l'uno nell'altro e che il <strong>di</strong>verso, partecipando dell'ente, non è però, a motivo <strong>di</strong> questa<br />
partecipazione, ciò <strong>di</strong> cui partecipa, bensì è <strong>di</strong>verso; e poiché è <strong>di</strong>verso dall'ente, è<br />
evidentissimo che è necessario che sia non-ente” (259A). “Per noi dunque anche l'ente non è,<br />
per tante volte quanti sono gli altri generi. Esso infatti non essendo quelli, è in sé uno, ma,<br />
d'altro canto, non è quegli altri, che sono infiniti <strong>di</strong> numero” (257A). Presentazione,<br />
traduzione e note <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o Mazzarelli e <strong>di</strong> Diego Fusaro (sito: filosofico.net). Accanto a<br />
<strong>Socrate</strong> ed ai matematici Teodoro e Teeteto viene introdotto anche uno Straniero <strong>di</strong> Elea, della<br />
scuola <strong>di</strong> Parmenide e <strong>di</strong> fatto portavoce <strong>di</strong> Platone, allo scopo <strong>di</strong> collegare la definizione <strong>di</strong><br />
“sofista” a quella <strong>di</strong> “scienza” e <strong>di</strong> procedere alla critica all'Eleatismo che, in quanto condotta<br />
da un <strong>di</strong>scepolo <strong>di</strong> Parmenide, si configura come un vero parrici<strong>di</strong>o. Il Sofista rappresenta il<br />
traguardo più alto della sua speculazione sul mondo delle idee, cioè il rapporto delle idee fra<br />
loro e non col mondo sensibile.<br />
I- Prologo (216A - 217A). “Ma non è che tu, Teodoro ci porti, senza rendertene conto, non<br />
uno straniero, ma un qualche <strong>di</strong>o?... A me, <strong>Socrate</strong>, quest'uomo non sembra per niente un<br />
43