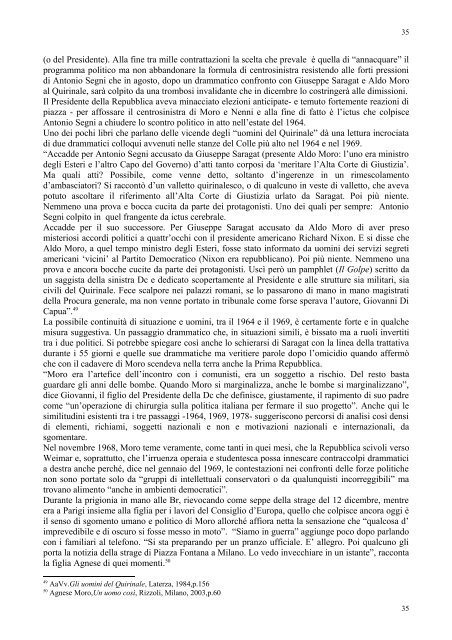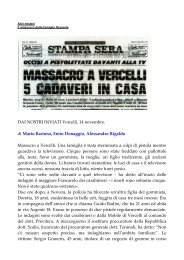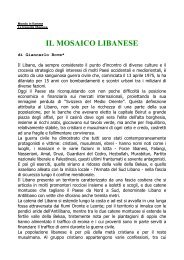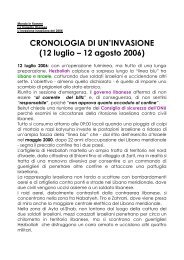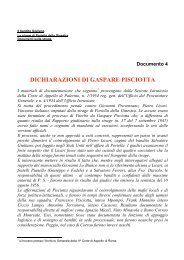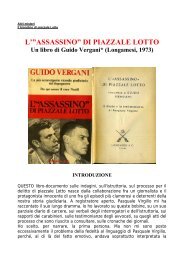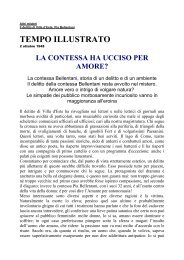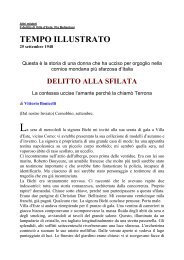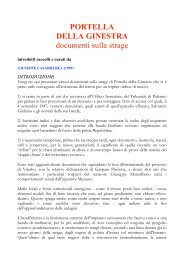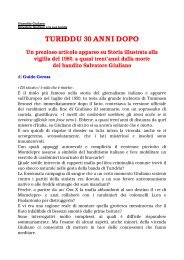Paolo Cucchiarelli - Misteri d'Italia
Paolo Cucchiarelli - Misteri d'Italia
Paolo Cucchiarelli - Misteri d'Italia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
(o del Presidente). Alla fine tra mille contrattazioni la scelta che prevale è quella di “annacquare” il<br />
programma politico ma non abbandonare la formula di centrosinistra resistendo alle forti pressioni<br />
di Antonio Segni che in agosto, dopo un drammatico confronto con Giuseppe Saragat e Aldo Moro<br />
al Quirinale, sarà colpito da una trombosi invalidante che in dicembre lo costringerà alle dimissioni.<br />
Il Presidente della Repubblica aveva minacciato elezioni anticipate- e temuto fortemente reazioni di<br />
piazza - per affossare il centrosinistra di Moro e Nenni e alla fine di fatto è l’ictus che colpisce<br />
Antonio Segni a chiudere lo scontro politico in atto nell’estate del 1964.<br />
Uno dei pochi libri che parlano delle vicende degli “uomini del Quirinale” dà una lettura incrociata<br />
di due drammatici colloqui avvenuti nelle stanze del Colle più alto nel 1964 e nel 1969.<br />
“Accadde per Antonio Segni accusato da Giuseppe Saragat (presente Aldo Moro: l’uno era ministro<br />
degli Esteri e l’altro Capo del Governo) d’atti tanto corposi da ‘meritare l’Alta Corte di Giustizia’.<br />
Ma quali atti? Possibile, come venne detto, soltanto d’ingerenze in un rimescolamento<br />
d’ambasciatori? Si raccontò d’un valletto quirinalesco, o di qualcuno in veste di valletto, che aveva<br />
potuto ascoltare il riferimento all’Alta Corte di Giustizia urlato da Saragat. Poi più niente.<br />
Nemmeno una prova e bocca cucita da parte dei protagonisti. Uno dei quali per sempre: Antonio<br />
Segni colpito in quel frangente da ictus cerebrale.<br />
Accadde per il suo successore. Per Giuseppe Saragat accusato da Aldo Moro di aver preso<br />
misteriosi accordi politici a quattr’occhi con il presidente americano Richard Nixon. E si disse che<br />
Aldo Moro, a quel tempo ministro degli Esteri, fosse stato informato da uomini dei servizi segreti<br />
americani ‘vicini’ al Partito Democratico (Nixon era repubblicano). Poi più niente. Nemmeno una<br />
prova e ancora bocche cucite da parte dei protagonisti. Uscì però un pamphlet (Il Golpe) scritto da<br />
un saggista della sinistra Dc e dedicato scopertamente al Presidente e alle strutture sia militari, sia<br />
civili del Quirinale. Fece scalpore nei palazzi romani, se lo passarono di mano in mano magistrati<br />
della Procura generale, ma non venne portato in tribunale come forse sperava l’autore, Giovanni Di<br />
Capua”. 49<br />
La possibile continuità di situazione e uomini, tra il 1964 e il 1969, è certamente forte e in qualche<br />
misura suggestiva. Un passaggio drammatico che, in situazioni simili, è bissato ma a ruoli invertiti<br />
tra i due politici. Si potrebbe spiegare così anche lo schierarsi di Saragat con la linea della trattativa<br />
durante i 55 giorni e quelle sue drammatiche ma veritiere parole dopo l’omicidio quando affermò<br />
che con il cadavere di Moro scendeva nella terra anche la Prima Repubblica.<br />
“Moro era l’artefice dell’incontro con i comunisti, era un soggetto a rischio. Del resto basta<br />
guardare gli anni delle bombe. Quando Moro si marginalizza, anche le bombe si marginalizzano”,<br />
dice Giovanni, il figlio del Presidente della Dc che definisce, giustamente, il rapimento di suo padre<br />
come “un’operazione di chirurgia sulla politica italiana per fermare il suo progetto”. Anche qui le<br />
similitudini esistenti tra i tre passaggi -1964, 1969, 1978- suggeriscono percorsi di analisi così densi<br />
di elementi, richiami, soggetti nazionali e non e motivazioni nazionali e internazionali, da<br />
sgomentare.<br />
Nel novembre 1968, Moro teme veramente, come tanti in quei mesi, che la Repubblica scivoli verso<br />
Weimar e, soprattutto, che l’irruenza operaia e studentesca possa innescare contraccolpi drammatici<br />
a destra anche perché, dice nel gennaio del 1969, le contestazioni nei confronti delle forze politiche<br />
non sono portate solo da “gruppi di intellettuali conservatori o da qualunquisti incorreggibili” ma<br />
trovano alimento “anche in ambienti democratici”.<br />
Durante la prigionia in mano alle Br, rievocando come seppe della strage del 12 dicembre, mentre<br />
era a Parigi insieme alla figlia per i lavori del Consiglio d’Europa, quello che colpisce ancora oggi è<br />
il senso di sgomento umano e politico di Moro allorché affiora netta la sensazione che “qualcosa d’<br />
imprevedibile e di oscuro si fosse messo in moto”. “Siamo in guerra” aggiunge poco dopo parlando<br />
con i familiari al telefono. “Si sta preparando per un pranzo ufficiale. E’ allegro. Poi qualcuno gli<br />
porta la notizia della strage di Piazza Fontana a Milano. Lo vedo invecchiare in un istante”, racconta<br />
la figlia Agnese di quei momenti. 50<br />
49 AaVv.Gli uomini del Quirinale, Laterza, 1984,p.156<br />
50 Agnese Moro,Un uomo così, Rizzoli, Milano, 2003,p.60<br />
35<br />
35