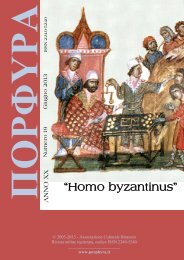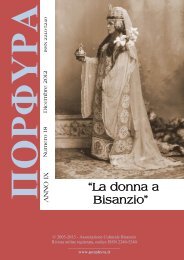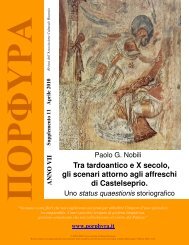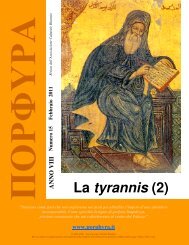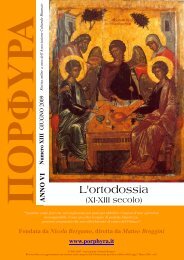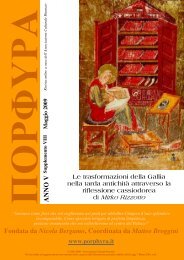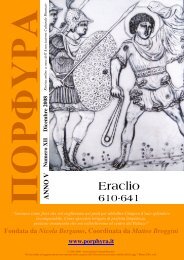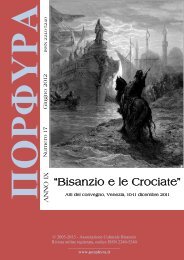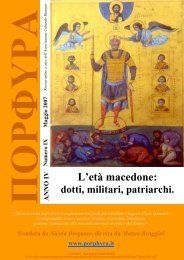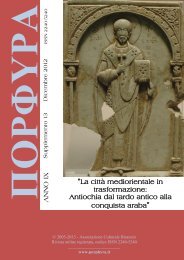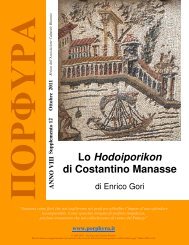qui - Porphyra
qui - Porphyra
qui - Porphyra
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il protocollo contemplava anche la consegna da parte dei senatori del modiolus, 155 un diadema<br />
aureo di dimensioni ridotte che era una sorta di riconoscimento civile dell’imperatore. Il rito civile<br />
<strong>qui</strong>ndi era espressione del consensus universorum verso l’eletto all’impero (il popolo pregava: «la<br />
città ti desidera, l’ecumene ti desidera»), 156 consenso che veniva ad aggiungersi a quello militare e<br />
senatoriale. È importante sottolineare che il consensus universorum rivestiva un ruolo strategico<br />
nel legittimare l’imperatore, tanto che Maiorano (sebbene imperatore occidentale), si preoccupò di<br />
dare forza di legge alla sua elezione, avuta per consenso del Senato e dell’esercito, con la novella<br />
datata 11 gennaio 458: «imperatorem me factum, patres conscripti, vestrae electionis arbitrio et<br />
fortissimi exercitus ordinatione cognioscite». 157 Secondo Ammiano la cerimonia militare non era<br />
valida in un contesto urbano: 158 il rito civile-ecclesiastico serviva <strong>qui</strong>ndi a catalizzare il popolo e a<br />
inglobarlo nell’enorme meccanismo simbolico della basileìa, che si concretizzava nel grido : «Dio<br />
ti ha dato a noi, Dio ti conservi».<br />
I protocolli del XII secolo descrivono un nuovo tipo di cerimonia, 159 dovuta allo stabilizzarsi<br />
della situazione politica e al fatto che gli imperatori fossero quasi tutti porfirogeniti o membri della<br />
stessa famiglia. In questa nuova cerimonia, Il basileus esce dai suoi appartamenti rivestito dello<br />
skaramangion e del sagion, 160 si reca nell’Oinopodion scortato da senatori e dignitari, e <strong>qui</strong> viene<br />
omaggiato dai patrizi. Quindi si reca al concistoro, ove ritto davanti al trono riceve la proskynesis<br />
di tutta la corte. Giunto a S. Sofia, procede verso l’oratorio del mitatorion, 161 ove si riveste del<br />
divitision e del tzitzakion, 162 e, dopo la preghiera presso l’iconostasi e l’offerta dei ceri, sale sull<br />
“ombelico purpureo”, un ambone in porfido ove si trovano, disposti sopra un altare portatile<br />
(antimision), la clamide purpurea e lo stemma con pendulia. 163 Il patriarca, ivi salito con lui, gli<br />
impone la clamide e lo incorona al canto dell’axion, seguito dal gloria. All’uscita, l’imperatore è<br />
accolto dai canti apotropaici dei demi e festeggiato con il consueto banchetto.<br />
Nei successivi protocolli di incoronazione di Manuele Comneno e di Andronico II si notano<br />
ulteriori variazioni. Ritorna in auge il rito della sollevazione sullo scudo, a cui partecipava pure il<br />
patriarca con l’imperatore anziano (se in vita): essi sostenevano la parte anteriore dello scudo<br />
insieme ad altri dignitari (despoti, sebastocratori, cesari o arconti). La cerimonia si svolgeva al<br />
610, cfr. CONST. PORPH., Liber de cerimoniis, 1, 91-95); il rito in S. Sofia si stabilizzò con Costante II (NICEFORO,<br />
Cronografia, 2, p. 30); Leone (NICEFORO, Cronografia, 3, p. 52 e CONST. PORPH., Liber de cerimoniis, 7, 71, 76,<br />
78). Cfr. anche PERTUSI, Le insegne, p. 529.<br />
155 Cfr. CONST. PORPH., Liber de cerimoniis, 1, 94; CHARANIS P., The imperial crown modiolus and its<br />
constitutional significance, in “Byzantion” 12 (1937), p. 190; IDEM, The Crown modiolus once more, in “Byzantion”<br />
13 (1938), pp. 337-381.<br />
156 Sul consensus universorum cfr. gli studi di INSTINSKY H.U., Consensus universorum, in “Hermes” 75 (1940), pp.<br />
265-278.<br />
157 Cfr. Nov. Maior., 1.<br />
158 Cfr. CONST. PORPH., Liber de cerimoniis, 4, 1, 1; MACCORMACK, Arte, p. 365.<br />
159 Tali protocolli contenuti nel Liber de cerimoniis sono aggiunti in calce a quelli dei V-VI secc.<br />
160 Il termine skaramangion, di non chiara derivazione, indica una lunga tunica (il cui colore, generalmente purpureo,<br />
dipendeva dalla festa in cui l’imperatore la indossava) ornata di clavi. Spesso vi comparivano alcune decorazioni, tra le<br />
quali spicca il castorium (perché ricamato con un castoro o decorato col pelo di questo animale), usato da Niceforo<br />
Foca: cfr. SCHLUMBERGER G., Un empereur byzantin au dixième siècle. Nicéphore Phocas, Paris 1923, pp. 211-248.<br />
Il sagion era una mantella purpurea che si poneva sullo skaramangion, con ricami aurei e perle.<br />
161 Interessante è il lavoro di PAPADOPOULOS J.B., Le mutatorium des église des byzantines, in Mémorial L. Petit,<br />
Bucarest 1948, pp. 366-372.<br />
162 Tale termine – come raccontato da CONST. PORPH., Liber de cerimoniis, 1, 1 – era di origine esotica e forse<br />
derivava dalla parola turca chichèk (fiore), nome della sposa di origini cazare di Costantino V. Tale abito, in origine<br />
femminile, venne adottato dalla corte come abito maschile da parata sotto forma di una tunica corta: cfr. WESSEL–<br />
PILTZ–NICOLESCU, Art. Insignien, pp. 420-424.<br />
163 Il simbolismo della pietra su cui viene creato il sovrano dei Romani orientali fu sicuramente assorbito dopo<br />
l’incoronazione di Carlo Magno, che si era inginocchiato sulla rota porphyrea (una lastra purpurea); in realtà esso è<br />
molto più antico e legato all’idea della pietra uranica, caduta dal cielo, che indica il re legittimo: ne sono esempi il lapis<br />
niger di Eliogabalo, la stone of destiny dei Britanni o ancora la Pietra Nera custodita alla Mecca. Cfr. GUÉNON R., Le<br />
roi du monde, Yorks 1983, cap. 9.<br />
21