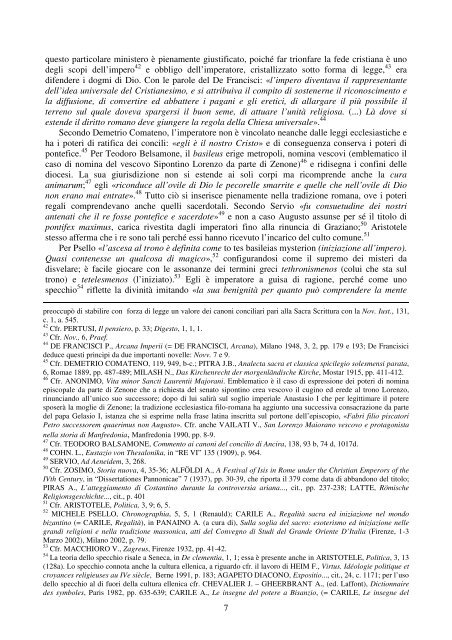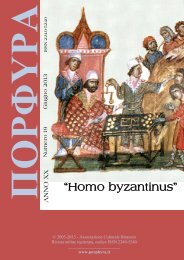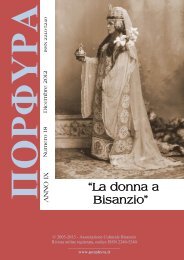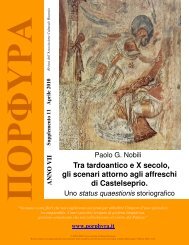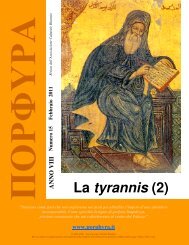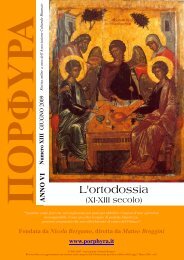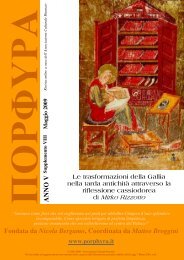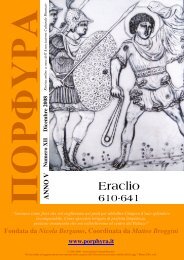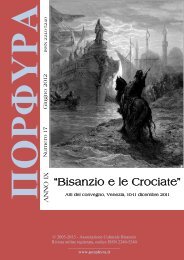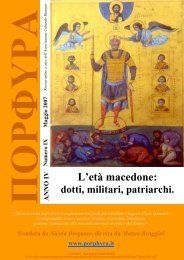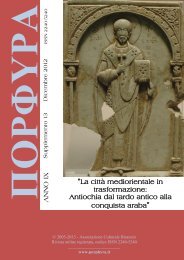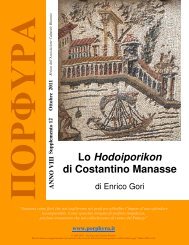qui - Porphyra
qui - Porphyra
qui - Porphyra
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
questo particolare ministero è pienamente giustificato, poiché far trionfare la fede cristiana è uno<br />
degli scopi dell’impero 42 e obbligo dell’imperatore, cristallizzato sotto forma di legge, 43 era<br />
difendere i dogmi di Dio. Con le parole del De Francisci: «l’impero diventava il rappresentante<br />
dell’idea universale del Cristianesimo, e si attribuiva il compito di sostenerne il riconoscimento e<br />
la diffusione, di convertire ed abbattere i pagani e gli eretici, di allargare il più possibile il<br />
terreno sul quale doveva spargersi il buon seme, di attuare l’unità religiosa. (...) Là dove si<br />
estende il diritto romano deve giungere la regola della Chiesa universale». 44<br />
Secondo Demetrio Comateno, l’imperatore non è vincolato neanche dalle leggi ecclesiastiche e<br />
ha i poteri di ratifica dei concili: «egli è il nostro Cristo» e di conseguenza conserva i poteri di<br />
pontefice. 45 Per Teodoro Belsamone, il basileus erige metropoli, nomina vescovi (emblematico il<br />
caso di nomina del vescovo Sipontino Lorenzo da parte di Zenone) 46 e ridisegna i confini delle<br />
diocesi. La sua giurisdizione non si estende ai soli corpi ma ricomprende anche la cura<br />
animarum; 47 egli «riconduce all’ovile di Dio le pecorelle smarrite e quelle che nell’ovile di Dio<br />
non erano mai entrate». 48 Tutto ciò si inserisce pienamente nella tradizione romana, ove i poteri<br />
regali comprendevano anche quelli sacerdotali. Secondo Servio «fu consuetudine dei nostri<br />
antenati che il re fosse pontefice e sacerdote» 49 e non a caso Augusto assunse per sé il titolo di<br />
pontifex maximus, carica rivestita dagli imperatori fino alla rinuncia di Graziano; 50 Aristotele<br />
stesso afferma che i re sono tali perché essi hanno ricevuto l’incarico del culto comune. 51<br />
Per Psello «l’ascesa al trono è definita come to tes basileias mysterion (iniziazione all’impero).<br />
Quasi contenesse un qualcosa di magico», 52 configurandosi come il supremo dei misteri da<br />
disvelare; è facile giocare con le assonanze dei termini greci tethronismenos (colui che sta sul<br />
trono) e tetelesmenos (l’iniziato). 53 Egli è imperatore a guisa di ragione, perché come uno<br />
specchio 54 riflette la divinità imitando «la sua benignità per quanto può comprendere la mente<br />
preoccupò di stabilire con forza di legge un valore dei canoni conciliari pari alla Sacra Scrittura con la Nov. Iust., 131,<br />
c. 1, a. 545.<br />
42 Cfr. PERTUSI, Il pensiero, p. 33; Digesto, 1, 1, 1.<br />
43 Cfr. Nov., 6, Praef.<br />
44 DE FRANCISCI P., Arcana Imperii (= DE FRANCISCI, Arcana), Milano 1948, 3, 2, pp. 179 e 193; De Francisici<br />
deduce questi principi da due importanti novelle: Novv. 7 e 9.<br />
45 Cfr. DEMETRIO COMATENO, 119, 949, b-c.; PITRA J.B., Analecta sacra et classica spicilegio solesmensi parata,<br />
6, Romae 1889, pp. 487-489; MILASH N., Das Kirchenrecht der morgenländische Kirche, Mostar 1915, pp. 411-412.<br />
46 Cfr. ANONIMO, Vita minor Sancti Laurentii Majorani. Emblematico è il caso di espressione dei poteri di nomina<br />
episcopale da parte di Zenone che a richiesta del senato sipontino crea vescovo il cugino ed erede al trono Lorenzo,<br />
rinunciando all’unico suo successore; dopo di lui salirà sul soglio imperiale Anastasio I che per legittimare il potere<br />
sposerà la moglie di Zenone; la tradizione ecclesiastica filo-romana ha aggiunto una successiva consacrazione da parte<br />
del papa Gelasio I, istanza che si esprime nella frase latina inscritta sul portone dell’episcopio, «Fabri filio piscatori<br />
Petro successorem quaerimus non Augusto». Cfr. anche VAILATI V., San Lorenzo Maiorano vescovo e protagonista<br />
nella storia di Manfredonia, Manfredonia 1990, pp. 8-9.<br />
47 Cfr. TEODORO BALSAMONE, Commento ai canoni del concilio di Ancira, 138, 93 b, 74 d, 1017d.<br />
48 COHN. L., Eustazio von Thesalonika, in “RE VI” 135 (1909), p. 964.<br />
49 SERVIO, Ad Aeneidem, 3, 268.<br />
50 Cfr. ZOSIMO, Storia nuova, 4, 35-36; ALFÖLDI A., A Festival of Isis in Rome under the Christian Emperors of the<br />
IVth Century, in “Dissertationes Pannonicae” 7 (1937), pp. 30-39, che riporta il 379 come data di abbandono del titolo;<br />
PIRAS A., L’atteggiamento di Costantino durante la controversia ariana..., cit., pp. 237-238; LATTE, Römische<br />
Religionsgeschichte..., cit., p. 401<br />
51 Cfr. ARISTOTELE, Politica, 3, 9; 6, 5.<br />
52 MICHELE PSELLO, Chronographia, 5, 5, 1 (Renauld); CARILE A., Regalità sacra ed iniziazione nel mondo<br />
bizantino (= CARILE, Regalità), in PANAINO A. (a cura di), Sulla soglia del sacro: esoterismo ed iniziazione nelle<br />
grandi religioni e nella tradizione massonica, atti del Convegno di Studi del Grande Oriente D’Italia (Firenze, 1-3<br />
Marzo 2002), Milano 2002, p. 79.<br />
53 Cfr. MACCHIORO V., Zagreus, Firenze 1932, pp. 41-42.<br />
54 La teoria dello specchio risale a Seneca, in De clementia, 1, 1; essa è presente anche in ARISTOTELE, Politica, 3, 13<br />
(128a). Lo specchio connota anche la cultura ellenica, a riguardo cfr. il lavoro di HEIM F., Virtus. Idéologie politique et<br />
croyances religieuses au IVe siècle, Berne 1991, p. 183; AGAPETO DIACONO, Expositio..., cit., 24, c. 1171; per l’uso<br />
dello specchio al di fuori della cultura ellenica cfr. CHEVALIER J. – GHEERBRANT A., (ed. Laffont), Dictionnaire<br />
des symboles, Paris 1982, pp. 635-639; CARILE A., Le insegne del potere a Bisanzio, (= CARILE, Le insegne del<br />
7