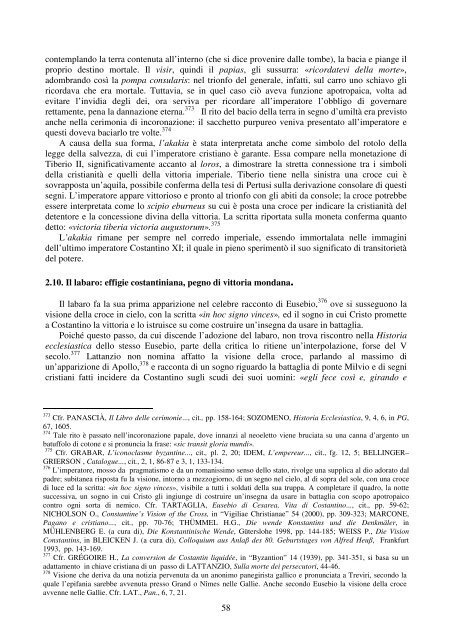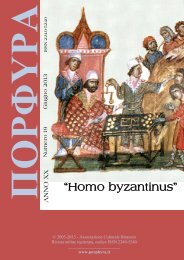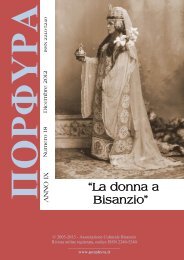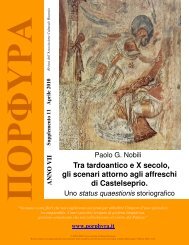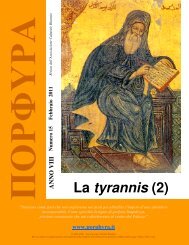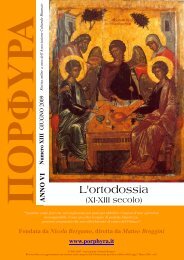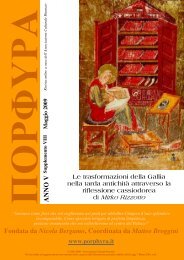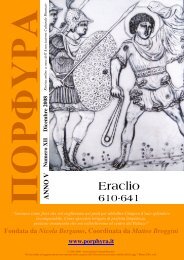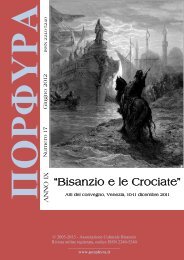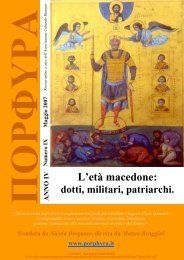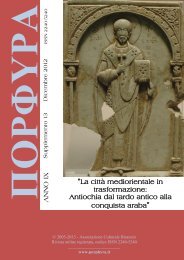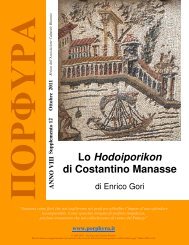qui - Porphyra
qui - Porphyra
qui - Porphyra
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
contemplando la terra contenuta all’interno (che si dice provenire dalle tombe), la bacia e piange il<br />
proprio destino mortale. Il visir, <strong>qui</strong>ndi il papias, gli sussurra: «ricordatevi della morte»,<br />
adombrando così la pompa consularis: nel trionfo del generale, infatti, sul carro uno schiavo gli<br />
ricordava che era mortale. Tuttavia, se in quel caso ciò aveva funzione apotropaica, volta ad<br />
evitare l’invidia degli dei, ora serviva per ricordare all’imperatore l’obbligo di governare<br />
rettamente, pena la dannazione eterna. 373 Il rito del bacio della terra in segno d’umiltà era previsto<br />
anche nella cerimonia di incoronazione: il sacchetto purpureo veniva presentato all’imperatore e<br />
questi doveva baciarlo tre volte. 374<br />
A causa della sua forma, l’akakia è stata interpretata anche come simbolo del rotolo della<br />
legge della salvezza, di cui l’imperatore cristiano è garante. Essa compare nella monetazione di<br />
Tiberio II, significativamente accanto al loros, a dimostrare la stretta connessione tra i simboli<br />
della cristianità e quelli della vittoria imperiale. Tiberio tiene nella sinistra una croce cui è<br />
sovrapposta un’a<strong>qui</strong>la, possibile conferma della tesi di Pertusi sulla derivazione consolare di questi<br />
segni. L’imperatore appare vittorioso e pronto al trionfo con gli abiti da console; la croce potrebbe<br />
essere interpretata come lo scipio eburneus su cui è posta una croce per indicare la cristianità del<br />
detentore e la concessione divina della vittoria. La scritta riportata sulla moneta conferma quanto<br />
detto: «victoria tiberia victoria augustorum». 375<br />
L’akakia rimane per sempre nel corredo imperiale, essendo immortalata nelle immagini<br />
dell’ultimo imperatore Costantino XI; il quale in pieno sperimentò il suo significato di transitorietà<br />
del potere.<br />
2.10. Il labaro: effigie costantiniana, pegno di vittoria mondana.<br />
Il labaro fa la sua prima apparizione nel celebre racconto di Eusebio, 376 ove si susseguono la<br />
visione della croce in cielo, con la scritta «in hoc signo vinces», ed il sogno in cui Cristo promette<br />
a Costantino la vittoria e lo istruisce su come costruire un’insegna da usare in battaglia.<br />
Poiché questo passo, da cui discende l’adozione del labaro, non trova riscontro nella Historia<br />
ecclesiastica dello stesso Eusebio, parte della critica lo ritiene un’interpolazione, forse del V<br />
secolo. 377 Lattanzio non nomina affatto la visione della croce, parlando al massimo di<br />
un’apparizione di Apollo, 378 e racconta di un sogno riguardo la battaglia di ponte Milvio e di segni<br />
cristiani fatti incidere da Costantino sugli scudi dei suoi uomini: «egli fece così e, girando e<br />
373<br />
Cfr. PANASCIÀ, Il Libro delle cerimonie..., cit., pp. 158-164; SOZOMENO, Historia Ecclesiastica, 9, 4, 6, in PG,<br />
67, 1605.<br />
374<br />
Tale rito è passato nell’incoronazione papale, dove innanzi al neoeletto viene bruciata su una canna d’argento un<br />
batuffolo di cotone e si pronuncia la frase: «sic transit gloria mundi».<br />
375 Cfr. GRABAR, L’iconoclasme byzantine..., cit., pl. 2, 20; IDEM, L’empereur..., cit., fg. 12, 5; BELLINGER–<br />
GRIERSON , Catalogue..., cit., 2, 1, 86-87 e 3, 1, 133-134.<br />
376<br />
L’imperatore, mosso da pragmatismo e da un romanissimo senso dello stato, rivolge una supplica al dio adorato dal<br />
padre; subitanea risposta fu la visione, intorno a mezzogiorno, di un segno nel cielo, al di sopra del sole, con una croce<br />
di luce ed la scritta: «in hoc signo vinces», visibile a tutti i soldati della sua truppa. A completare il quadro, la notte<br />
successiva, un sogno in cui Cristo gli ingiunge di costruire un’insegna da usare in battaglia con scopo apotropaico<br />
contro ogni sorta di nemico. Cfr. TARTAGLIA, Eusebio di Cesarea, Vita di Costantino..., cit., pp. 59-62;<br />
NICHOLSON O., Constantine’s Vision of the Cross, in “Vigiliae Christianae” 54 (2000), pp. 309-323; MARCONE,<br />
Pagano e cristiano..., cit., pp. 70-76; THÜMMEL H.G., Die wende Konstantins und die Denkmäler, in<br />
MÜHLENBERG E. (a cura di), Die Konstantinische Wende, Güterslohe 1998, pp. 144-185; WEISS P., Die Vision<br />
Constantins, in BLEICKEN J. (a cura di), Collo<strong>qui</strong>um aus Anlaβ des 80. Geburtstages von Alfred Heuβ, Frankfurt<br />
1993, pp. 143-169.<br />
377<br />
Cfr. GRÉGOIRE H., La conversion de Costantin li<strong>qui</strong>dée, in “Byzantion” 14 (1939), pp. 341-351, si basa su un<br />
adattamento in chiave cristiana di un passo di LATTANZIO, Sulla morte dei persecutori, 44-46.<br />
378<br />
Visione che deriva da una notizia pervenuta da un anonimo panegirista gallico e pronunciata a Treviri, secondo la<br />
quale l’epifania sarebbe avvenuta presso Grand o Nîmes nelle Gallie. Anche secondo Eusebio la visione della croce<br />
avvenne nelle Gallie. Cfr. LAT., Pan., 6, 7, 21.<br />
58