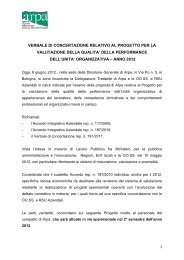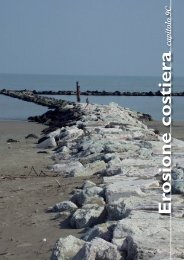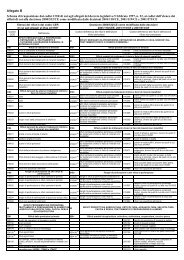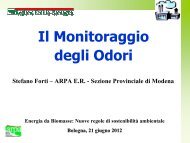Il Radon ambientale in Emilia-Romagna - Arpa
Il Radon ambientale in Emilia-Romagna - Arpa
Il Radon ambientale in Emilia-Romagna - Arpa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3. INDAGINI GEOLOGICHE PER LA CONOSCENZA E LA<br />
PREVENZIONE DEL RISCHIO “RADON”<br />
Luca Martelli – Regione <strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong> - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli<br />
3.1 Introduzione<br />
Un aspetto fondamentale per la conoscenza e prevenzione del rischio “<strong>Radon</strong>” è la def<strong>in</strong>izione delle<br />
condizioni geologiche locali; gli aspetti geologici che pr<strong>in</strong>cipalmente <strong>in</strong>fluiscono sulle emissioni di<br />
radon sono la composizione geochimica delle rocce (presenza di elementi capaci di generare radon)<br />
e le vie di connessione tra le rocce “madri” e i serbatoi naturali di radon e la superficie.<br />
La trasmissione di gas tra sottosuolo e superficie avviene grazie alla porosità delle rocce<br />
(permeabilità primaria) e attraverso le faglie e i sistemi di fratturazione (permeabilità secondaria).<br />
Per la caratterizzazione delle litologie e dei pr<strong>in</strong>cipali sistemi di faglie è stata predisposta una carta<br />
di riferimento, alla scala 1:250.000, appositamente derivata dalla Carta Geologico-Strutturale<br />
dell’Appenn<strong>in</strong>o <strong>Emilia</strong>no-Romagnolo alla scala 1:250.000 (1) e dalla cartografia geologica regionale<br />
alla scala 1:10.000 e 1:25.000 (2) . Tale cartografia, qui non riprodotta per la sua complessità, è<br />
consultabile presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>.<br />
Sulla base di precedenti analoghe <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i (3) e di dati di letteratura specialistica, nella carta<br />
geologica di riferimento predisposta per l’<strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>, le rocce affioranti sono state<br />
raggruppate <strong>in</strong> base a litologia prevalente, stima della permeabilità ed età (MA = Milioni di Anni).<br />
3.2 Classificazione litologica<br />
Per la pianura padana e la costa i depositi affioranti sono state raggruppati nelle seguenti classi:<br />
• argille e limi di piana alluvionale e di laguna; permeabilità primaria generalmente bassa;<br />
spessore variabile da qualche dec<strong>in</strong>a ad alcune cent<strong>in</strong>aia di metri; età: Pleistocene medio (0.8<br />
MA – Presente);<br />
• sabbie di canale e di arg<strong>in</strong>e fluviale e sabbie costiere; permeabilità primaria medio-alta; spessore<br />
variabile da qualche metro a poche dec<strong>in</strong>e di metri; età: Pleistocene medio (0.8 MA – Presente);<br />
• ghiaie e sabbie di conoide; permeabilità primaria alta; spessore variabile da diverse dec<strong>in</strong>e a<br />
pochi metri andando dal marg<strong>in</strong>e verso la pianura e la costa; età: Pleistocene medio (0.8 MA –<br />
Presente).<br />
Per la zona appenn<strong>in</strong>ica, cioè la montagna e la zona coll<strong>in</strong>are f<strong>in</strong>o al limite morfologico che segna il<br />
passaggio alla pianura, i depositi e le rocce affioranti sono stati raggruppati nelle seguenti classi:<br />
• depositi alluvionali di fondovalle e terrazzati e depositi fluvio-lacustri <strong>in</strong>tramontani, costituiti da<br />
ghiaie, sabbie e limi con buona permeabilità primaria; spessore variabile da pochi metri ad<br />
alcune dec<strong>in</strong>e di metri; età: Pliocene superiore term<strong>in</strong>ale (2 MA – Presente);<br />
• prevalenti arenarie, generalmente poco cementate, sabbie e alternanze sabbioso-pelitiche con<br />
livelli ghiaiosi e rari <strong>in</strong>tervalli pelitici; buona permeabilità primaria e secondaria; spessore<br />
variabile da poche a diverse dec<strong>in</strong>e di metri; età: Mess<strong>in</strong>iano superiore - Pleistocene medio (6 –<br />
0.65 MA);<br />
• argille e argille marnose, con <strong>in</strong>tercalazioni di sabbie e arenarie e livelli di slump; bassa<br />
permeabilità; spessore variabile da alcune dec<strong>in</strong>e a oltre mille metri; età: Mess<strong>in</strong>iano superiore –<br />
Pleistocene <strong>in</strong>feriore (6 - 1 MA);<br />
• gessi e calcari evaporitici con <strong>in</strong>tervalli argillosi e gessoareniti; permeabilità per fratturazione e<br />
carsismo; spessore di alcune dec<strong>in</strong>e di metri, talora raddoppiato da ripetizioni tettoniche; età:<br />
Mess<strong>in</strong>iano <strong>in</strong>feriore - medio (6.5 - 6 MA);<br />
35