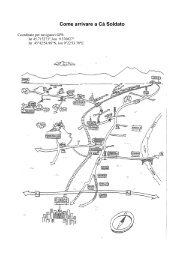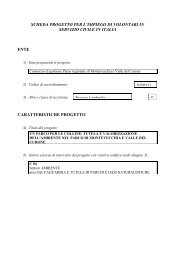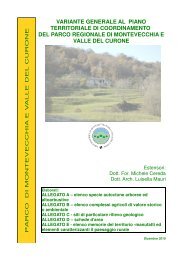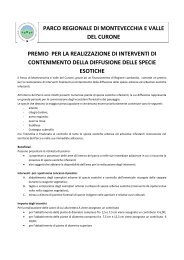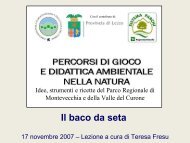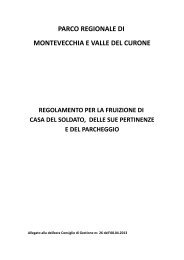rapporto ambientale VAS Parco Naturale - Parco di Montevecchia e ...
rapporto ambientale VAS Parco Naturale - Parco di Montevecchia e ...
rapporto ambientale VAS Parco Naturale - Parco di Montevecchia e ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>VAS</strong> – Piano del <strong>Parco</strong> <strong>Naturale</strong> - Proposta <strong>di</strong> <strong>rapporto</strong> <strong>ambientale</strong> e stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> incidenza 2010d'acqua dolce (Austropotamobius pallipes), un crostaceo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a taglia e <strong>di</strong> abitu<strong>di</strong>ni prettamente notturne.Il gambero è presente in un fontanile, quello <strong>di</strong> Mirasole, che anticamente riforniva <strong>di</strong> acque i giar<strong>di</strong>ni dellavilla Gallarati-Scotti della frazione Oreno <strong>di</strong> Vimercate.In tutti gli affluenti in cui è presente, il gambero non raggiunge mai l'asta del torrente principale, per cui si puòparlare <strong>di</strong> popolazioni tutte, <strong>di</strong> norma, isolate tra loro; é probabile che sia la presenza della trota, dove leacque sono più copiose, ad impe<strong>di</strong>re <strong>di</strong> fatto uno stabile collegamento tra le varie popolazioni. Le acque deitorrenti principali, sia Curone sia Molgoretta, non appaiono infatti inquinate nei tratti in questione(rispettivamente me<strong>di</strong>a e alta valle del Curone e alta valle <strong>di</strong> Santa Croce).I fontanili del <strong>Parco</strong> <strong>di</strong> <strong>Montevecchia</strong> e della Valle del Curone sono rari in quanto le con<strong>di</strong>zioni che generanoquesto fenomeno sono limitate a fon<strong>di</strong> vallivi o ai pie<strong>di</strong> <strong>di</strong> scarpate <strong>di</strong> natura fluvio-glaciale dove localmente sipuò verificare una variazione <strong>di</strong> permeabilità del terreno che comporta la risalita delle acque <strong>di</strong> falda e <strong>di</strong>drenaggio. La zona dei fontanili all‟interno del <strong>Parco</strong> costituisce un‟area molto particolare in quanto molto piùa nord rispetto alla “fascia delle risorgive”. La spiegazione è da ricercarsi nella formazione <strong>di</strong> una piccolavalle fluviale, delimitata dai terrazzamenti del Mirasole e <strong>di</strong> Valaperta, percorsa dai meandri del torrenteLavandaia. Qui lo strato impermeabile determina la presenza <strong>di</strong> acqua ad una profon<strong>di</strong>tà inferiore ai 10metri. Man mano che si scende a valle tale profon<strong>di</strong>tà si riduce ad un paio <strong>di</strong> metri ed in concomitanza <strong>di</strong>depressioni si presenta la risorgiva.Il perché questo lembo <strong>di</strong> terra abbia sviluppato un “sistema delle acque” trova la sua ragione “economica”nel fatto che si trovava stretto tra due sistemi produttivi dettati dalle peculiarità dei territori confinanti. A nor<strong>di</strong>niziavano le colline della Brianza, ricche <strong>di</strong> legname, castagne, vini pregiati; a sud vi era l‟alta pianuraMilanese dove l‟agricoltura (cereali, prati da sfalcio) poteva, grazie al latifondo, operare su larga scala. Aquesto lembo <strong>di</strong> terra (dove al latifondo si affiancavano anche le numerose piccole proprietà) restavanopoche possibilità per la competizione quin<strong>di</strong> la popolazione, sin dal me<strong>di</strong>oevo, aveva integrato l‟attivitàagricola con attività artigianali. Allo sfalcio si era aggiunta la coltivazione e lavorazione del lino con il suoindotto. Si ha fondata ragione <strong>di</strong> credere che taluni mulini non erano de<strong>di</strong>ti alla macinazione delle granaglie,bensì avessero un uso industriale legato alla lavorazione del lino. Dunque il territorio aveva sviluppato lapropria economia sfruttando al meglio la risorsa “acqua” .La gestione della risorsa acqua (e delle strade) interessava tutte le comunità. Spesso veniva regolamentatada usi locali a volte contrastanti con la “città <strong>di</strong> Milano” . Nel 1346 la città <strong>di</strong> Milano re<strong>di</strong>ge la “rubrica generalede l‟aqua e de la rasone de li molini e de le strade” meglio nota come “Statuti delle acque e delle strade”. Erauno statuto <strong>di</strong> 100 articoli che regolava una materia complessa, dettato dal buon senso e dalla concretezzatanto che rimase <strong>di</strong> fatto in vigore, per <strong>di</strong>rimere le <strong>di</strong>spute legali, fino agli inizi del „900.Lo sfruttamento delle acque avveniva con l‟irreggimentare i corsi naturali dei torrenti Lavandaia, Curone, eMolgoretta con sistemi <strong>di</strong> chiuse e <strong>di</strong> canali <strong>di</strong> prelievo e ri<strong>di</strong>stribuzione. A questo flusso si aggiungeva laportata dei fontanili. Il fontanile, “Gallarati Scotti” (detto anche Fontana nuova o Fontana <strong>di</strong> mezzo) eracentrale rispetto ad altre due teste ora interrate. Verso il Mirasole vi era il fontanile detto “Fontana delMaressolo” mentre quello verso il torrente Lavandaia era detto “Fontanone”. Le tre aste confluivano in unsolo canale <strong>di</strong> portata significativa, parte integrante <strong>di</strong> una rete idrica che andava a muovere i mulini a valle.Le prime notizie che si hanno sui Fontanili del <strong>Parco</strong>, sono desunte da documenti che riguardano lacessione e la locazione <strong>di</strong> terreni dalla cui descrizione è possibile ricostruire una mappa del territorio. Nel14