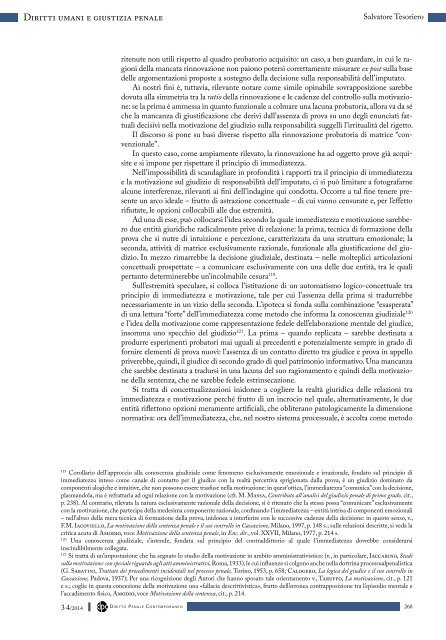Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Diritti umani e giustizia penale<br />
Salvatore Tesoriero<br />
ritenute non utili rispetto al quadro probatorio acquisito: un caso, a ben guardare, in cui le ragioni<br />
della mancata rinnovazione non paiono potersi correttamente misurare ex post sulla base<br />
delle argomentazioni proposte a sostegno della decisione sulla responsabilità dell’imputato.<br />
Ai nostri fini è, tuttavia, rilevante notare come simile opinabile sovrapposizione sarebbe<br />
dovuta alla simmetria tra la ratio della rinnovazione e le cadenze del controllo sulla motivazione:<br />
se la prima è ammessa in quanto funzionale a colmare una lacuna probatoria, allora va da sé<br />
che la mancanza di giustificazione che derivi dall’assenza di prova su uno degli enunciati fattuali<br />
decisivi nella motivazione del giudizio sulla responsabilità suggelli l’irritualità del rigetto.<br />
Il discorso si pone su basi diverse rispetto alla rinnovazione probatoria di matrice “convenzionale”.<br />
In questo caso, come ampiamente rilevato, la rinnovazione ha ad oggetto prove già acquisite<br />
e si impone per rispettare il principio di immediatezza.<br />
Nell’impossibilità di scandagliare in profondità i rapporti tra il principio di immediatezza<br />
e la motivazione sul giudizio di responsabilità dell’imputato, ci si può limitare a fotografarne<br />
alcune interferenze, rilevanti ai fini dell’indagine qui condotta. Occorre a tal fine tenere presente<br />
un arco ideale – frutto di astrazione concettuale – di cui vanno censurate e, per l’effetto<br />
rifiutate, le opzioni collocabili alle due estremità.<br />
Ad una di esse, può collocarsi l’idea secondo la quale immediatezza e motivazione sarebbero<br />
due entità giuridiche radicalmente prive di relazione: la prima, tecnica di formazione della<br />
prova che si nutre di intuizione e percezione, caratterizzata da una struttura emozionale; la<br />
seconda, attività di matrice esclusivamente razionale, funzionale alla giustificazione del giudizio.<br />
In mezzo rimarrebbe la decisione giudiziale, destinata – nelle molteplici articolazioni<br />
concettuali prospettate – a comunicare esclusivamente con una delle due entità, tra le quali<br />
pertanto determinerebbe un’incolmabile cesura 119 .<br />
Sull’estremità speculare, si colloca l’istituzione di un automatismo logico-concettuale tra<br />
principio di immediatezza e motivazione, tale per cui l’assenza della prima si tradurrebbe<br />
necessariamente in un vizio della seconda. L’ipoteca si fonda sulla combinazione “esasperata”<br />
di una lettura “forte” dell’immediatezza come metodo che informa la conoscenza giudiziale 120<br />
e l’idea della motivazione come rappresentazione fedele dell’elaborazione mentale del giudice,<br />
insomma uno specchio del giudizio 121 . La prima – quando replicata – sarebbe destinata a<br />
produrre esperimenti probatori mai uguali ai precedenti e potenzialmente sempre in grado di<br />
fornire elementi di prova nuovi: l’assenza di un contatto diretto tra giudice e prova in appello<br />
priverebbe, quindi, il giudice di secondo grado di quel patrimonio informativo. Una mancanza<br />
che sarebbe destinata a tradursi in una lacuna del suo ragionamento e quindi della motivazione<br />
della sentenza, che ne sarebbe fedele estrinsecazione.<br />
Si tratta di concettualizzazioni inidonee a cogliere la realtà giuridica delle relazioni tra<br />
immediatezza e motivazione perché frutto di un incrocio nel quale, alternativamente, le due<br />
entità riflettono opzioni meramente artificiali, che obliterano patologicamente la dimensione<br />
normativa: ora dell’immediatezza, che, nel nostro sistema processuale, è accolta come metodo<br />
119<br />
Corollario dell’approccio alla conoscenza giudiziale come fenomeno esclusivamente emozionale e irrazionale, fondato sul principio di<br />
immediatezza inteso come canale di contatto per il giudice con la realtà percettiva sprigionata dalla prova, è un giudizio dominato da<br />
componenti alogiche e intuitive, che non possono essere trasfuse nella motivazione: in quest’ottica, l’immediatezza “comunica” con la decisione,<br />
plasmandola, ma è refrattaria ad ogni relazione con la motivazione (cfr. M. Massa, Contributo all’analisi del giudizio penale di primo grado, cit.,<br />
p. 238). Al contrario, rilevata la natura esclusivamente razionale della decisione, si è ritenuto che la stessa possa “comunicare” esclusivamente<br />
con la motivazione, che partecipa della medesima componente razionale, confinando l’immediatezza – entità intrisa di componenti emozionali<br />
– nell’alveo della mera tecnica di formazione della prova, inidonea a interferire con le successive cadenze della decisione: in questo senso, v.,<br />
F.M. Iacoviello, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione, Milano, 1997, p. 148 s.; sulle relazioni descritte, si veda la<br />
critica acuta di Amodio, voce Motivazione della sentenza penale, in Enc. dir., vol. XXVII, Milano, 1977, p. 214 s.<br />
120<br />
Una conoscenza giudiziale, s’intende, fondata sul principio del contraddittorio al quale l’immediatezza dovrebbe considerarsi<br />
inscindibilmente collegata.<br />
121<br />
Si tratta di un’impostazione che ha segnato lo studio della motivazione in ambito amministrativistico: (v., in particolare, Iaccarino, Studi<br />
sulla motivazione: con speciale riguardo agli atti amministrativi, Roma, 1933), le cui influenze si colgono anche nella dottrina processualpenalistica<br />
(G. Sabatini, Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale, Torino, 1953, p. 658; Calogero, La logica del giudice e il suo controllo in<br />
Cassazione, Padova, 1937); Per una ricognizione degli Autori che hanno sposato tale orientamento v., Taruffo, La motivazione, cit., p. 121<br />
e s.; coglie in questa concezione della motivazione una «fallacia descrittivistica», frutto dell’erronea contrapposizione tra l’episodio mentale e<br />
l’accadimento fisico, Amodio, voce Motivazione della sentenza, cit., p. 214.<br />
3 - 4/<strong>2014</strong> 268