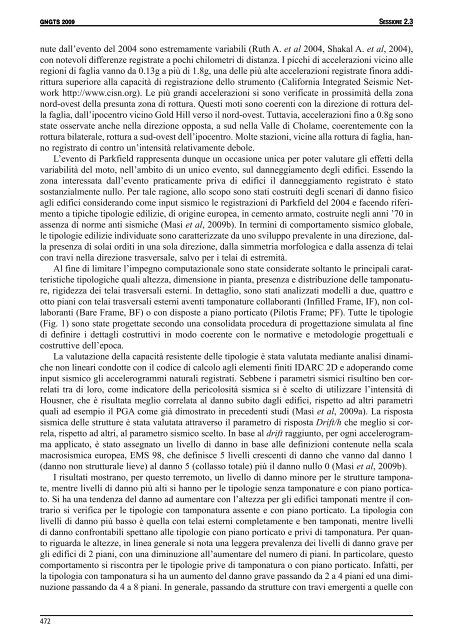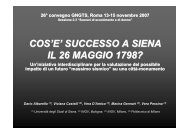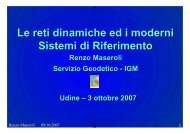Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
GNGTS 2009 SESSIONE <strong>2.3</strong><br />
nute dall’evento del 2004 sono estremamente variabili (Ruth A. et al 2004, Shakal A. et al, 2004),<br />
con notevoli differenze registrate a pochi chilometri di distanza. I picchi di accelerazioni vicino alle<br />
regioni di faglia vanno da 0.13g a più di 1.8g, una delle più alte accelerazioni registrate finora addirittura<br />
superiore alla capacità di registrazione dello strumento (California Integrated Seismic Network<br />
http://www.cisn.org). Le più grandi accelerazioni si sono verificate in prossimità della zona<br />
nord-ovest della presunta zona di rottura. Questi moti sono coerenti con la direzione di rottura della<br />
faglia, dall’ipocentro vicino Gold Hill verso il nord-ovest. Tuttavia, accelerazioni fino a 0.8g sono<br />
state osservate anche nella direzione opposta, a sud nella Valle di Cholame, coerentemente con la<br />
rottura bilaterale, rottura a sud-ovest dell’ipocentro. Molte stazioni, vicine alla rottura di faglia, hanno<br />
registrato di contro un’intensità relativamente debole.<br />
L’evento di Parkfield rappresenta dunque un occasione unica per poter valutare gli effetti della<br />
variabilità del moto, nell’ambito di un unico evento, sul danneggiamento degli edifici. Essendo la<br />
zona interessata dall’evento praticamente priva di edifici il danneggiamento registrato è stato<br />
sostanzialmente nullo. Per tale ragione, allo scopo sono stati costruiti degli scenari di danno fisico<br />
agli edifici considerando come input sismico le registrazioni di Parkfield del 2004 e facendo riferimento<br />
a tipiche tipologie edilizie, di origine europea, in cemento armato, costruite negli anni ’70 in<br />
assenza di norme anti sismiche (Masi et al, 2009b). In termini di comportamento sismico globale,<br />
le tipologie edilizie individuate sono caratterizzate da uno sviluppo prevalente in una direzione, dalla<br />
presenza di solai orditi in una sola direzione, dalla simmetria morfologica e dalla assenza di telai<br />
con travi nella direzione trasversale, salvo per i telai di estremità.<br />
Al fine di limitare l’impegno computazionale sono state considerate soltanto le principali caratteristiche<br />
tipologiche quali altezza, dimensione in pianta, presenza e distribuzione delle tamponature,<br />
rigidezza dei telai trasversali esterni. In dettaglio, sono stati analizzati modelli a due, quattro e<br />
otto piani con telai trasversali esterni aventi tamponature collaboranti (Infilled Frame, IF), non collaboranti<br />
(Bare Frame, BF) o con disposte a piano porticato (Pilotis Frame; PF). Tutte le tipologie<br />
(Fig. 1) sono state progettate secondo una consolidata procedura di progettazione simulata al fine<br />
di definire i dettagli costruttivi in modo coerente con le normative e metodologie progettuali e<br />
costruttive dell’epoca.<br />
La valutazione della capacità resistente delle tipologie è stata valutata mediante analisi dinamiche<br />
non lineari condotte con il codice di calcolo agli elementi finiti IDARC 2D e adoperando come<br />
input sismico gli accelerogrammi naturali registrati. Sebbene i parametri sismici risultino ben correlati<br />
tra di loro, come indicatore della pericolosità sismica si è scelto di utilizzare l’intensità di<br />
Housner, che è risultata meglio correlata al danno subito dagli edifici, rispetto ad altri parametri<br />
quali ad esempio il PGA come già dimostrato in precedenti studi (Masi et al, 2009a). La risposta<br />
sismica delle strutture è stata valutata attraverso il parametro di risposta Drift/h che meglio si correla,<br />
rispetto ad altri, al parametro sismico scelto. In base al drift raggiunto, per ogni accelerogramma<br />
applicato, è stato assegnato un livello di danno in base alle definizioni contenute nella scala<br />
macrosismica europea, EMS 98, che definisce 5 livelli crescenti di danno che vanno dal danno 1<br />
(danno non strutturale lieve) al danno 5 (collasso totale) più il danno nullo 0 (Masi et al, 2009b).<br />
I risultati mostrano, per questo terremoto, un livello di danno minore per le strutture tamponate,<br />
mentre livelli di danno più alti si hanno per le tipologie senza tamponature e con piano porticato.<br />
Si ha una tendenza del danno ad aumentare con l’altezza per gli edifici tamponati mentre il contrario<br />
si verifica per le tipologie con tamponatura assente e con piano porticato. La tipologia con<br />
livelli di danno più basso è quella con telai esterni completamente e ben tamponati, mentre livelli<br />
di danno confrontabili spettano alle tipologie con piano porticato e privi di tamponatura. Per quanto<br />
riguarda le altezze, in linea generale si nota una leggera prevalenza dei livelli di danno grave per<br />
gli edifici di 2 piani, con una diminuzione all’aumentare del numero di piani. In particolare, questo<br />
comportamento si riscontra per le tipologie prive di tamponatura o con piano porticato. Infatti, per<br />
la tipologia con tamponatura si ha un aumento del danno grave passando da 2 a 4 piani ed una diminuzione<br />
passando da 4 a 8 piani. In generale, passando da strutture con travi emergenti a quelle con<br />
472