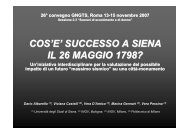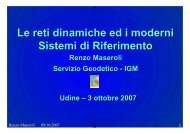Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
GNGTS 2009 SESSIONE <strong>2.3</strong><br />
zioni predittive empiriche all’interno dell’algoritmo ShakeMap (che converte accelerazioni e velocità<br />
in intensità). La KF può venire infatti vista (anche seguendo un suggerimento di Molchan et al.,<br />
2004), come una relazione semi-empirica che simula il calo dell’intensità con la distanza da una sorgente<br />
finita, a rottura bilaterale anche assimmetrica, con meccanismo definito.<br />
Confronto fra ShakeMap e intensità osservate in campagna. Rinviando all’articolo esteso<br />
(Pettenati et al., 2009), mostriamo qui soltanto il paragone fra le 223 intensità Quest osservate in<br />
campagna nei giorni successivi all’evento del 6 aprile e le due ShakeMap disponibili poco dopo il<br />
verificarsi dello stesso evento. Il confronto -qui solo qualitativo- è facilitato da alcuni accorgimenti<br />
adottati per disegnare le Figg. 1 e 2.<br />
Ridisegno dei dati originali ShakeMap e Quest. I dati Quest sono stati conturati con l’algoritmo<br />
n-n (Sirovich et al., 2002), che ricordiamo onora perfettamente i dati sperimentali. A differenza<br />
di altri lavori precedenti (quando li arrotondavamo per default al grado successivo), in questo caso<br />
i gradi incerti (es.: V-VI) sono stati trattati come numeri reali (es. 5.5) e le isosiste passano per i<br />
mezzi gradi. In altre parole, i grigi adottati nella Fig. 1 (ed anche nella Fig. 2) corrispondono ad<br />
arrotondamenti al numero intero. Per facilitare il paragone ed evidenziare dettagli, che aiutino a<br />
cogliere visivamente la struttura delle ShakeMap (sia USGS che INGV), abbiamo: 1) omesso il<br />
modello digitale del terreno; 2) utilizzato i file x;y;z tracciando le isolinee che passano per i mezzi<br />
gradi.<br />
Discussione. Risulta subito evidente che le isolinee approssimativamente concentriche delle<br />
Figg. 2a e 2b non sono centrate rispetto all’immagine in Fig. 1. Si tenga presente che la ‘pietra di<br />
paragone’ in Fig. 1 comprende tutti i siti rilevati dalle squadre Quest e che non ci sono siti con intensità<br />
i≥VI fuori dall’area coperta dalle isosiste in Fig. 1. Si tenga presente altresì che le Figg. 1 e 2<br />
abbracciano la medesima area. Per altro, anche il nostro scenario KF in tempo quasi-reale (Fig. non<br />
mostrata) è afflitto dallo stesso problema. Motivi: 1) sia le ShakeMaps che il parametrico KF hanno<br />
dovuto basarsi sugli epicentri delle prime decine di minuti (poi risultati di qualche chilometro<br />
troppo ad ovest); ma soprattutto: solo nei giorni successivi all’evento ci si è resi conto dell’effetto<br />
di direttività della sorgente del 6 aprile verso SE. Altra nota: le intensità osservate (Fig. 1) decrescono<br />
dal grado IX al VII in breve spazio, per poi calare al V a distanze proporzionalmente ben più<br />
elevate; nessuno scenario rapido (nemmeno il KF, non mostrato) riesce a riprodurre questo strano<br />
calo per così dire a due rampe. Nell’articolo esteso, crediamo di dimostrare che l’allungamento in<br />
direzione NW-SE della zona con i≥VII (Fig. 1) non è dovuto ad effetti locali ipoteticamente concentrati<br />
lungo la Valle dell’Aterno e non è nemmeno l’effetto spurio della ubicazione dei centri abitati<br />
lungo valli ad orientamento in direzione appenninica. Tali conclusioni sono sostenute da adeguate<br />
analisi geostatistiche e da verifiche del campionamento costituito dalla distribuzione dei siti<br />
rilevati dalle squadre Quest (seppure irregolare, la posizione dei siti è ampiamente sufficiente a<br />
descrivere il fenomeno).<br />
Se il primo scenario parametrico KF de L’Aquila era insoddisfacente, a distanza di alcune settimane<br />
dai due eventi studiati è stato possibile ottenere scenari parametrici KF abbastanza buoni per<br />
entrambi; quello di Frignano decisamente buono (Figg. non mostrate). In particolare per l’evento<br />
del 6 aprile, è stato indispensabile disporre dell’ipocentro rilocalizzato con maggiore attendibilità<br />
(INGV e cortesia di A. Zollo) e soprattutto - grazie al lavoro dei molti colleghi ringraziati – conoscere<br />
l’effetto di direttività verso SE (confermato a posteriori da nostre inversioni per la sorgente<br />
con la tecnica KF). A questo punto, inseriti gli epicentri e le fault plane aggiornate nel modello di<br />
scenario parametrico KF, e soprattutto considerata una serie di sorgenti lineari a rottura fortemente<br />
assimmetrica (prevalentemente verso SE), ecco che si è formata un’area di VIII grado allungata in<br />
direzione NW-SE (Fig. non mostrata) ben bilanciata con quella visible in Fig. 1 (anche se di forma<br />
non coincidente).<br />
Conclusioni di protezione civile. La conclusione (che offriamo alla discussione all’interno del<br />
progetto S3 di DPC ed INGV) sarebbe la seguente. Non ci appare ragionevole sperare che il coordinamento<br />
immediato dei soccorsi e dell’assistenza possa dipendere da simulazioni istantanee di<br />
493