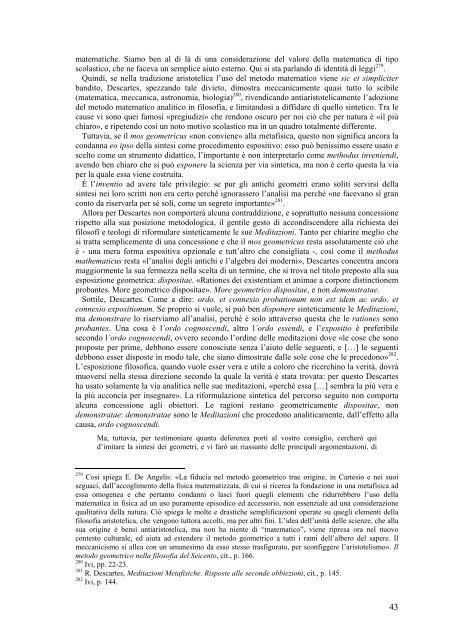Sara Pagliano ALIA VERITATIS NORMA - Lettere e Filosofia ...
Sara Pagliano ALIA VERITATIS NORMA - Lettere e Filosofia ...
Sara Pagliano ALIA VERITATIS NORMA - Lettere e Filosofia ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
matematiche. Siamo ben al di là di una considerazione del valore della matematica di tipo<br />
scolastico, che ne faceva un semplice aiuto esterno. Qui si sta parlando di identità di leggi 279 .<br />
Quindi, se nella tradizione aristotelica l’uso del metodo matematico viene sic et simpliciter<br />
bandito, Descartes, spezzando tale divieto, dimostra meccanicamente quasi tutto lo scibile<br />
(matematica, meccanica, astronomia, biologia) 280 , rivendicando antiaristotelicamente l’adozione<br />
del metodo matematico analitico in filosofia, e limitandosi a diffidare di quello sintetico. Tra le<br />
cause vi sono quei famosi «pregiudizi» che rendono oscuro per noi ciò che per natura è «il più<br />
chiaro», e ripetendo così un noto motivo scolastico ma in un quadro totalmente differente.<br />
Tuttavia, se il mos geometricus «non conviene» alla metafisica, questo non significa ancora la<br />
condanna eo ipso della sintesi come procedimento espositivo: esso può benissimo essere usato e<br />
scelto come un strumento didattico, l’importante è non interpretarlo come methodus inveniendi,<br />
avendo ben chiaro che si può exponere la scienza per via sintetica, ma non è certo questa la via<br />
per la quale essa viene costruita.<br />
È l’inventio ad avere tale privilegio: se pur gli antichi geometri erano soliti servirsi della<br />
sintesi nei loro scritti non era certo perché ignorassero l’analisi ma perché «ne facevano sì gran<br />
conto da riservarla per sé soli, come un segreto importante» 281 .<br />
Allora per Descartes non comporterà alcuna contraddizione, e soprattutto nessuna concessione<br />
rispetto alla sua posizione metodologica, il gentile gesto di accondiscendere alla richiesta dei<br />
filosofi e teologi di riformulare sinteticamente le sue Meditazioni. Tanto per chiarire meglio che<br />
si tratta semplicemente di una concessione e che il mos geometricus resta assolutamente ciò che<br />
è - una mera forma espositiva opzionale e tutt’altro che consigliata -, così come il methodus<br />
mathematicus resta «l’analisi degli antichi e l’algebra dei moderni», Descartes concentra ancora<br />
maggiormente la sua fermezza nella scelta di un termine, che si trova nel titolo preposto alla sua<br />
esposizione geometrica: dispositae. «Rationes dei existentiam et animae a corpore distinctionem<br />
probantes. More geometrico dispositae». More geometrico dispositae, e non demonstratae.<br />
Sottile, Descartes. Come a dire: ordo, et connexio probationum non est idem ac ordo, et<br />
connexio expositionum. Se proprio si vuole, si può ben disponere sinteticamente le Meditazioni,<br />
ma demonstrare lo riserviamo all’analisi, perché è solo attraverso questa che le rationes sono<br />
probantes. Una cosa è l’ordo cognoscendi, altro l’ordo essendi, e l’expositio è preferibile<br />
secondo l’ordo cognoscendi, ovvero secondo l’ordine delle meditazioni dove «le cose che sono<br />
proposte per prime, debbono essere conosciute senza l’aiuto delle seguenti, e […] le seguenti<br />
debbono esser disposte in modo tale, che siano dimostrate dalle sole cose che le precedono» 282 .<br />
L’esposizione filosofica, quando vuole esser vera e utile a coloro che ricerchino la verità, dovrà<br />
muoversi nella stessa direzione secondo la quale la verità è stata trovata: per questo Descartes<br />
ha usato solamente la via analitica nelle sue meditazioni, «perché essa […] sembra la più vera e<br />
la più acconcia per insegnare». La riformulazione sintetica del percorso seguito non comporta<br />
alcuna concessione agli obiettori. Le ragioni restano geometricamente dispositae, non<br />
demonstratae: demonstratae sono le Meditazioni che procedono analiticamente, dall’effetto alla<br />
causa, ordo cognoscendi.<br />
Ma, tuttavia, per testimoniare quanta deferenza porti al vostro consiglio, cercherò qui<br />
d’imitare la sintesi dei geometri, e vi farò un riassunto delle principali argomentazioni, di<br />
279 Cosi spiega E. De Angelis: «La fiducia nel metodo geometrico trae origine, in Cartesio e nei suoi<br />
seguaci, dall’accoglimento della fisica matematizzata, di cui si ricerca la fondazione in una metafisica ad<br />
essa omogenea e che pertanto condanni o lasci fuori quegli elementi che ridurrebbero l’uso della<br />
matematica in fisica ad un uso puramente episodico ed accessorio, non essenziale ad una considerazione<br />
qualitativa della natura. Ciò spiega le molte e drastiche semplificazioni operate su quegli elementi della<br />
filosofia aristotelica, che vengono tuttora accolti, ma per altri fini. L’idea dell’unità delle scienze, che alla<br />
sua origine è bensì antiaristotelica, ma non ha niente di “matematico”, viene ripresa ora nel nuovo<br />
contesto culturale, ed aiuta ad estendere il metodo geometrico a tutti i rami dell’albero del sapere. Il<br />
meccanicismo si allea con un umanesimo da esso stesso trasfigurato, per sconfiggere l’aristotelismo». Il<br />
metodo geometrico nella filosofia del Seicento, cit., p. 166.<br />
280 Ivi, pp. 22-23.<br />
281 R. Descartes, Meditazioni Metafisiche. Risposte alle seconde obbiezioni, cit., p. 145.<br />
282 Ivi, p. 144.<br />
43