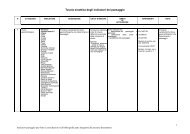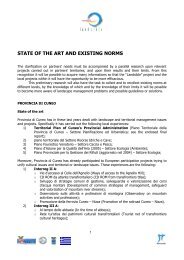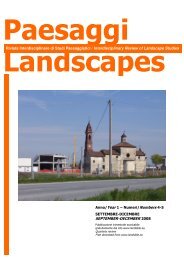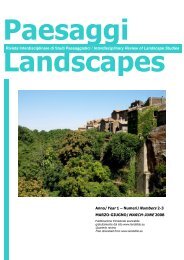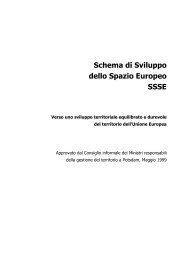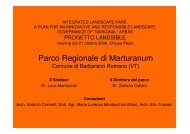Rivista Interdisciplinare di Studi Paesaggistici ... - Landsible.eu
Rivista Interdisciplinare di Studi Paesaggistici ... - Landsible.eu
Rivista Interdisciplinare di Studi Paesaggistici ... - Landsible.eu
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Rivista</strong> <strong>Inter<strong>di</strong>sciplinare</strong> <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>Paesaggistici</strong> / Inter<strong>di</strong>sciplinary Review of Landscape Stu<strong>di</strong>esreale, senza immagini, non può esserci una conoscenza, effettivamente <strong>di</strong>versa della realtà. Il processo che èall’origine della creazione <strong>di</strong> una rappresentazione, si basa sempre su un programma o una teoriad’osservazione, talvolta <strong>di</strong>chiarata, ma il più delle volte lasciati impliciti. Per questo, teoricamente, sonopossibili un’infinità d’immagini della realtà, perché infiniti possono essere i punti <strong>di</strong> vista, ma in sostanza neesiste un numero limitato come, d’altronde, limitate sono le metafore del reale: “Per quanto mal definita, larealtà ‘territorio’ è <strong>di</strong>venuta così l’oggetto non elu<strong>di</strong>bile della rappresentazione geo-grafica contemporanea” 2 .L’osservazione è <strong>di</strong> grande interesse, perché sottintende che, per conoscere il territorio, sianecessario “immaginare” rappresentazioni che non sono altro che punti <strong>di</strong> vista <strong>di</strong>fferenti, con cui si guardaall’oggetto rappresentato. Come scrive Rosset, la realtà è detta “i<strong>di</strong>ota”, perché è unica. Questo significa cheessa ha il privilegio ontologico d’essere imitabile, senza poter a sua volta imitare qualcos’altro 3 .Il territorio, quando osservato da un punto <strong>di</strong> vista esclusivamente geografico, <strong>di</strong>viene unageostruttura, più o meno ben definita, a partire dalla quale si possono costruire geogrammi 4 o immagini. Difronte alla rappresentazione, che fissa me<strong>di</strong>ante parole o immagini la realtà, si trova il reale, la “brillance”.La realtà è come il sole per Icaro: quando ci si avvicina troppo, ci si può bruciare. Di conseguenza, prenderein considerazione il reale significa non possedere veramente una realtà, ma qualcosa sotto una luce menointensa 5 .Alla fine del processo <strong>di</strong> rappresentazione, la realtà svanisce per lasciare il posto ad una o piùimmagini, più o meno banali. Il reale precede spesso la sua rappresentazione, la cui funzione non è <strong>di</strong>evocare una realtà contemporanea della percezione, ma <strong>di</strong> svelare un reale anteriore. La rappresentazione piùconvincente in<strong>di</strong>ca comunemente un reale precedente, o che almeno ha cominciato ad essere reale prima <strong>di</strong>essere riconosciuto come tale. Il reale dunque viene conosciuto soltanto successivamente, poiché in un primotempo esso consiste nella sola comparsa del reale in sé 6 .Quest’ultima osservazione è efficace nell’illustrare come una realtà possa essere spesso riconosciutamolto tempo dopo la sua prima realizzazione materiale. La storia contemporanea <strong>di</strong>mostra come, peresempio, il paesaggio industriale, vale a <strong>di</strong>re l’immagine dell’industria, abbia contribuito a far conoscere talerealtà, quando questa ha cominciato un suo primo declino. Questo ritardo coincide con il momento in cui lesocietà industriali sono state in grado <strong>di</strong> osservare criticamente e creare immagini della realtà che lecircondava. Questo ha coinciso con l’inizio della crisi del sistema 7 .Per meglio inquadrare il ruolo della rappresentazione come strumento <strong>di</strong> conoscenza, si può ricorrerealla metafora e ai suoi elementi costitutivi: il significante e il significato. È necessario rilevare però che trametafora e rappresentazione non sussiste una vera e propria omologia, perché il rapporto tra significante esignificato, nel primo caso, è arbitrario, mentre non lo è quando si tratta del rapporto tra figura materiale eimmagine. Il geogramma, ad esempio, che – si è detto – è una particolare immagine frutto <strong>di</strong> uno specificopunto <strong>di</strong> vista (geografico), viene creato per dare conto <strong>di</strong> qualcosa ritenuto rilevante, interessante oconvenzionale, riguardo alla realtà materiale osservata, e per questo non arbitrario.Per far capire questa <strong>di</strong>stinzione tra realtà materiale e immagine è molto utile <strong>di</strong> ricorrere alla teoria<strong>di</strong> Hans Belting esposta nella sua Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft. Secondo Beltingun’immagine è più che il prodotto <strong>di</strong> una percezione. È il risultato <strong>di</strong> una simbolizzazione personale ocollettiva. Inoltre, occorre <strong>di</strong>stinguere tra le immagini interne e quelle esterne. Per fare questa <strong>di</strong>stinzione,Belting <strong>di</strong> avvale <strong>di</strong> una relazione triangolare immagine-me<strong>di</strong>um-sguardo o, ancora, immagine-<strong>di</strong>spositivocorpo.Nel caso delle immagini interne, <strong>di</strong>spositivo e corpo costituiscono una sola cosa: quando cerco <strong>di</strong>evocare piazza San Marco a Venezia, l’immagine che compare è quella che la mia memoria è capace <strong>di</strong>creare sullo schermo della mia mente; ma quest’immagine nessuno può vederla, nessuno se ne puòappropriare e sono incapace <strong>di</strong> renderla senza fare una descrizione verbale o un <strong>di</strong>segno, che sarà moltopovero, perché non renderà mai conto <strong>di</strong> ciò che ho o credo <strong>di</strong> avere nella mente.Invece, nel caso dell’immagine esterna il <strong>di</strong>spositivo o me<strong>di</strong>um non sarà più il corpo e avremo lapossibilità <strong>di</strong> rendere visibile l’immagine. Non posso riprodurre un’immagine interna, ma posso riprodurre2 G. Dematteis, Le Metafore della Terra, la geografia umana tra mito e scienza, Feltrinelli, Milano, 1985, p. 73.3 C. Rosset, Le réel. Traité de l’i<strong>di</strong>otie, E<strong>di</strong>tions de minuit, Paris, 1977, pp. 47-48.4 Il geogramma non è altro che l’immagine della realtà geografica.5 Ibid.6 C. Rosset, Le réel. Traité de l’i<strong>di</strong>otie, cit.7 Ciò è accaduto in <strong>di</strong>versi momenti a seconda dei contesti territoriali, ma generalmente sempre dopo il 1970.23