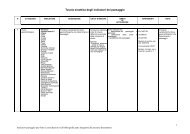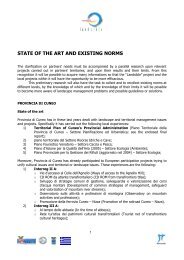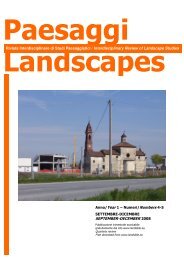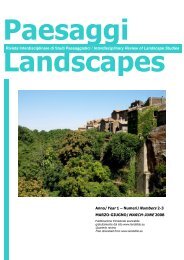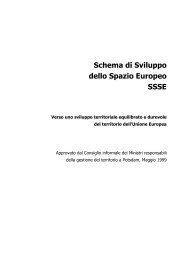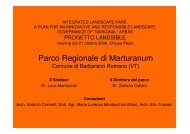Rivista Interdisciplinare di Studi Paesaggistici ... - Landsible.eu
Rivista Interdisciplinare di Studi Paesaggistici ... - Landsible.eu
Rivista Interdisciplinare di Studi Paesaggistici ... - Landsible.eu
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Rivista</strong> <strong>Inter<strong>di</strong>sciplinare</strong> <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>Paesaggistici</strong> / Inter<strong>di</strong>sciplinary Review of Landscape Stu<strong>di</strong>esriceve un’altra smentita, perché non c’è niente da copiare: “L’uomo che appare nel Paesaggio con cacciatore<strong>di</strong> Rembrandt non è presumibilmente una persona reale; egli è precisamente l’uomo che appare nell’incisione<strong>di</strong> Rembrandt [...]. Una figura che rappresenta un uomo lo denota; una figura che rappresenta un uomoimmaginario è una figura-<strong>di</strong>-uomo; e una figura che rappresenta un uomo, come un uomo, è una figura-<strong>di</strong>uomoche lo denota. Così, mentre il primo caso riguarda solo ciò che la figura denota, e il secondo solo chegenere <strong>di</strong> figura sia, il terzo riguarda sia la denotazione che la classificazione [...]. Una rappresentazione odescrizione è idonea, efficace, illuminante, sottile, suggestiva, nella misura in cui il pittore o scrittore coglierelazioni ine<strong>di</strong>te e significative, e <strong>di</strong>spone dei mezzi per renderle manifeste” 15 . La seguente battuta èrivelatrice: “A chi si rammaricava che il suo ritratto <strong>di</strong> Gertrude Stein non fosse somigliante, si <strong>di</strong>ce chePicasso abbia risposto: ‘Non importa; lo sarà’” 16 . Si vede chiaramente che la rappresentazione intrattienestretti rapporti con l’invenzione e dunque con la creatività. In questo senso, il paesaggio comerappresentazione è un’invenzione, tuttavia quest’idea pone un evidente problema nei confronti del realismo.Secondo Goodman un quadro “è realistico precisamente nella misura in cui è un’illusione ben riuscita, taleda indurre lo spettatore a supporre che esso sia ciò che rappresenta, o che ne abbia le caratteristiche. Lamisura <strong>di</strong> realismo proposta coincide, in altre parole, con la probabilità <strong>di</strong> scambiare la rappresentazione conciò che è rappresentato” 17 . Tale spiegazione è plausibile, ma, nel caso del paesaggio, non del tuttoconvincente, perché il realismo non è assolutamente l’aspetto che si vuole misurare. Se il paesaggio, ognivolta, è ricerca <strong>di</strong> questa perfezione nell’immagine, che non è attingibile dalla realtà materiale, allora è lamisura della probabilità <strong>di</strong> sostituire la rappresentazione al rappresentato.Per quanto riguarda il territorio, la ricerca della perfezione è stata presente nelle civiltà, in tutti i mitie le religioni, attraverso la nozione <strong>di</strong> para<strong>di</strong>so: o l’abbiamo perduto e dobbiamo ritrovarlo o dobbiamoentrarci dopo la morte. Il paesaggio mi sembra essere un sostituto del para<strong>di</strong>so, un’età dell’oro del territorio e,naturalmente, nella stessa misura in cui il para<strong>di</strong>so è stato concepito <strong>di</strong>versamente secondo i popoli e imomenti della storia, il paesaggio è passato attraverso concezioni <strong>di</strong>fferenti. La perfezione si manifesta nellastoricità e non fuori da questa. Se è vero che all’utopia corrisponde l’ucronia, si parla più facilmente dellaperfezione del territorio che non <strong>di</strong> quella del tempo. Se possiamo immaginare un territorio perfetto – unpara<strong>di</strong>so –, non si può immaginare una storia perfetta, se non nel prolungamento della perfezionenell’eternità e allora non c’è più storia, ma c’è un tempo senza sofferenze, <strong>di</strong> soli piaceri, come è il caso deipara<strong>di</strong>si creati dalle religioni. Ciò non è altro che la fine della storia, non nel senso utilizzato da Fukuyama,ma nel senso della non realizzazione del mondo. Come posso essere cosciente della perfezione se nonattraverso le emozioni e i sentimenti? La rappresentazione incita al dono della memoria per conservarla. Sitratta <strong>di</strong> una perfezione relativa. Abbiamo, tutti, la nostalgia della perfezione, del para<strong>di</strong>so. Parlare <strong>di</strong>realismo è ancora un modo per ritornare sul problema della somiglianza. La rappresentazione non è stabile,così come non lo è neppure l’espressione: “Tanto nel caso della rappresentazione quanto dell’espressione,certe relazioni si fissano stabilmente per un certo polo attraverso l’abitu<strong>di</strong>ne; ma in nessuno dei due casiesistono relazioni assolute, universali o immutabili” 18 .René Char ha saputo avvicinarsi all’idea <strong>di</strong> perfezione quando ha scritto: “la poesia è l’amorerealizzato del desiderio rimasto desiderio (le poème est l’amour réalisé du désir dem<strong>eu</strong>ré désir)” 19 . Non allostesso modo, ma in una maniera analoga, si può scrivere che l’immagine del paesaggio è il paesaggio delterritorio perfetto rimasto desiderio. L’apparizione del paesaggio come desiderio <strong>di</strong> perfezione o <strong>di</strong> territorioperfetto è assolutamente fondamentale. In realtà si tratta <strong>di</strong> un’apparire d’immagini, <strong>di</strong> un vivere attraverso leimmagini se non nelle immagini. È sempre più evidente che la rappresentazione si manifesta attraverso unterribile fenomeno <strong>di</strong> trasformazione, <strong>di</strong> atrofia o <strong>di</strong> ipertrofia. La deformazione è uno dei meccanismiimportanti della rappresentazione, ma non ancora totalmente chiarito. Per far ciò occorrerebbe lavorare sullaquestione della caricatura.La rappresentazione obbe<strong>di</strong>sce ad uno spazio visuale interno: “Giacometti aveva allora colto moltobene ciò che <strong>di</strong>pendeva dalla visione e ciò che <strong>di</strong>pendeva dallo sguardo, nel senso della pulsione ‘scopica’ <strong>di</strong>15 N. Goodman, I linguaggi dell’arte, cit., pp. 30-36.16 Ivi, p. 36.17 Ivi, p. 37.18 Ivi, pp. 50-51.19 Cfr. C. Masson, Op. cit., p. 116.25