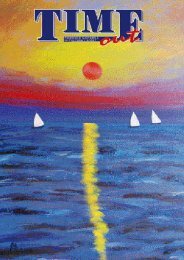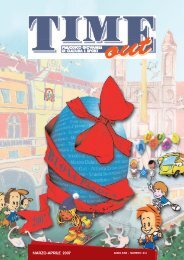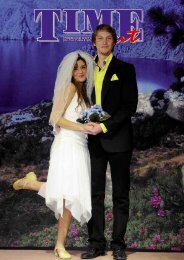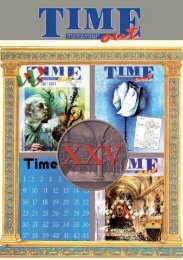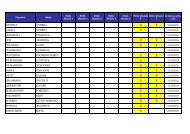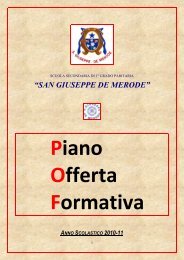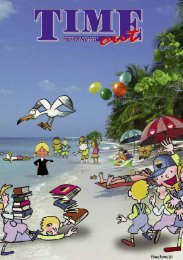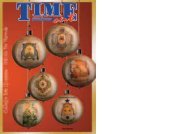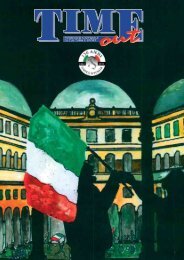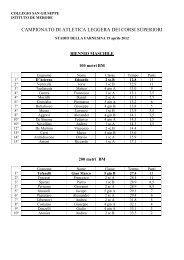qdpd n 7.pdf - Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode
qdpd n 7.pdf - Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode
qdpd n 7.pdf - Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
“La poesia è testimonianza d’Iddio” QdPD 1 (2011)<br />
un’urna (v. 10) che accoglie la reliquia (v. 11) del corpo (si tratta di una discesa<br />
agli inferi, di una morte simbolica). È il procedimento tipico dell’analogia, che<br />
fa uso del linguaggio liturgico e religioso, conferendo sacralità alla situazione.<br />
L’acqua scorre e trasforma il corpo del poeta in un sasso, uniformandolo così alla<br />
realtà minerale della natura. Il corpo è scarnificato (le mie quattr’ossa, v. 17), ma<br />
può riemergere come rinato e liberato. S’innesta qui il motivo cristologico dell’acrobata<br />
sull’acqua (vv. 19-20), che richiama il miracolo di Cristo. Illuminato e<br />
riscaldato dal sole, il poeta conquista la propria identità, sentendosi intimamente<br />
partecipe della vita dell’universo e vibrando all’unisono con esso. In questa armonia,<br />
in questa sensazione di pienezza consiste la sua felicità. E la poesia, se<br />
vuole essere pienamente se stessa, ha il compito di cogliere questi rari istanti, rivelando<br />
la percezione di una segreta simbiosi con il mistero e l’inconoscibile.<br />
Una scheda riepilogativa dei procedimenti formali adottati da Ungaretti sarà<br />
l’assegno per casa.<br />
II Lezione – Direzione e termine della vita<br />
I motivi del viaggio, del naufragio e della ricerca religiosa si richiamano analogicamente<br />
tra loro in alcune liriche dell’Allegria. In Preghiera, lirica conclusiva<br />
della raccolta con trasparente riferimento alla canzone Alla Vergine di F. Petrarca<br />
che chiude il Canzoniere, il poeta chiede al Signore di poter naufragare nell’alba<br />
del giorno in cui avrà compreso chiaramente l’orientamento da dare alla propria<br />
vita, finalmente libero da contatti ingannevoli contingenti (barbaglio della promiscuità,<br />
v. 2) 5 e sollevato da ogni senso di oppressione (v. 4). Per lui si tratterà di<br />
una rinascita (giovane giorno, v.6) in un mondo di nitore e stupore (v. 3). Tre<br />
strofe, versi liberi, assenza di punteggiatura, enjambements.<br />
La seconda fase d’esperienza umana di Ungaretti coincide con la raccolta poetica<br />
Sentimento del tempo. Se ne darà informazione riguardo alla cronologia e alla<br />
struttura, insistendo sulla nuova concezione del tempo rispetto all’Allegria. All’attimo<br />
della ‘folgorazione’, all’istante in cui si manifesta il mistero della vita<br />
succede il tempo avvertito come durata, come causa del mutamento, di distruzione<br />
e rinascita. Nella sezione centrale figura Fine di Crono, lirica del 1925 che<br />
dà il nome alla sezione stessa e rappresenta una “fantasia della fine del mondo. Gli<br />
astri, ‘Penelopi innumeri’, filano la vita finché il loro Signore, il loro Ulisse ritorni ad<br />
abbracciarli, ad annullarli in sé. Tornerà poi l’Olimpo, la quiete assoluta, il non esistere<br />
più” 6 . Un ulissismo particolare, astrale, lega in analogia i vv. 7-8; 11. Il fiore eterno<br />
di sonno (v. 12) simboleggia il dono divino dell’eternità, che l’uomo può raggiungere<br />
solo dopo la morte. I ragazzi noteranno la presenza della punteggiatura e<br />
5 Cfr. G.Ungaretti, Note – L’Allegria, op. cit., p. 527.<br />
6 Cfr. G.Ungaretti, Note – Sentimento del tempo, in Vita d’un uomo, p. 537.<br />
67