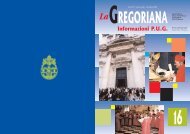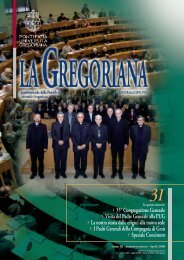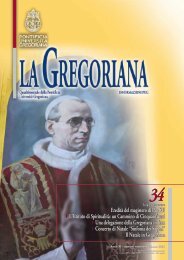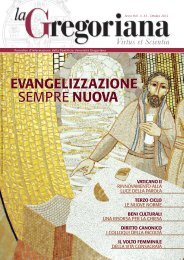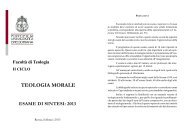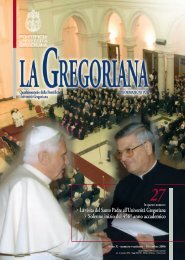Compendio di storia della scrittura latina. Paleografia ... - Gregoriana
Compendio di storia della scrittura latina. Paleografia ... - Gregoriana
Compendio di storia della scrittura latina. Paleografia ... - Gregoriana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I.- I primi tempi (fine sec. VIII - fine sec. IX: precapuano).<br />
II.- La formazione (fine sec. IX - sec. X: capuano).<br />
III.- La perfezione (sec. XI-XII: abati Teobaldo, Desiderio, ecc.).<br />
IV.- La decandenza (fine sec. XII - sec. XIII). Alla fine del sec. XIII fu sostituita<br />
dalla <strong>scrittura</strong> gotica. Alcuni esempi <strong>di</strong> <strong>scrittura</strong> beneventana durante i sec. XIX-XV ci<br />
sono pervenuti, ma si tratta <strong>di</strong> casi rari.<br />
Nell’appen<strong>di</strong>ce <strong>della</strong> monografia <strong>di</strong> E. A. Lowe si trova l’elenco dei co<strong>di</strong>ci in<br />
beneventana, che comprende più <strong>di</strong> 600 manoscritti.<br />
10.4.4 Criteri per la datazione <strong>della</strong> <strong>scrittura</strong> beneventana<br />
- Durante il primo periodo, essa era simile alla precarolina dell’Italia settentrionale.<br />
Dopo la fine del regno lombardo, i monaci hanno portato a Montecassino alcuni co<strong>di</strong>ci<br />
scritti in tipi precarolini. Apparivano ancora elementi corsivi, le parole non erano<br />
separate con chiarezza, la “a” era scritta talvolta aperta nella parte superiore; non si<br />
osservava la regola per l’uso <strong>della</strong> “ti” dura e <strong>della</strong> “ti” sibilante.<br />
Durante il secondo periodo, si osservò con regolarità ciò che mancava durante il<br />
primo; ma non si trattava ancora <strong>di</strong> una <strong>scrittura</strong> calligrafica, pur mantenendosi dentro le<br />
forme «beneventane». Invece, durante il terzo periodo questa <strong>scrittura</strong> raggiunse la sua<br />
vetta per quanto riguarda la regolarità e la calligrafia, l’osservanza <strong>della</strong> frattura delle<br />
aste brevi, nonché l’accentuazione del chiaroscuro. Erano evidenti alcuni dettagli: il<br />
collegamento orizzontale sul rigo superiore, l’accostamento delle parti rotonde delle<br />
lettere vicine, la frequenza delle abbreviazioni - fu allora che si usò, come mezzo <strong>di</strong><br />
abbreviazioni, la lettera soprascritta -.<br />
Nel quarto periodo si <strong>di</strong>mostrò la decadenza. Le lettere s’impicciolirono e crescevano<br />
in angolosità; apparivano alcuni trattini aggiuntivi, s’introducevano elementi dell’epoca<br />
finale <strong>della</strong> <strong>scrittura</strong> carolina (in concorrenza, durante il sec. XII, con la beneventana,<br />
praticamente limitata ai monasteri benedettini). Dopo la metà del sec. XIII, la <strong>scrittura</strong><br />
beneventana cessò <strong>di</strong> essere usata regolarmente.<br />
Nella Dalmazia e nella regione <strong>di</strong> Bari non fu raggiunta la calligrafia «desideriana».<br />
Le scritture <strong>di</strong> quelle regioni erano più rotonde e fluenti, perciò non presentano la<br />
frattura tipica <strong>della</strong> beneventana <strong>di</strong> Montecassino, soltanto qualche cenno ad essa a<br />
modo <strong>di</strong> serpeggiamento angoloso 136 .<br />
Sono peculiari <strong>della</strong> <strong>scrittura</strong> italiana meri<strong>di</strong>onale i rotoli liturgici in <strong>scrittura</strong><br />
beneventana. La maggioranza <strong>di</strong> essi contengono l’Exultet pasquale, ma esistono anche<br />
altri con la Bene<strong>di</strong>ctio fontis del Sabato Santo, o con il rito dell’Or<strong>di</strong>nazione <strong>di</strong> un<br />
vescovo. Questi testi si trovano, <strong>di</strong> solito, intercalati da illustrazioni. Le <strong>di</strong>verse<br />
illuminazioni in<strong>di</strong>cano il tema del canto rispettivo. Affinché i fedeli potessero vedere le<br />
immagini, esse erano <strong>di</strong>pinte in senso contrario alla <strong>scrittura</strong> 137 .<br />
136 Cfr. A. PETRUCCI, «Note e ipotesi sull’origine <strong>della</strong> <strong>scrittura</strong> barese», in Bolletino dell’Archivio<br />
Paleografico Italiano, nuova serie, 4-5 (1958-59) 101-114. La barese sarebbe sorta dalla <strong>scrittura</strong><br />
documentaria beneventana in uso nella Puglia, con qualche influsso greco; la punta del calamo era<br />
piuttosto dura. V. NOVAK, «Something New from the Dalmatian Beneventana», in Me<strong>di</strong>evalia et<br />
Humanistica, 14 (1962) 76-85. M. INGUANEZ, «La <strong>scrittura</strong> beneventana in co<strong>di</strong>ci e documenti dei secoli<br />
XIV e XV», in Scritti <strong>di</strong> <strong>Paleografia</strong> e Diplomatica in onore <strong>di</strong> Vincenzo Federici, Firenze 1944.<br />
137 Cfr. G. CAVALLO, «La genesi dei rotoli liturgici beneventani», in Miscellanea in memoria <strong>di</strong><br />
Giorgio Cencetti, Torino 1973, pp. 213-229; IDEM, Rotoli “Exultet” dell’Italia meri<strong>di</strong>onale, Bari 1973<br />
[facsimili dei rotoli].<br />
68