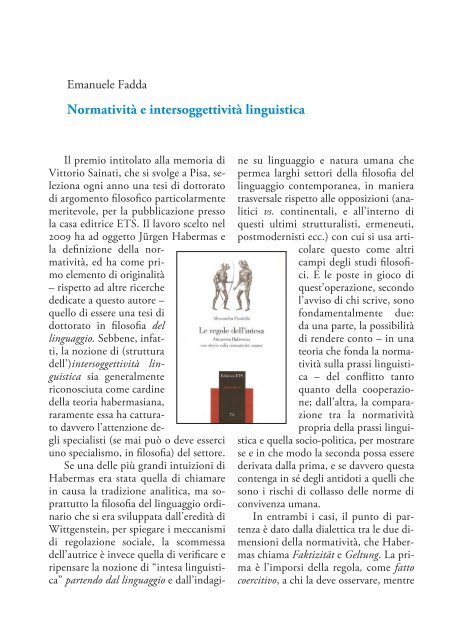You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Emanuele Fadda<br />
Normatività e intersoggettività linguistica<br />
Il premio intitolato alla memoria di<br />
Vittorio Sainati, che si svolge a Pisa, seleziona<br />
ogni anno una tesi di dottorato<br />
di argomento filosofico particolarmente<br />
meritevole, per la pubblicazione presso<br />
la casa editrice ETS. Il lavoro scelto nel<br />
2009 ha ad oggetto Jürgen Habermas e<br />
la definizione della normatività,<br />
ed ha come primo<br />
elemento di originalità<br />
– rispetto ad altre ricerche<br />
dedicate a questo autore –<br />
quello di essere una tesi di<br />
dottorato in filosofia del<br />
linguaggio. Sebbene, infatti,<br />
la nozione di (struttura<br />
del l’)inter sog get tività linguistica<br />
sia generalmente<br />
riconosciuta come cardine<br />
della teoria habermasiana,<br />
raramente essa ha catturato<br />
davvero l’attenzione degli<br />
specialisti (se mai può o deve esserci<br />
uno specialismo, in filosofia) del settore.<br />
Se una delle più grandi intuizioni di<br />
Habermas era stata quella di chiamare<br />
in causa la tradizione analitica, ma soprattutto<br />
la filosofia del linguaggio ordinario<br />
che si era sviluppata dall’eredità di<br />
Wittgenstein, per spiegare i meccanismi<br />
di regolazione sociale, la scommessa<br />
dell’autrice è invece quella di verificare e<br />
ripensare la nozione di “intesa linguistica”<br />
partendo dal linguaggio e dall’indagi-<br />
ne su linguaggio e natura umana che<br />
permea larghi settori della filosofia del<br />
linguaggio contemporanea, in maniera<br />
trasversale rispetto alle opposizioni (analitici<br />
vs. continentali, e all’interno di<br />
questi ultimi strutturalisti, ermeneuti,<br />
postmodernisti ecc.) con cui si usa articolare<br />
questo come altri<br />
campi degli studi filosofici.<br />
E le poste in gioco di<br />
quest’operazione, secondo<br />
l’avviso di chi scrive, sono<br />
fondamentalmente due:<br />
da una parte, la possibilità<br />
di rendere conto – in una<br />
teoria che fonda la normatività<br />
sulla prassi linguistica<br />
– del conflitto tanto<br />
quanto della cooperazione;<br />
dall’altra, la comparazione<br />
tra la normatività<br />
propria della prassi linguistica<br />
e quella socio-politica, per mostrare<br />
se e in che modo la seconda possa essere<br />
derivata dalla prima, e se davvero questa<br />
contenga in sé degli antidoti a quelli che<br />
sono i rischi di collasso delle norme di<br />
convivenza umana.<br />
In entrambi i casi, il punto di partenza<br />
è dato dalla dialettica tra le due dimensioni<br />
della normatività, che Habermas<br />
chiama Faktizität e Geltung. La prima<br />
è l’imporsi della regola, come fatto<br />
coercitivo, a chi la deve osservare, mentre