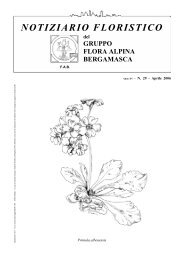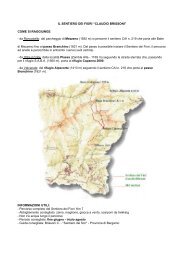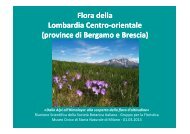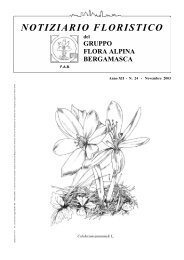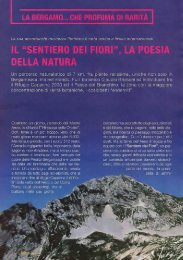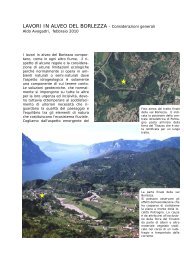IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
INFORMATORE BOTANICO ITALIANO, <strong>40</strong> SUPPL. 1, <strong>2008</strong><br />
<strong>Flora</strong> da conservare: implementazione delle categorie e dei criteri IUCN (2001) per la redazione di nuove Liste Rosse<br />
103<br />
Quercus ithaburensis Decne. subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge et F. Yaltirik<br />
R. ACCOGLI, P. MEDAGLI, L. BECCARISI e S. MARCHIORI<br />
Nomenclatura:<br />
Nome scientifico: Quercus ithaburensis Decne.<br />
subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge et F. Yaltirik<br />
Sinonimi: Quercus aegilops L. var. macrolepis<br />
Kotschy, Quercus macrolepis Kotschy, Q. graeca<br />
Kotschy<br />
Famiglia: Fagaceae<br />
Nome comune: Vallonea<br />
Descrizione. Specie arborea con chioma semi-sempreverde,<br />
con tronco di 10-25 m, con corteccia<br />
finemente fessurata, di colore scuro. Le foglie<br />
hanno lamina generalmente increspata, da ellittica<br />
a lanceolata con base cuoriforme e asimmetrica,<br />
margine con 5-7 denti acuti e mucronati per lato<br />
(PIGNATTI, 1982). Nella pagina superiore le foglie<br />
sono glabre e di colore verde, mentre in quella inferiore<br />
sono più chiare, pubescenti quando il lembo<br />
è appena disteso. La forma e le dimensioni dei frutti<br />
sono alquanto variabili: la cupola presenta squame<br />
lanceolate ed un diametro comprensivo delle<br />
scaglie di 3-6 cm; le dimensioni della ghianda sono<br />
di 2-3 x 4-8 cm.<br />
Biologia. Si tratta di una fanerofita che in Puglia fiorisce<br />
ad aprile. La produzione annuale di ghiande è<br />
normalmente elevata, anche se molti individui presentano<br />
una fruttificazione abbondante ad annate<br />
alterne; buona è la rinnovazione spontanea.<br />
Nell’Orto Botanico dell’Università del Salento viene<br />
attuata la conservazione ex situ della specie: la propagazione<br />
generativa ripetuta per 4 anni di seguito, ha<br />
attestato valori di resa germinativa del 75-95%. In<br />
vivaio le plantule presentano buona resistenza,<br />
sopravvivono alla stagione estiva, facendo registrare<br />
bassi valori di mortalità.<br />
Ecologia. I dati termopluviometrici della stazione<br />
meteorologica di Lucugnano, prossima all’areale<br />
salentino della Vallonea, presentano aspetti caratteristici<br />
che aiutano a capire le peculiari esigenze bioclimatiche<br />
della specie.<br />
Essa si adatta a situazioni idriche diverse, purché le<br />
piogge siano abbondanti da ottobre a marzo. Occupa<br />
una zona ben differenziata e circoscritta, in un<br />
distretto climaticamente ben distinto nell’ambito del<br />
Salento, nel piano bioclimatico mesomediterraneo<br />
umido-subumido (RIVAS-MARTÍNEZ, 2004). Il substrato<br />
geomorfologico è rappresentato da formazioni<br />
di tipo calcareo o calcarenitico, mentre dal punto di<br />
vista pedologico, sembra preferire i terreni di tipo<br />
franco argilloso sottili. Tali condizioni, benché al<br />
limite rispetto alle esigenze ecologiche della specie in<br />
altre aree del Mediterraneo (DUFOUR-DROR, ERTAS,<br />
2004), sono sufficienti per la sua crescita e per la rinnovazione<br />
spontanea.<br />
In Italia, la specie è raramente inserita nell’ambito di<br />
formazioni boschive, ma risulta confinata in nuclei e<br />
filari ai margini dei coltivi o negli interstizi dei caratteristici<br />
muretti a secco (SAULI , 1933).<br />
Distribuzione in Italia.<br />
In Italia la Vallonea è presente in un ben definito<br />
distretto della Puglia e cioè nelle province di Lecce,<br />
Brindisi e Taranto, dispersa in esemplari singoli e<br />
addensata in maniera significativa soprattutto nella<br />
zona di Tricase (DONNO, 1942). Questo estremo<br />
lembo della Puglia rappresenta il limite occidentale<br />
dell’areale dove tale specie può esistere e riprodursi<br />
allo stato spontaneo.<br />
Regione biogeografica: seguendo PEDROTTI (1996), le<br />
stazioni di Q. ithaburensis subsp. macrolepis rientrano<br />
nella regione biogeografica mediterranea, secondo<br />
RIVAS-MARTINEZ et al. (2004), subregione mediterranea-orientale,<br />
adriatica pugliese.<br />
Secondo PIGNATTI (l.c.), le presenze della specie in<br />
Italia sono limitate al Salento Meridionale, con il territorio<br />
di Tricase, ed al Bosco Selva, in provincia di<br />
Matera, citata dallo stesso Autore e non più rinvenuta<br />
in tempi recenti (MEDAGLI, GAMBETTA, 2003).<br />
Numero di stazioni: il popolamento del territorio di<br />
Tricase può essere considerato come un’unica grande<br />
stazione di presenza spontanea della specie. Invece,<br />
in altre località pugliesi, nei territori di Gagliano del<br />
Capo, Marittima, Andrano, Gallipoli, Otranto,<br />
Supersano, Alessano, Castrignano, Corigliano,<br />
Cutrofiano, Lecce, Taranto, Brindisi, Cannole,<br />
Corsano, Giurdignano, Scorrano (DONNO, 1942;