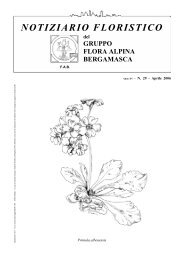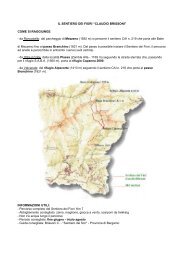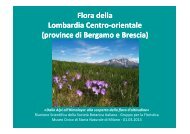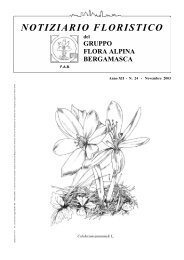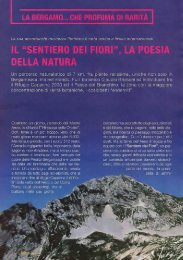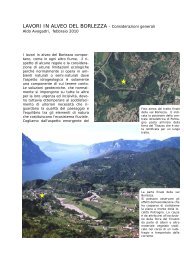IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Flora</strong> da conservare: implementazione delle categorie e dei criteri IUCN (2001) per la redazione di nuove Liste Rosse<br />
113<br />
chia mediterranea (Pistacia lentiscus L. su tutte) a scapito<br />
di S. spinosum. La minaccia più grave risulta<br />
essere la riduzione dell’habitat idoneo causata dallo<br />
sviluppo di nuove infrastrutture umane, quali insediamenti<br />
urbani (Minaccia 1.4.2: “Infrastructure<br />
development - Human settlement”) o infrastrutture<br />
stradali e ferroviarie (Minaccia 1.4.4: “Infrastructure<br />
development - Transport”). Ciò è dimostrato dal caso<br />
della popolazione di Tivoli (PIGNATTI, 1982) e dalle<br />
nostre indagini sui cambiamenti d’uso del suolo<br />
avvenuti nel periodo 1950-1990 lungo la costa ionica<br />
settentrionale della Calabria. In realtà è verosimile<br />
che, in Italia, le popolazioni siciliane siano le uniche<br />
esenti da rischi a medio-breve termine.<br />
Criteri IUCN applicati.<br />
L’assegnazione di S. spinosum ad una delle categorie<br />
di rischio IUCN (IUCN, 2001) è stata basata su<br />
stime quantitative inerenti i caratteri distributivi<br />
della specie in Italia e relative variazioni nell’arco<br />
temporale 1950-2006 (criteri A e B). In tal senso è<br />
stata utilizzata una banca dati georiferita.<br />
Nelle stime d’areale (EOO), vaste superfici evidentemente<br />
inidonee alla vita della specie (come parte del<br />
Mar Tirreno interposto tra i siti sardi e le altre popolazioni<br />
italiane) sono state escluse tramite triangolazione<br />
di Delauney ed utilizzando un valore di α = 2<br />
(IUCN, 2006).<br />
La superficie occupata (AOO) è stata stimata utilizzando<br />
una griglia 2x2 Km; i dati siciliani, originariamente<br />
in scala 10x10 Km, sono stati riportati per estrapolazione<br />
(IUCN, 2006) alla scala di riferimento (2x2).<br />
Per la fascia costiera dell’alto Ionio calabrese è stata<br />
condotta un’analisi multi-temporale (1950-1990)<br />
per valutare i cambiamenti d’uso del suolo intervenuti<br />
nel periodo considerato.<br />
Criterio A<br />
Sottocriteri<br />
A2-Riduzione: dai dati considerati è emersa una contrazione<br />
superiore al 50% a carico della specie in un<br />
arco temporale di circa <strong>40</strong> anni. In accordo con i dati<br />
riportati in SELIGMAN, HENKIN (2002) sull’aspettativa<br />
di vita dei ramet di S. spinosum questa finestra<br />
temporale è compatibile con un periodo di 3 generazioni.<br />
I cambiamenti di uso del suolo osservati e le<br />
informazioni bibliografiche suggeriscono quale causa<br />
principale di tale declino l’antropizzazione delle aree<br />
costiere, un fenomeno tuttora in atto.<br />
Opzioni<br />
c) L’entità della riduzione è stata stimata in base alle<br />
variazioni a carico dell’areale regionale che, negli anni<br />
’90 è risultato ridotto del 52,78% rispetto al 1950.<br />
Criterio B<br />
Sottocriteri<br />
B1-Areale Regionale (EOO): stimato in 64.412 Km 2<br />
(prima del 1950) e 30.412 Km 2 (attuale).<br />
B2-Superficie occupata (AOO): stimata in 252,1 Km 2<br />
(prima del 1950) e 224,1 Km 2 (attuale).<br />
Opzioni<br />
a) In Italia, in base all’accezione IUCN (2006),<br />
attualmente S. spinosum può essere ritenuto presente<br />
in 5 location. Le singole stazioni note per Sardegna e<br />
Puglia sono ritenute due location indipendenti.<br />
L’uniformità ecologica dei siti calabresi, rende le<br />
popolazioni della specie sensibili allo stesso fattore di<br />
rischio (antropizzazione) su tutto l’areale locale, che<br />
può quindi ritenersi un’unica location. In Sicilia possono<br />
essere individuate 2 location, una relativa all’area<br />
costiera (sensibile a problemi di antropizzazione)<br />
e l’altra che include le popolazioni dell’interno, legate<br />
soprattutto alle modalità di gestione di aree colturali<br />
e dei pascoli.<br />
In virtù delle ampie distanze tra le popolazioni delle<br />
varie regioni (ben superiori a 50 Km), l’areale italiano<br />
di S. spinosum può ritenersi, inoltre, estremamente<br />
frammentato.<br />
b) Le procedure seguite hanno permesso di stimare<br />
una riduzione di areale regionale (b(i)) superiore al<br />
52% negli ultimi decenni; e nello stesso periodo la<br />
superficie occupata (b(ii)) risulta essersi ridotta di<br />
circa l’11%. In Calabria, lo studio delle variazioni<br />
d’uso del suolo ha evidenziato una chiara tendenza<br />
alla perdita di habitat idoneo (b(iii)), in termini sia<br />
qualitativi (riduzione della dimensione media dei<br />
patches, aumento dell’isolamento tra di essi), che<br />
quantitativi (riduzione della superficie netta occupata<br />
dagli ambienti di gariga prossimi alla costa).<br />
Infine, è ben documentata la scomparsa di subpopolazioni<br />
(b(iv)) in Lazio, Puglia, Calabria e Sardegna.<br />
Categoria di rischio.<br />
Criterio A – L’entità del declino osservato a carico dell’areale<br />
regionale (>50%), il periodo su cui è avvenuto<br />
(3 generazioni) e la natura delle cause da cui dipende<br />
giustifica l’attribuzione di S. spinosum alla seguente<br />
categoria IUCN (2001): Endangered, EN A2c.<br />
Criterio B – Considerando l’attuale superficie occupata<br />
(