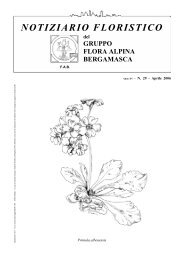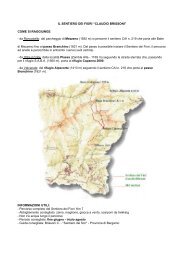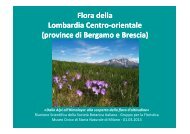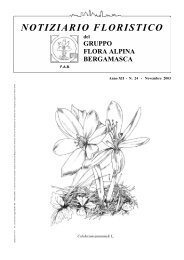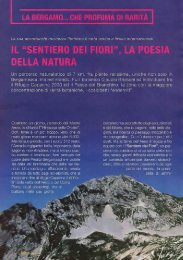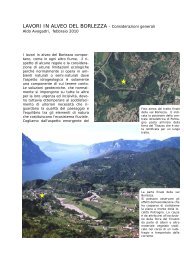IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
INFORMATORE BOTANICO ITALIANO, <strong>40</strong> SUPPL. 1, <strong>2008</strong><br />
<strong>Flora</strong> da conservare: implementazione delle categorie e dei criteri IUCN (2001) per la redazione di nuove Liste Rosse<br />
87<br />
Limonium etruscum Arrigoni et Rizzotto<br />
B. FOGGI, D. VICIANI, E. VENTURI e C. ROSI<br />
Nomenclatura:<br />
Specie: Limonium etruscum Arrigoni et Rizzotto<br />
Famiglia: Plumbaginaceae<br />
Nome comune: Statice etrusco<br />
Descrizione. Erba perenne, legnosa alla base, alta 15-<br />
50 cm. Foglie basali riunite in rosetta. Foglie lanceolate<br />
3-8 x 0,5-1,5 cm, 3-5 nervi, margine scarioso<br />
sottile. Fusti rugosi, ramosi in alto, con rami a 45-<br />
50°. Fiori riuniti in spighe terminali lunghe 1-10 cm.<br />
Brattea interna 5 nervia, 5,5 mm, scariosa-bruno rossastra,<br />
con nervo evidente. Fiori azzurro-violetto<br />
(ARRIGONI, RIZZOTTO, 1985).<br />
Biologia. Emicriptofita scaposa, a rosette basali; fioritura<br />
da luglio a settembre.<br />
Numero cromosomico: 2n = 36.<br />
Ecologia. La popolazione di Cala di Portovecchio si<br />
presenta divisa in vari gruppi di individui riferibili a<br />
due principali tipi di vegetazione. I rilevamenti fitosociologici<br />
e le osservazioni effettuate nel 2006<br />
hanno messo in evidenza che L. etruscum può essere<br />
riferito a due tipologie vegetazionali. Il primo gruppo<br />
è localizzato in stazioni del livello topografico<br />
inferiore in aree raggiunte dalle mareggiate su substrato<br />
sabbioso, che rimane umido da ottobre a<br />
marzo e successivamente va incontro a evaporazione<br />
e in estate è ricoperto da uno strato di sale. In queste<br />
cenosi L. etruscum è accompagnato da specie quali<br />
Sporobolus pungens (Schreber) Kunth, Inula crithmoides<br />
L., Carex extensa Good., Parapholis filiformis<br />
(Roth) C.E. Hubb., Plantago coronopus L. Il secondo<br />
gruppo di individui è posizionato in aree arretrate<br />
rispetto alla battigia, ed occupa le radure all’interno<br />
della matrice dominata da Juncus acutus L. e Schoenus<br />
nigricans L.<br />
Distribuzione in Italia.<br />
Regione biogeografica: la specie ricade interamente nel<br />
Settore Toscano della Provincia Tirrenica (PEDROTTI,<br />
1996). Secondo ARRIGONI (1983) la specie ricade nel<br />
settore fitogeografico Mediterraneo centrale, settore<br />
Ligure-Tirrenico.<br />
Regione amministrativa: Toscana.<br />
Numero di stazioni: secondo ARRIGONI, RIZZOTTO<br />
(1985) la specie aveva in passato due poli di distribuzione:<br />
uno nella Palude di Talamone, l’altro nelle<br />
depressioni retrodunali a sud di Bocca d’Ombrone,<br />
da poco sotto la foce fino alla spiaggia di Collelungo.<br />
Già nel 1985 i due A.A. notavano che la popolazione<br />
della Palude di Talamone era scomparsa.<br />
Sopralluoghi successivi da noi effettuati a partire dal<br />
1999 fino ad oggi hanno confermato tale scomparsa:<br />
in effetti questa area è andata soggetta a notevoli<br />
cambiamenti dovuti sia ai lavori di bonifica che a<br />
nuove urbanizzazioni. Anche le popolazioni situate<br />
subito a sud di Bocca d’Ombrone sono scomparse a<br />
causa dell’erosione del litorale, che in questo tratto<br />
ha praticamente cancellato la spiaggia e le dune<br />
retrostanti ed ha fatto sì che il mare raggiungesse la<br />
pineta. In seguito a questa documentata riduzione di<br />
superficie occupata, l’Ente Parco, nel 1999-2000<br />
aveva anche promosso un tentativo di reintroduzione<br />
in una zona idonea a nord di Bocca d’Ombrone, che<br />
però non ha dato gli esiti sperati (Life/NAT).<br />
Attualmente la specie è ridotta alla sola popolazione<br />
di Porto Vecchio. Per la valutazione del suo stato di<br />
vulnerabilità sono stati adottati i criteri IUCN<br />
(2001, 2003, 2006).<br />
Per stimare la dimensione della popolazione è stato<br />
effettuato un conteggio dei ramet contenuti in plot di<br />
1x1 m individuati con campionamento randomizzato,<br />
ed è stato utilizzato lo stimatore di HORVITZ,<br />
THOMPSON (1952). Nonostante che dal punto di<br />
vista strettamente statistico il campionamento risulti<br />
sottodimensionato (ELZINGA et al., 1998; MCCUNE,<br />
GRACE, 2002), il risultato è più che sufficiente per<br />
ottenere il dato utile ai fini dell’assegnazione della<br />
categoria IUCN. Infatti il numero di individui<br />
(ramet) stimati è di gran lunga superiore a quello<br />
minimo previsto nelle Linee Guide IUCN del 2006;<br />
l’assegnazione di una eventuale categoria di rischio<br />
deve pertanto essere basata sull’areale di distribuzione<br />
o sulla superficie effettivamente occupata; l’AOO<br />
risulta di 1 km 2 (utilizzando una griglia di 1x1 km),<br />
mentre l’EOO misurato è pari a 20.044 m 2 .<br />
Tipo corologico e areale globale. Endemico, presente<br />
esclusivamente lungo le coste della Toscana meridionale.