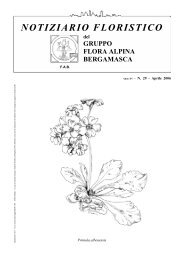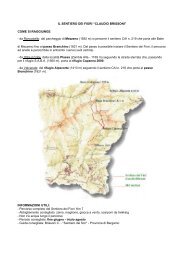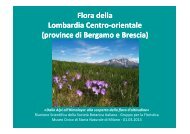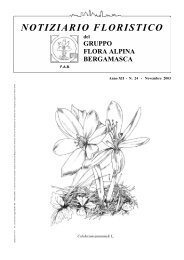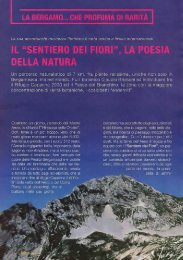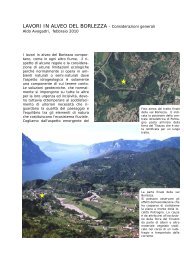IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
INFORMATORE BOTANICO ITALIANO, <strong>40</strong> SUPPL. 1, <strong>2008</strong><br />
<strong>Flora</strong> da conservare: implementazione delle categorie e dei criteri IUCN (2001) per la redazione di nuove Liste Rosse<br />
53<br />
Anchusa littorea Moris<br />
G. FENU e G. BACCHETTA<br />
Nomenclatura:<br />
Nome scientifico: Anchusa littorea Moris<br />
Sinonimi: Anchusa arvensis Moris; Anchusa crispa<br />
Moris; Anchusa crispa Viv. var. littorea (Moris)<br />
Illario<br />
Famiglia: Boraginaceae<br />
Nome comune: Buglossa litorale<br />
Descrizione. Pianta annua o più raramente bienne,<br />
debolmente ispida, (1,5)5-10(25) cm, eretta o con<br />
rami decombenti. Foglie lineari bislunghe, 4-12x1-<br />
1,5 cm, intere o leggermente sinuose, con peli e setole<br />
sul margine. Foglie inferiori ristrette in picciolo,<br />
foglie superiori e caulinari sessili. Infiorescenza lassa<br />
con fiori distribuiti lungo i rami, all’ascella delle<br />
foglie e al centro delle ramificazioni. Brattee lanceolate<br />
più lunghe del calice, simili alle foglie superiori,<br />
ciliate al margine. Calice fiorifero tubuloso, 5-6 mm,<br />
diviso sino alla metà e con lacinie lanceolate, acute.<br />
Peduncolo sottile. Calice fruttifero campanulato,<br />
rigonfio alla base e con lacinie piegate verso l’esterno.<br />
Peduncolo ricurvo. Corolla bianco-cerulea 7-9 mm,<br />
tubo 4-5 mm, lembo 3-4 mm. Squame ovali, piccole,<br />
ciliate. Antere lineari, 1,2-1,5 mm, inserite nella<br />
parte superiore del tubo, ma distanti dalle squame.<br />
Stilo eguale o più lungo del calice, stigma subtronco.<br />
Mericarpi di colore variabile dal bruno chiaro al grigio<br />
scuro, 0,5-1x1,5-2 mm, con un becco laterale e<br />
un anello basale sottile, superficie finemente e densamente<br />
tubercolata. (VALSECCHI, 1980, SELVI,<br />
BIGAZZI, 1998; BACCHETTA et al., <strong>2008</strong>).<br />
Biologia. Terofita o più raramente emicriptofita<br />
bienne, fiorisce da marzo a maggio con contemporanea<br />
maturazione dei frutti che si protrae fino a luglio<br />
inoltrato. Il frutto è una nucula trigona dotata di elasiosoma,<br />
la cui presenza indica un adattamento per<br />
una dispersione di tipo mirmecocoro. La biologia<br />
riproduttiva di questa specie ad oggi non è stata sufficientemente<br />
indagata. Anche se sull’unica popolazione<br />
attualmente conosciuta è stata osservata l’attività<br />
di alcuni insetti, si ritiene che l’auto-impollinazione<br />
autonoma sia il sistema riproduttivo principale.<br />
La dispersione del seme è effettuata principalmente<br />
dal vento e dalle formiche.<br />
Non si hanno, ad oggi, informazioni circa l’effettiva<br />
capacità germinativa e le temperature ottimali e cardinali<br />
di germinazione. Il numero cromosomico è<br />
2n=16, calcolato su materiale proveniente da S’Ena<br />
Arrubia, locus classicus in provincia di Oristano<br />
(VALSECCHI, 1976).<br />
Ecologia. Specie psammofila, caratteristica degli<br />
ambiti retrodunali (SELVI, BIGAZZI, 1998) dove vegeta<br />
in aree limitate, riparate dall’azione diretta del<br />
vento salmastro e retrostanti la fascia dell’ammofileto<br />
(VALSECCHI, 1980; CONTI et al., 1992). Dal<br />
punto di vista bioclimatico si ritrova in ambito<br />
Mediterraneo pluvistagionale oceanico, con termotipo<br />
termomediterraneo superiore e ombrotipo secco.<br />
L’unica popolazione attualmente conosciuta è distribuita<br />
su una superficie di circa 3000 m 2 (BACCHETTA<br />
et al., <strong>2008</strong>) ed è localizzata ai lati di un sentiero di<br />
accesso al mare, frequentato in tutte le stagioni. La<br />
popolazione appare costituita da diversi nuclei di<br />
individui localizzati ai margini del sentiero, al limite<br />
o nelle discontinuità del ginepreto a Juniperus oxycedrus<br />
L. subsp. macrocarpa (Sibth. et Sm.) Neirl. e in<br />
quelle aree dove è minore il calpestio e il disturbo,<br />
principalmente antropico. La specie si rinviene associata<br />
a numerose specie terofitiche quali Linaria flava<br />
(Poiret) Desf. subsp. sardoa (Sommier) Arrigoni,<br />
Phleum sardoum (Hackel) Hackel, Malcolmia ramosissima<br />
(Desf.) Thell., Tuberaria guttata (L.) Fourr.,<br />
Polycarpon alsinifolius (Biv.) DC. e Silene nummica<br />
Vals.<br />
Ancora non sono state descritte le cenosi alle quali<br />
partecipa A. littorea; in maniera del tutto provvisoria<br />
è comunque possibile ipotizzare che tale specie possa<br />
partecipare a fitocenosi appartenenti all’alleanza del<br />
Alkanno-Maresion nanae Rivas Goday 1957 ex Rivas<br />
Goday et Riv.-Mart. 1963 corr. Díez Garretas, Asensi<br />
et Riv.-Mart. 2001, che identifica l’habitat di interesse<br />
comunitario “Dune con prati dei Malcolmietalia”<br />
(2230).<br />
Distribuzione in Italia.<br />
Regione biogeografica: secondo la classificazione di